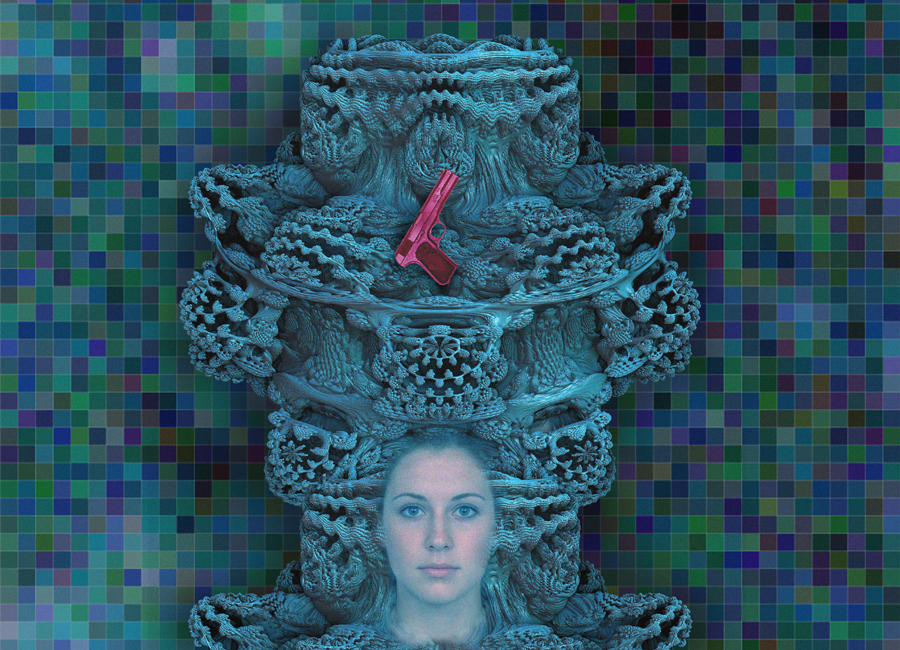Autore
Indice
- Introduzione
- Attraverso le lenti della medicalizzazione
- La solitudine degli universi unici
- Sacche di resistenza nella reificazione
- Per una politica del dolore
↓ download pdf
S&F_n. 26_2021
Abstract
Beyond medicalization: what’s left of pain
With the help of the ethnopsychiatric research led by Tobie Nathan and other fundamental anthropological insights, we want to analyze how the medical and psychological gaze shapes our understanding and narration of pain and death. Specifically, our purpose is to highlight how the medicalization of discourse took away the possibility for the pain to say something crucial for the subject and society, isolating the individuals who suffer, thus preventing the possibility of reflecting and changing the status quo.
In “The Myth of Sisyphus” (1942),
Albert Camus famously declares,
“There is but one truly serious
philosophical problem,
and that is suicide.”
Seventy years later,
everyone knows that suicide
is a psychiatric emergency,
not a philosophical problem.
Thomas Szasz, Suicide Prohibition, 2007
- Introduzione
Insieme, lui e io avremmo potuto definire e affinare la comprensione che, in pratica, “insopportabile” e “intollerabile” significano in realtà appena sopportabile e in qualche modo tollerabile, e che questi termini possono essere incorporati in un rigoroso modello per la sopravvivenza. Magari sarebbe riuscito a fare quello che l'imperatore Hirohito ordinò al suo popolo sopraffatto alla fine della Seconda guerra mondiale: soffrire l'insoffribile e sopportare l'insopportabile – e vivere[1].
Queste parole provengono da una lettera scritta da Edwin Shneidman alla madre di un uomo morto suicida. Qui, il suicidologo cerca di spiegare quanto la volontà suicidaria sia qualcosa di articolato e complesso, tentando di alternare comprensione verso la sofferenza del figlio e legittimazione dei sentimenti contrastanti della destinataria. È evidente in queste parole la persuasione di fondo – affatto singolare nella weltanschauung occidentale – che non esista un dolore tanto grande da giustificare la fine di una vita[2]. L’idea, in altre parole, che il dolore possa essere sempre, se non superato, quantomeno gestito, reso malleabile dalla potenza del conatus che ci lega alla vita su questa terra.
Volendo analizzare gli effetti di senso più diffusi che portano il dolore e la morte come propri significanti all’interno del discorso contemporaneo, individuiamo due linee di pensiero solo apparentemente contrastanti: la constatazione amara dell’atteggiamento evitante che rimuove dai discorsi ogni accenno alla finitezza, sottolineando la perdita che questo evitamento comporta nella vita dell’individuo[3] – la possibilità di dare significato, prospettiva e insegnamento[4]; e la convinzione che la vita sia qualcosa da preservare nella sua massima potenzialità. È quest’ultima visione a informare il procedere medico-tecnologico che contribuisce grandemente alla progressiva obliazione del perituro che la prima rifiuta, eppure questi due effetti di senso si compenetrano e concausano senza nessun reale contrasto.
D’altro canto, se l’unico ruolo che riusciamo a immaginare per la morte e il dolore è quello di servire la vita, è evidente che questa ha la precedenza e che ai primi attribuiamo una funzione sussidiaria: si tenterà quindi di confinarli con ogni mezzo[5], proprio come cerca di fare il progresso medico-tecnologico. Non potendo scomparire dal nostro immaginario, tuttavia, la morte e il dolore troveranno casa nel “rimosso”, quella risacca tutta occidentale dove vanno a finire quei concetti scomodi che rimossi del tutto non lo saranno mai, che finiscono con l’abitare l’intermezzo schizofrenico del ricordo e della dimenticanza: dimenticanza magnificata dal progresso medico ed economico dei paesi occidentali, e ricordo narcotizzato fintantoché non irrompe nel fluire delle vite.
Psicologia e psichiatria, le istituzioni che si fanno carico del dolore psicologico nella società secolarizzata, svolgono questo compito attraverso una modalità di pensare l’esistenza e il dolore plasmata dalla grammatica del pensiero scientifico e medico, un pensiero che guarda la vita attraverso specifiche lenti, che fatica a considerare la morte e che ha un modo peculiare di significare il dolore.
Nella lettera scritta da Shneidman possiamo facilmente cogliere un primo aspetto di questa modalità: la direzione della domanda. Di fronte all’enormità del dolore di un suicida, lo psicologo prende come oggetti dell’interrogazione la morte e il dolore, per spiegarli attraverso il presupposto valore della vita[6]. Invertire il corso di questa ricerca, interrogando la vita attraverso lo sguardo del dolore e della fine, significa tuttavia porsi quesiti fondamentali: qual è il senso del dolore nelle nostre vite, e che uso – se un uso esiste, e se di uso si può parlare – possiamo fare di questo confine che ci divide così precariamente dalla percezione della finitezza?
- Attraverso le lenti della medicalizzazione
Thomas Szasz, psichiatra vicino alle posizioni dell’antipsichiatria, illustra in modo molto chiaro il processo sociologico che chiamiamo medicalizzazione[7]:
Prima, le persone si sentivano depresse o erano depresse. Adesso hanno la depressione. Prima, alcune persone depresse finivano per uccidersi, ma la maggior parte di loro non lo faceva. Adesso le persone non si uccidono, è la depressione a ucciderle, e (virtualmente) chiunque si uccida lo ha fatto perché depresso[8].
La medicalizzazione è quel fenomeno sociale che impone la griglia concettuale del sapere medico e psicologico come lente privilegiata di lettura di tutti i fenomeni che concernono l’uomo. Aggiunge, in altre parole, un passaggio nell’interpretazione delle difficoltà sociali e individuali: tra soggetto e mondo si inserisce la spiegazione medica della difficoltà. Nessun malessere può esser veramente compreso senza questo passaggio esplicativo, che talvolta può risultare sufficiente da solo. Riflettendo sul suicidio, Karl Jaspers metteva in guardia rispetto alle problematiche di questo tipo di interpretazione del disagio: «la via più semplice e comoda sembra sia quella di attenersi per il suicidio all’ipotesi della malattia mentale […] Il problema viene così sbrigativamente risolto, essendo collocato al di fuori del mondo normale, ma non è così»[9].
La morte e il dolore rappresentano, nella nostra costellazione antropologica, le due massime presentificazioni dell’alterità: se la morte è quell’Altro talmente Altro da sfuggire ogni tentativo di interpretazione e di rappresentazione[10], il dolore è il principio di corruzione che si insinua nel soggetto integro e vitale. Il dolore psichico profondo, quando mette in dubbio il valore della vita, si sporge oltre una frontiera inesplorata. Può davvero esistere una sofferenza esistenziale che non si qualifichi come una tipologia di depressione? Esiste veramente un suicidio razionale, compiuto consapevolmente e non in preda a una malattia mentale che impedisce al soggetto di scorgere le possibilità alternative? Queste sono le domande che aleggiano da sempre intorno lo studio del soggetto psicologico sofferente.
Per ottenere diritto di cittadinanza nel discorso sociale e istituzionale la sofferenza mentale è passata attraverso il vaglio del sapere medico, da quella distinzione tra normale e patologico che sappiamo, con Foucault[11] e Canguilhem[12], informa surrettiziamente tutto il sapere occidentale. In questo modo le diverse sofferenze vengono misurate e vagliate attraverso le griglie categoriali della biomedicina e dei diversi approcci psicologici.
Nella Storia della follia Foucault[13] descrive in che modo il malato mentale perde quello che gli epistemologi sociali chiamano oggi potere testimoniale: la possibilità di parlare per se stessi e di essere ritenuti interlocutori affidabili. Durante il XIX secolo è in atto quella che il filosofo chiama “medicalizzazione della follia”, fenomeno che ruota principalmente attorno allo sviluppo di una fondamentale asimmetria nel rapporto tra medico e malato. Il contesto del manicomio contribuisce infatti a formare uno sguardo medico la cui caratteristica principale è la non reciprocità con lo sguardo del malato. Se questo non viene più sottoposto a misure punitive, come accadeva in passato, viene tuttavia osservato, analizzato e indagato nel profondo, alla stregua dei cadaveri di Bichat. L’interrogazione del medico è volta alla separazione chirurgica di tutto ciò che impedisce l’osservazione precisa e compiuta del nucleo patologico del paziente.
- La solitudine degli universi unici
Per comprendere più a fondo questa modalità tutta occidentale d’intendere il dolore, l’etnopsichiatra Tobie Nathan[14] racconta come questo viene trattato nelle società “a universo multiplo”. La malattia in queste società viene spiegata attraverso l’incontro tra l’universo terreno e uno degli universi alternativi codificati dalla propria cultura. Una persona sofferente potrebbe, ad esempio, aver ricevuto il malocchio da parte di un famigliare, oppure potrebbe esser posseduta da uno spirito. Il malato, in questo caso, è considerato il vero esperto sulla natura della propria sofferenza, perché è lui stesso a essere entrato in contatto con l’universo invisibile. Può non conoscerne la causa, e per questo motivo si rivolgerà a uno sciamano o un guaritore, ma questi non potranno mai rivendicare un accesso privilegiato alla verità della sua condizione, che è anche, se non fondamentalmente, la verità di un mondo di invisibili la cui conoscenza è importante per tutta la comunità.
Manca quel livello di delegittimazione di cui Foucault descrive la strutturazione nella Storia della follia: quel presupposto della nostra ragione medica per cui lo sconfinamento verso la sofferenza non può che renderci meno affidabili, più lontani dalla razionalità salda che fonda la nostra idea di soggetto con potere testimoniale. Parte di questa razionalità la possiamo trovare nelle parole di Shneidman che aprono questo testo, in quella persuasione che vede il dolore come qualcosa di soggettivamente disfunzionale, che pertanto va affrontato, gestito ed eroicamente superato. All’interpretazione erronea che il suicida fa del proprio dolore viene quindi contrapposta quella razionale dello sguardo medico e psicologico.
I postulati che orientano le psicoterapie sono, secondo Nathan, costituiti da due punti cruciali: il dolore, la follia e la sragione sono sempre patologici, e tutte le patologie risiedono nel soggetto. Questi postulati diventano chiari dal momento in cui Nathan fa l’esempio di una donna che sviene: nella nostra società a universo unico penseremo certamente che questa donna soffra di un disturbo appartenente al reame del conoscibile. Lo sguardo posato su questa donna farà di lei un personaggio semplificato, quasi regredito: la si potrà compatire o la si potrà incolpare, la si potrà guidare e anche aiutare, sostiene Nathan, ma in ogni caso questa donna resterà tendenzialmente sola, il suo dolore non sarà occasione di conoscenza e di messa in moto della comunità.
In una società a universo multiplo, invece, si ipotizzerà che uno spirito si sia impadronito della donna e, quindi, diventerà indispensabile ricorrere alla figura che si occupa di questi spiriti. La donna diventerà necessariamente l’informatrice involontaria di quel mondo invisibile con cui è entrata in contatto. Così il disturbo sarà utile all’intero gruppo perché contribuirà a rendere complesso il mondo e a informarsi sui suoi invisibili, con ricadute fondamentali nella gestione dei rapporti del gruppo, non diversamente da come riportava Victor Turner rispetto alle pratiche di cura Ndembu:
Sembra che il “dottore” Ndembu identifichi il proprio compito più con la riparazione dei mali di una collettività che con la cura di un singolo paziente. La malattia è essenzialmente il segno che “c'è qualcosa di marcio” nella vita del gruppo. Il paziente non migliorerà finché tutte le tensioni e le aggressività nei rapporti di gruppo non saranno state portate alla luce e sottoposte al trattamento rituale[15].
Se nella psicoterapia scientifica il paziente viene inserito in un protocollo di cura che sostanzialmente lo isola dal resto della comunità – e separa la sua sofferenza dalle responsabilità comunitarie e sociali, confinandola nelle problematiche inerenti il proprio vissuto individuale – nelle società a universo multiplo, il soggetto mette in atto una serie di dinamiche – la prima è appunto il coinvolgimento di un curatore – che quella comunità la interpellano e la modificano.
In definitiva, per quanto sia chiaro che non si possano veramente commensurare questi due sguardi culturali, le riflessioni di Nathan ci permettono di scorgere dei presupposti come, nella nostra cultura, il dolore rischi di perdere la propria costituzione epistemica e agentiva. Il pericolo nascosto nella dichiarazione della propria sofferenza è pertanto significativo, perché l’aiuto passerà da un esame e da una categorizzazione, ma anche da una perdita di potere epistemico su quel sapere complesso che è il proprio dolore raccontato[16]. In nessuna parte di questo processo il soggetto troverà un aggancio con la propria comunità, perché nel nostro universo unico niente è meno di interesse collettivo di un disturbo, una depressione, un pensiero ossessivo. I nostri sofferenti sono soli, perché il loro dolore riguarda solo loro stessi: l’unico modo che hanno per tornare nella comunità è dimostrare di esser “guariti” il prima possibile.
- Sacche di resistenza nella reificazione
In un articolo del 1980 Michael Taussig[17], antropologo e medico, riprende la teoria di György Lukács della reificazione e dell’oggettivazione del mondo per illustrare, attraverso l’analisi etnografica, come questo processo si manifesti nel dominio del patologico. La biomedicina occidentale, secondo l’antropologo, è parte integrante dell’apparato ideologico dell’ordine sociale, e le sue pratiche reificano i segni, le esperienze e gli esiti delle scelte umane interpretandoli come fatti desocializzati di natura. Conformandosi anch’esso alle necessità di produzione della merce, il patologico finisce quindi col produrre esseri umani oggettivati e destoricizzati. «Secondo Taussig, non è un caso che la malattia sia divenuta un punto focale della pratica ideologica. Una grave malattia interrompe la routine quotidiana e l'accettazione più o meno acritica della vita» commenta Allan Young[18]. Il patologico forgia un accesso privilegiato sul corpo e la mente del paziente, ed è a questo punto che il clinico occidentale diventa lo strumento perfetto per il controllo sociale e agente di specifici interessi di classe. La malattia diviene così un “tradimento intrasomatico”, e il malato viene trasformato da «soggetto della propria storia a oggetto passivo di una scienza medica ostentatamente benevola»[19].
Sebbene la reificazione del patologico sembri spogliare completamente il dolore del proprio potere agentivo, Nancy Scheper Hughes e Margaret Lock suggeriscono, riprendendo le teorie sulla resistenza di James Scott, che le identificazioni e significazioni offerte dalla scienza medica possano venir utilizzate come modalità di rifiuto o di protesta silenziosa delle classi subalterne. Secondo Scott[20] la resistenza dei subalterni va colta nelle piccole forme di resistenza quotidiana, in piccoli atti di sabotaggio e in forme di costume e cultura come la satira, le canzoni e le storie. In questo senso, si può pensare lo spazio clinico della malattia oggettivata come «uno spazio dal quale comunicare paura, ansia e rabbia, perché in nessuno dei due casi [la trance e la malattia] gli individui che si trovano in circostanze normali sono ritenuti pienamente responsabili della loro condizione»[21].
Si viene a creare quindi un circuito vizioso: la reificazione sottesa al pensiero medico guarda al dolore come un’occorrenza soggettiva, sradicata dalle condizioni sociali e storiche in cui esso è collocato. La perdita di potere testimoniale che ne deriva viene quindi utilizzata dai subalterni come modalità di resistenza passiva rispetto alle ingiustizie sociali patite. Più il pensiero medico si popolarizza creando effetti di senso nel discorso pubblico, più assistiamo al processo della medicalizzazione della vita quotidiana di cui parla Szasz, nella quale i soggetti ricercano identificazioni psicopatologiche per legittimare i propri bisogni, sofferenze e difficoltà.
Ciò che rende questo circuito vizioso, è che le suddette pratiche di resistenza concedono un sollievo unicamente individuale, adoperando gli stessi strumenti di un’istituzione che è parte fondamentale di quel sistema iniquo che spesso crea per primo le condizioni per la sofferenza e l’infelicità.
Con le parole di Mark Fisher, il disagio e la sofferenza sociale vengono privatizzati[22], contribuendo alla persuasione collettiva che sia impossibile pensare una società diversa, in grado di distribuire non solo le risorse, ma anche il benessere psicofisico. Che si possa vivere unicamente in una società come questa – è questo il realismo capitalista teorizzato da Fisher –, nella quale un soggetto sano è un soggetto adattato, un soggetto in grado di sopportare l’insopportabile, e, sostanzialmente, per parafrasare lo psichiatra Piero Cipriano, un soggetto che sa lavorare[23].
- Per una politica del dolore
L’uso massivo e sempre più diffuso del linguaggio medicalizzato all’interno della vita quotidiana può quindi esser letto come una prova sufficiente che il dolore, lungi dall’esser meno presente, è massivamente tradotto entro le spiegazioni riduzionistiche della biomedicina, che forniscono nuove modalità socialmente adeguate a riferirsi alla propria sofferenza. Il dolore, tuttavia, prima che patologia, è un sapere, una finestra aperta sulle diverse manifestazioni della condizione umana. Se le pratiche discorsive vengono pervase da diagnosi – ansia, depressione, funzionamenti neurologici – si impedisce a questo sapere di dispiegarsi e trovare forme di legittimazione che non siano una deresponsabilizzazione meccanicistica.
La retorica eroica della sofferenza che leggiamo in controluce nelle parole di Shneidman è l’involontaria ammissione che esiste un buco di conoscenza, un’incapacità di comprendere come il dolore possa valicare il confine di pensabilità che ci protegge dalla figurazione della fine. Quelle parole ci dicono molto di più sullo sguardo di chi le scrive che sul dolore che vorrebbero spiegare: rappresentano un allontanamento preventivo dalla possibilità che la vita non abbia un valore in sé, che possa tradursi in vuota sopravvivenza.
Uscire dall’ingenuità algofobica propria del pensiero medicalizzato significa in prima istanza riconoscere al dolore il proprio statuto epistemico, statuto che ha la potenza narrativa e agentiva di mettere in crisi lo status quo. Il dolore, la morte, la caducità, sono gli unici aspetti che orizzontalmente coinvolgono tutti: possono quindi servire da cassa di risonanza delle sofferenze degli ultimissimi, degli ultimi ma anche dei penultimi, di quella classe media che tende all’anestesia delle vulnerabilità, abituata a pensare al malessere come prezzo necessario da pagare per una felicità che sfugge, si allontana, ma che arriverà, basta lavorare – e lavorarci.
[1] E.S. Shneidman, Autopsy of a suicidal mind, Oxford University Press, New York 2004, p. 163. La traduzione è nostra.
[2] Cfr. T. Szasz, Suicide prohibition: the shame of medicine, Syracuse University Press, Syracuse 2007.
[3] Per una trattazione filosofica di questo argomento, cfr. B.-C. Han, La società senza dolore (2020), tr. it. Einaudi, Torino 2021.
[4] Cfr. E. Severino, in I. Testoni, L’ultima nascita: psicologia del morire e death education, Bollati Boringhieri, Torino 2015, pp. IX-XII.
[5] Anche giuridico, come argomenta Thomas Szasz in T. Szasz, op. cit., pp. IX-XIII.
[6] Ibid., pp. 95-103.
[7] Cfr. P. Conrad, The medicalization of society: on the transformation of human conditions into treatable disorders, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2007.
[8] T. Szasz, The medicalization of everyday life, Syracuse University Press, Syracuse 2007, p. xxv. La traduzione è nostra.
[9] K. Jaspers, La mia filosofia (1941), tr. it. Einaudi, Torino 1971.
[10] Cfr. S. Freud, Considerazioni attuali sulla guerra e la morte (1915), tr. it. Newton Compton, Roma 1976, pp. 16-43.
[11] Cfr. M. Foucault, Nascita della clinica (1963), tr. it. Centauria, Milano 2018.
[12] Cfr. G. Canguilhem, Il normale e il patologico (1966), tr. it. Einaudi, Torino 1996.
[13] Cfr. M. Foucault, Storia della follia nell’età classica (1961), tr. it. BUR, Milano 2011.
[14] Cfr. T. Nathan, I. Stengers, Medici e Stregoni (1996), tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 2017.
[15] V. Turner, Un medico Ndembu al lavoro (1967), in Id., La foresta dei simboli: aspetti del rituale Ndembu, tr. it. Morcelliana, Brescia 1976.
[16] Cfr. P. Crichton, H. Carel, I.J. Kidd, Epistemic injustice in psychiatry, in «Psychiatry», 41 (2), 2016, pp. 65-70.
[17] Cfr. M. Taussig, Reificazione e coscienza del paziente (1980), in I. Quaranta, Antropologia Medica: i testi fondamentali, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006, p. 184.
[18] A. Young, Antropologie della “ilness” e della “sickness” (1982), in I. Quaranta, op. cit., p. 131.
[19] Ibid., p. 130.
[20] Cfr. J. Scott, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts, Yale University Press, New Haven 1990.
[21] M. Lock, N.S. Hughes, Un approccio critico interpretativo in antropologia medica (1990), in I. Quaranta, op. cit., p. 184.
[22] Cfr. M. Fisher, The privatization of stress, in «Soundings», 48, 2011, pp. 123-133.
[23] P. Cipriano, La società dei devianti, Elèuthera, Milano 2016, p. 15.