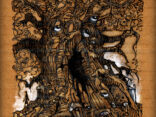Autore
Indice
- Alle origini della riflessione. Il viaggio intersiderale come desiderio dell’altrimenti
- La tecnica verso l’indipendenza dal luogo
- Tecnica, volto e disincanto
- Sviluppo tecnico, uomo e natura tra Lévinas e Heidegger
S&F_n. 15_2016
Abstract
Gagarin on Abraham’s Trail. The Question concerning Technology in Emmanuel Lévinas’s Work
Lévinas takes Jurij Gagarin’s space enterprise as a starting point to analyze the issue of technique and its consequences for the human. The importance of technical development, that is what it has in common with Judaism, resides in its ability to release man from the violence of enrootedness in the soil. In definite contrast to the anti-modernist heideggerian position, Lévinas thinks of the technique as a disembodiment from the paganism, hiding in exaltation of the rural landscape. Thanks to its demystifying essence, technology becomes a way of thinking about the ethics, outside the traditional ontological paradigm.
- Alle origini della riflessione. Il viaggio intersiderale come desiderio dell’altrimenti
«Cosmonauta Gagarin non voltarti indietro». Singolare come il titolo di una canzone dei nostri tempi riesca a rievocare il senso di quella tensione alla trascendenza che, agli occhi di Emmanuel Lévinas, segna il volo di Jurij Gagarin nello spazio. Sì, perché quello dell’astronauta russo è un viaggio verso l’altrove senza alcuna nostalgia del ritorno. Non si tratta dell’eroica avventura di un Ulisse moderno che, nella circolarità di un movimento totalizzante, parte per riapprodare alla sua terra natìa e riaffermare, così, la propria identità. Nell’esperienza di Gagarin vive, piuttosto, il senso di una destituzione, di un’inquietudine che scuote l’io nella sua immobilità e lo conduce alla via del «non riposo in sé». È l’evento concreto del dis-astro: «né morte né disgrazia», spiega Lévinas, «ma come dell’essere che si sarebbe staccato dalla sua fissità di essere, dal suo riferimento a una stella, da ogni esistenza cosmologica»[1].
Espulso dalla «quiete del consueto» e dalle garanzie del familiare, quell’uomo di sofoclea memoria[2], di cui «nulla di più inquietante s’aderge»[3], proprio quando si illude di aver domato persino «la più sublime delle divinità», «l’indistruttibile infaticabile» che è la terra, si ritrova, tuttavia, a dover deporre le armi: sfumano, nello spazio, le incontrovertibili certezze del Medesimo.
È il 12 aprile del 1961 quando Gagarin, come un Abramo, lascia la casa del padre verso l’ignoto ma, in questo caso, nessun ordine divino: «non c’è nessun Dio quassù» avrebbe detto l’astronauta di ritorno dallo spazio. L’accostamento azzardato sembra trovare la sua legittimazione nelle parole di Lévinas che, in Heidegger, Gagarin e noi[4], elabora, in un sorprendente dialogo con il giudaismo, un’originale riflessione sulla questione della tecnica. Sullo sfondo, l’esigenza di un’atopia, come modo di espulsione dal luogo, risponde, in una prospettiva marcatamente anti-heideggeriana, all’emergenza di una liberazione dal tradizionale asservimento al dominio dell’essere. Il viaggio intersiderale del ’61 assume, per Lévinas, un significato che trascende l’elogio di un’ammirevole prestazione: nel volo dell’astronauta «conta anzitutto la possibile apertura su nuove conoscenze e nuove possibilità tecniche […] ma, sopra ogni altra cosa, conta aver abbandonato lo Spazio. Per un’ora un uomo è vissuto al di fuori di ogni orizzonte: intorno a lui tutto era cielo o, più esattamente, tutto era spazio geometrico. Un uomo ha vissuto nell’assoluto dello spazio omogeneo»[5]. Allontanarsi dalla stabilità della posizione, non occupare nessun suolo: è così che Gagarin ha potuto restare sospeso nella trama di quel «no man’s land» che, luogo non-luogo, a metà strada tra l’essere e il non-ancora essere, rappresenta, per Lévinas, il presupposto imprescindibile per pensare altrimenti rispetto al dramma dell’incatenamento.
- La tecnica verso l’indipendenza dal luogo
Decisiva messa in discussione del «privilegio del radicamento»[6], lo sviluppo tecnologico rivela, da questo punto di vista, una sostanziale prossimità al senso più profondo del giudaismo e alla sua estrema libertà rispetto agli spazi. Quando la scaturigine di ogni barbarie risiede, per citare Pascal, nell’affermazione: «Il mio posto al sole è là»[7], la «Bibbia», scrive Lévinas, «conosce solo una Terra Santa: terra favolosa che rigetta gli ingiusti ed in cui non è possibile radicarsi…»[8].
Dietro l’urgenza di una liberazione dal luogo, i traumatici eventi che hanno segnato il destino del popolo ebraico, testimoniano di un’apolidia come imprescindibile presupposto etico: «La condizione – o l’incondizione – di stranieri e di schiavi nel paese d’Egitto avvicina l’uomo al suo prossimo. Gli uomini si cercano l’un l’altro nell’incondizione di stranieri. Nessuno è a casa propria»[9].
La terra o la sua assenza: non è forse a partire da qui – si chiede Lévinas – che si dispiega il ruolo salvifico del progresso tecnologico? Concepita al di fuori del suo carattere meramente strumentale, la tecnica, come il giudaismo, si fa garante di una possibilità che racchiude l’essenza stessa dell’etica: «Percepire gli uomini al di fuori della situazione in cui sono immersi»[10], scardinare i presupposti di quella perseveranza nell’essere, di cui la brutalità del radicamento porta l’inestinguibile traccia. È solo in virtù di questa «tregua» dall’anonimato dell’elementale e di questa tensione verso l’indipendenza dal luogo, che può consumarsi, infatti, la disfatta dell’ontologia, condizione necessaria affinché la relazione inter-umana, in concreto, accada.
Come l’uomo ebreo, prima di scoprire paesaggi e città[11], si rivolge già all’altro da sé, così, l’uomo della moderna tecnica, estraneo a qualsiasi inclinazione alla situatività, incontra Altri al di là dei vincoli che le radici impongono. Nessuna apologia dell’esilio: quella del nomadismo è una scelta che, con l’esistenza sedentaria, condivide la medesima incapacità di evasione «da un paesaggio o da un clima»[12].
- Tecnica, volto e disincanto
A rendersi necessaria, è, piuttosto, una definitiva liberazione da quell’aderenza alle «superstizioni dello Spazio», dietro la quale si nasconderebbe la tragica frattura dell’umanità in autoctoni e stranieri. È proprio in virtù delle sua essenza demistificatrice, che lo sviluppo tecnologico, nell’interpretazione levinasiana, pare spogliarsi di ogni potenzialità distruttiva, per offrire le condizioni stesse affinché questa spaccatura possa rimarginarsi e «il volto dell’uomo brilli nella sua nudità»[13]. La tecnica come possibilità che l’epifania del volto d’Altri accada. In questa apparente dissonanza, c’è tutta l’armonia di un dialogo, che trova la sua giustificazione nell’approccio disincantato di Lévinas al religioso. Epurata del suo carattere oracolare, la religione perde la sua inclinazione all’intangibilità per farsi, a partire dalla concretezza dell’incontro con Altri, verità incarnata, pensiero in azione. In un contesto in cui la ricerca della trascendenza, pur nella sua «ulteriorità», non perde mai di vista lo «scenario umano»[14], l’analisi di Lévinas appare dominata da un’essenziale inclinazione alla secolarizzazione. Ecco come, a un tratto, tecnica, etica e spirito religioso, si allineano nello spazio di una mutua convivenza:
La tecnica […] è distruttrice degli dei pagani. Grazie ad essa alcuni dei sono morti: dei della congiunzione astrologica e del fatum, dei locali, dei del luogo e del paesaggio, tutti dei che abitano la coscienza e che raddoppiano, nell’angoscia e nel terrore, gli dei dei cieli. La tecnica ci insegna che tali dei appartengono al mondo, e che quindi sono delle cose, ed essendo delle cose non sono grancosa[15].
È con queste parole che, in uno dei suoi corsi su Dio, la morte e il tempo, Lévinas insiste sull’effetto di disincanto che la tecnica, in quanto profonda erosione dell’universo degli dei pagani, sembra poter produrre. Attraverso un sostanziale affrancamento dai pericoli che l’«eterna seduzione del paganesimo»[16] serba in sé, lo sviluppo della tecnologia salva l’umano dal carattere «untuoso», che impregna ogni forma di mistificazione.
È significativo notare l’assonanza di intenti che lega, per certi versi, quest’analisi con l’interpretazione del Don Chisciotte. Come la fame, «grande franchezza della materia»[17], libera il Chisciotte dalla certezza dell’incantesimo in cui è imprigionato, la tecnica, nello squarcio inferto alla solidità dei falsi miti, svela tutta la fragilità del «sacro che filtra attraverso il mondo»[18].
A partire da situazioni differenti, ma altrettanto concrete, si rende possibile quell’incontro con Altri, che è la condizione d’accesso privilegiata, affinché la via di una «trascendenza non ontologica»[19] venga tracciata. Fame e tecnica: in entrambi i casi, la secolarizzazione come conditio sine qua non dell’eticità. Al Dasein di Heidegger che «non ha mai fame»[20], Lévinas indica, attraverso l’esempio del Chisciotte, l’eventualità di un faccia a faccia che accade proprio nello spazio dell’«ultramaterialità» di un bisogno. In mezzo ai campi della Foresta Nera in cui ci sono solo alberi e «non si incontrano uomini»[21], il filosofo traccia, attraverso la tecnica, il sentiero che conduce al santo.
Dal sacro al santo, dunque. Dalla fascinazione di un paesaggio, alla morte di quel «certo Dio che abita dietro-ai-mondi»[22], dalla penombra dei «boschetti sacri» alla luce di ciò che, nell’assoluta separazione, brilla nella sua purezza. L’intenzione sottesa alla riflessione levinasiana sulla tecnica è tutta qui, nelle coordinate di questo cammino, orientato a circoscrivere il potere della magia, che si insinua nel mistero delle cose, nel «“finta di niente” degli oggetti quotidiani»[23], nella «curiosità che si manifesta là dove si devono abbassare gli occhi»[24]. A quell’«impuro armeggio della magia»[25] che, penetrato nel mondo moderno, legittima le pericolose apparenze del vero e le illusioni di una «vita invasa dalle scorie della vita»[26], la tecnica risponde con la più elevata forma di desacralizzazione: l’emancipazione dell’umano dall’«impersonale fecondità» della terra.
Di fronte alle esitazioni post-belliche dei più, di cui si moltiplicano gli interrogativi sull’amoralità del crescente sviluppo tecnologico, è singolare come in Lévinas, diretto testimone di una prigionia di guerra durata circa cinque anni, la questione della tecnica divenga possibilità concreta di ripensare al senso al di fuori delle violente «ragioni dell’essere», che si celano nelle nostalgie del paesaggio. Non si tratta di sottovalutare, in una sorta di idilliaca fiducia, la minaccia che l’infernale «ingranaggio [..] in cui girano esseri e cose»[27] comporta per l’identità umana. «C’è del vero», ammette Lévinas, «nella dichiarazione: la tecnica è pericolosa»[28], per poi ribadire, altrove: «Nessuno è così folle da misconoscere le contraddizioni della tecnica»[29]. Ma non c’è traccia, in quest’analisi, di quella «comoda retorica» che, proprio attraverso i moderni mezzi di comunicazione, grida il suo dissenso al progresso e si abbandona alle false consolazioni, che il panorama rurale promette.
- Sviluppo tecnico, uomo e natura tra Lévinas e Heidegger
«Perdonami, mio ottimo amico. Amo imparare, ma i campi e gli alberi non vogliono insegnarmi niente…»[30]. Così Socrate, interrogato da Fedro, giustificava la sua riluttanza ad allontanarsi dalla città di Atene. Così Lévinas, erede del messaggio socratico, risponderebbe all’inurbano Heidegger, genio dello Spazio[31] che, in quella «madre generosa senza volto»[32] della terra, scopre la traccia dei «poteri pre-tecnici» del luogo sull’uomo: è «solo nella misura in cui l’uomo è già, da parte sua, pro-vocato a mettere allo scoperto (herausfördern) le energie della natura»[33], che il disvelamento insito all’essenza della tecnica moderna può dispiegarsi.
Ancora una volta, non è in discussione il problema del progresso delle macchine e dei pericoli sottesi alle facilitazioni che comportano. Nell’analisi di Heidegger ciò che è in gioco è l’illusione antropocentrica che l’im-posizione destinale provvede già a sgretolare: «L’essere nel mondo heideggeriano», scrive in merito Lévinas, «è comprensione: la stessa attività tecnica è apertura, s-coperta dell’essere fosse anche secondo la modalità dell’oblio-dell’essere. L’ontico […] cede ovunque il passo all’ontologico, ad una luminosità nascosta da liberare […]»[34]. Tutto accade nell’intrigo del già dato e, nella priorità conferita al mondo, l’anti-progressismo di Heidegger svela la tragicità delle sue ispirazioni antiumanistiche. Coltivare, edificare, costruire: per quanto il Dasein si affaccendi, «se vado verso l’uscita di questa sala, è perché ci sono già, e non potrei andarvi se non fossi così fatto che sono già là»[35].
Modo del «soggiornare sulla terra», l’attività tecnica confermerebbe, dunque, l’impossibilità di svincolarsi dalla propria situazione, dalla contingenza alla quale, «guardiano dell’Essere»[36], l’uomo è già da sempre assegnato. Ma, controbatte Lévinas:
Le cose non sono […] il fondamento del luogo, la quintessenza di tutte le relazioni che costituiscono la nostra presenza sulla terra (e “sotto il cielo, in compagnia degli uomini e nell’attesa degli dei”). Il rapporto del Medesimo con l’Altro, la mia accoglienza dell’Altro è il fatto decisivo in cui vengono alla luce le cose non come ciò che si edifica ma come ciò che si dona[37].
Sebbene le pretese soggettivistiche di un io, che si vorrebbe scaturigine di ogni senso, vengano sradicate dall’analisi heideggeriana, nuovi pericoli si insinuano, proprio laddove si consuma la disfatta dell’antropocentrismo tecnico. Con estrema lucidità, Lévinas ne definisce i contorni. Attraverso la subordinazione di ogni relazione con l’ente alla relazione con l’essere dell’ente, quella di Heidegger diviene una «filosofia dell’ingiustizia»[38], che giustifica il potere e pensa la relazione etica come «ciò che si svolge nel destino dei popoli a dimora stabile, possessori e costruttori della terra»[39]. Ma è proprio qui che la questione della tecnica si impregna di motivazioni etico-politiche e segna lo scarto incolmabile tra Lévinas e Heidegger.
«Être rivé».
In Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo[40], così Lévinas definiva l’essenza di quell’inchiodamento che, legittimato dall’«ontologia dell’essere che ha cura d’essere», sarebbe all’origine dell’ideologia nazionalsocialista.
Nelle sue ispirazioni antimoderniste, la riflessione di Heidegger, vera e propria «ontologia della natura», finisce per ricondurre ogni significato all’ordine di quei «sentimenti elementari», sul cui atroce risveglio, la filosofia dell’hitlerismo ha posto le proprie fondamenta. Solida testimonianza dell’aderenza dell’io al suolo, l’analisi heideggeriana si muove, così, nella dimensione di una biologia, divenuta, pericolosamente, genesi della spiritualità. La «voce misteriosa del sangue» e i richiami della terra materna divengono lo scenario privilegiato di un dramma nel quale l’uomo, schiacciato dal peso della sua esistenza, si ritrova attore non protagonista.
Ciò che ne consegue, dal punto di vista di Lévinas, è una temibile approvazione delle «oscure potenze», che regnano in seno al passato e alla sua irrevocabile eredità. In questo senso, se il costruire un ponte, il plasmare una brocca, l’edificare una casa, sono, per Heidegger, tutti modi del lasciar accadere le cose nella loro semplicità, la tecnica, in quanto compimento di un destino, porterebbe con sé quel «tragico sapore di definitivo», che determina l’impossibilità di ogni evasione.
Ma, proprio nel punto in cui Heidegger ha inchiodato il suo Dasein, Lévinas sopraggiunge a svincolarlo dalla gravità delle proprie pesantezze terrestri.
Dinnanzi all’anti-soggettivismo di un pensiero, che si fa apologia dell’abbandono al mondo, l’appello alla tecnica diviene, stavolta, promessa di libertà e conferma di quanto, al di là delle seduzioni del luogo,
«rimaniamo padroni del mistero che respira»[41].
Tra le sacre geografie del paesaggio, Lévinas ritrova, nell’extraterritorialità della tecnica, l’eventualità di un’emancipazione tanto profonda, da divenire garanzia della giustizia sociale e assicurazione del rispetto di quei diritti umani, troppo spesso infranti in nome dell’Essere.
Lo sviluppo delle tecniche – scrive il filosofo in Fuori dal soggetto – è probabilmente, di per sé, la modalità essenziale mediante la quale il pensiero dei diritti umani, posto al centro della coscienza di sé, si amplia nella sua concezione e si inscrive, o viene richiesto, come base di qualsiasi legislazione umana[…][42].
In senso diametralmente opposto al misticismo che vive nelle forze naturali invocate da Heidegger, Lévinas definisce, dunque, i contorni di una tecnica, che «urta forse immaginazione e passioni»[43] ma, a livello della vita morale, religiosa e politica, scongiura ogni potenziale deriva ideologica e affranca l’umano da ciò che lo ha costretto alla gravità del suo destino.
«Lo sviluppo della tecnica non è la causa ma è già l’effetto dell’alleggerimento della sostanza dell’uomo»[44].
[1] E. Lévinas, Etica e Infinito. Dialoghi con Philippe Nemo (1982), tr. it. Castelvecchi, Roma 2012, p. 67.
[2] Si veda per l’interpretazione del primo coro dell’Antigone di Sofocle (vv. 332-375) M. Heidegger, Introduzione alla metafisica (1966), tr. it. Mursia, Milano 1979, pp. 154-171.
[3] Ibid., p. 154.
[4] E. Lévinas, Heidegger, Gagarin e noi (1961), ora in Difficile Libertà. Saggi sul giudaismo (1963), tr. it. Jaca Book, Milano 2004, pp. 289-292.
[5] Ibid., p. 291.
[6] Ibid.
[7] Id., Etica e infinito, cit., p. 109.
[8] Id., Heidegger, Gagarin e noi, cit., p. 291.
[9] Id., Umanesimo dell’altro uomo (1972), tr. it. Il Melangolo, Genova 1985, p. 150.
[10] Id., Heidegger, Gagarin e noi, cit., p. 291.
[11] Cfr. Id., Difficile libertà, cit., p. 40.
[12] Id., Heidegger, Gagarin e noi, cit., p. 291.
[13] Ibid.
[14] Sul punto si veda F. Camera, Spazio della trascendenza e significato dell’etica. Nota su Trascendance et intelligibilité di E. Levinas, in A. Moscato (a cura di), Levinas. Filosofia e trascendenza, Parte seconda, Marietti, Genova 1992, pp. 129-142.
[15] E. Lévinas, Dio, la morte e il tempo (1993), tr. it. Jaca Book, Milano 1996, p. 228.
[16] Id., Heidegger, Gagarin e noi, cit., p. 291.
[17] Id., Dio, la morte e tempo, cit., p. 232.
[18] Id., Heidegger, Gagarin e noi, cit., p. 291.
[19] Id., Dio, la morte e il tempo, cit., p. 232.
[20] Id., Totalità e Infinito (1961), tr. it. Jaca Book, Milano 1990, p. 136.
[21] Id., Tra noi. Saggi sul pensare-all’altro (1991), tr. it. Jaca Book, Milano 1998, p. 151.
[22] Id., Dio, la morte e il tempo, cit., p. 225.
[23] Id., Dal sacro al santo. Cinque nuove letture talmudiche (1977), tr. it. Città Nuova Editrice, Roma 1985, p. 87.
[24] Ibid., p. 92.
[25] Ibid., p. 87.
[26] Ibid., p. 101.
[27] Id., Heidegger, Gagarin e noi, cit., p. 289.
[28] Ibid.
[29] Id., Dio, la morte e il tempo, cit., p. 228.
[30] Platone, Fedro 230d 4-6.
[31] E. Lévinas, Heidegger, Gagarin e noi, cit., p. 291.
[32] Id., Totalità e infinito, cit., p. 44.
[33] M. Heidegger, La questione della tecnica, in Saggi e discorsi (1957), tr. it. Mursia, Milano 1976, p. 13.
[34] E. Lévinas, Altrimenti che essere o al di là dell’ essenza (1974), tr. it. Jaca Book, Milano 1983, p. 100.
[35] M. Heidegger, Costruire Abitare Pensare, in Saggi e discorsi, cit., p. 105.
[36] E. Lévinas, Heidegger, Gagarin e noi, cit., p. 290.
[37] Id., Totalità e Infinito, cit., p. 75.
[38] Ibid., p. 44.
[39] Ibid.
[40] Id., Alcune riflessioni della filosofia dell’hitlerismo (1934), tr. it. Quodlibet, Macerata 1996.
[41] Id., Heidegger, Gagarin e noi, cit., p. 292.
[42] Id., Fuori dal Soggetto (1987), tr. it. Marietti, Genova 1992, pp. 125-126.
[43] Id., Heidegger, Gagarin e noi, cit., p. 292.
[44] Ibid., pp. 298-290.