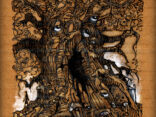Autore
Indice
- Intro
- Percorsi di ricerca ed esplorazioni
- Critica della violenza
- L’ideale della nonviolenza
- Sul nodo tra etica e politica
S&F_n. 23_2020
Abstract
“Some fleeting glimpse of utopia”. Nonviolence and the challenge of ethical-political planning in Judith Butler
The thesis at the heart of this paper is that, in her latest text, The Force of Nonviolence. An Ethico-Political Bind, Judith Butler presents a moment of reflection with original aspects compared to her previous thought. She inaugurates here a new point of view in her thinking, through which also previous categories and concepts undergo a shift useful to actively act for the preparation of the future. By deepening and autonomizing the theme of nonviolence, the critical thinker intends to elaborate an ethical-political dimension that, keeping anarchic accents and shared inventiveness from below, wants to present itself as a credible and universalizable alternative. In this framework, not without shadows, complications and paradoxes, nonviolence takes on the shape of what embodies the utopian possibility, common to all human beings, to open a different, revolutionary future, where the reproduction of violence – both psychic, social and, finally and above all, institutional – is stopped, with a view to taking on the vulnerability and precariousness of living beings.
A Helin Bölek, Ibrahim Gökçek e Mustafa Koçak,
che la terra vi sia lieve
Büyü de baban sana,
Büyü de büyü
Baskılar, işkenceler,
Kelepçeler, gözaltılar,
Zindanlar alacak
Grup Yorum, «Büyü»[1]
- Intro
Quando individui arrestati ingiustamente, incarcerati, sottoposti alla violenza statale della prigionia e della tortura decidono di dare la forma di uno sciopero della fame, fino a morirne, alla lotta contro il potere che li opprime, ci troviamo di fronte a una decisione che turba profondamente. Quando questo atto viene compiuto da chi è abituato a lottare, anche culturalmente, contro il sistema dei rapporti capitalistici, il gesto colpisce ancora di più. In questo caso, infatti, si tratta non di un sacrificio, di un atto eroico, o del segno di una disperazione solitaria, bensì di una denuncia contro una forma di società e di socialità in cui è venuta meno «“anche la più piccola possibilità di una vita dignitosa”»[2]. Ma quale portata ha questa denuncia? Di quali conseguenze feconde è capace? Cosa ci dice della capacità dei legami etico-politici rivoluzionari di rispondere allo stesso livello ma diversamente alla violenza che viene loro contrapposta e alla sfida di rinnovamento radicale del mondo che si pongono come obiettivo?
Judith Butler ha riflettuto diffusamente sul ruolo dei comportamenti volti a trasformare radicalmente i rapporti etici, la stessa struttura etica del soggetto e la relazione tra questa rinnovata dimensione etica e il suo riflesso politico[3]. In particolare, si è a lungo soffermata sul ruolo di queste condotte come manifestazione reale dell’opposizione alla violenza dominante. Finora lo ha fatto, come osserva Bazzicalupo, fondandosi su un «momento etico metapolitico»[4]. The Force of Nonviolence. An Ethico-Political Bind[5] presenta, sin dal titolo, un progetto che è una sfida. È l’esperimento di porre in relazione, a partire da una certa autonomia reciproca, i due piani dell’etica e della politica, in modo che possano infondere nella nonviolenza la forza necessaria affinché essa si presenti come soggetto autonomo nel discorso etico, in quello politico e in quello del loro fertile intreccio. Così, in questo testo, Butler esplora la possibilità di una progettualità etico-politica che, tenendo assieme accenti anarchici e inventiva condivisa dal basso, sia capace di porsi all’altezza delle dinamiche biopolitiche e di sovranità[6] che istituiscono la vigenza della violenza sociale. In questo quadro, la nonviolenza si vuole tanto in grado di abbandonare il proprio carattere responsivo, per confrontarsi alla pari con i meccanismi della violenza, quanto dotata di una propria struttura indipendente, capace di raccogliere la sfida di dar forma a un futuro utopico – secondo una concezione di utopia che, per molti versi, mi sembra prossima a quella rivendicata da Henri Lefebvre[7].
La tesi che qui propongo è, dunque, che The Force of Nonviolence sia il lavoro filosofico che inaugura, non senza complicazioni, incertezze e nessi non perspicui, un nuovo punto di vista nel pensiero di Judith Butler, attraverso cui anche le categorie e i concetti precedenti[8] subiscono un certo slittamento. La sfida di pensare una nuova prospettiva che consenta di superare alcune impasse delle formulazioni precedenti[9] è raccolta secondo la modalità di fare filosofia propria all’autrice americana. Il suo dichiarato rifiuto di pensare in termini sistematici o, almeno, tendenti alla sistematicità corrisponde a una scrittura il cui movimento ricorda lo stile del trattato descritto da Walter Benjamin: una riflessione che abbandona il percorso lineare (progressivo o circolare che sia) per riprendere «continuamente da capo» il movimento, come il «respiro», traendo così «l’impulso a un sempre rinnovato avvio», «con minuziosità»[10].
Per comprendere come tale elaborazione progettuale prenda corpo, quali siano le sue proposte e quali i nodi che rimangono aperti e i luoghi che si mostrano ancora problematici, è dunque di una qualche utilità indicare preliminarmente quali sono i diversi punti di vista da cui Butler muove nella sua ricerca filosofica.
- Percorsi di ricerca ed esplorazioni
Questione di genere rappresenta bene il primo punto di vista, quello che si interroga sulla costituzione del soggetto e sulla negoziazione della sua apparizione, con una conseguente attenzione per i confini tra l’individuale psichico-corporeo e l’alterità normativa e del mondo[11]. Butler si confronta – osserva Bernini – con «il debito ontologico che il soggetto sconta verso il potere, senza tuttavia rinunciare a una speranza utopista nella resistenza, nella sovversione o nella dislocazione del potere che il soggetto può operare»[12]. All’interno di queste coordinate, è proprio l’antecedenza non discussa della dimensione soggettiva a far emergere la nonviolenza come posizione della singolarità. Formulazione questa che ancora compare in Critica della violenza etica, dove Butler afferma che il soggetto abitato costitutivamente dall’altro non deve chiudersi su di sé davanti alla violenza inevitabile che tale alterità esercita su di lui. Al contrario, deve – nel senso etico dell’obbligo – farsi carico dell’«insopportabilità» della propria «esposizione come segno e monito di una comune vulnerabilità, di una comune fisicità e di un comune rischio»[13]. È rispetto alla posizione teorico-politica così formulata che si dirigono critiche come quella di Boucher di contribuire «a una politica culturale di sinistra, basata sulla strategia della strategia [strategy of the strategy] della sovversione marginale delle norme culturali dominanti»[14].
Un punto di vista diverso inizia a emergere dopo l’importante lavoro La vita psichica del potere, dove l’autrice aveva aperto alla necessità di formulare una teoria radicale del riconoscimento[15]. Pur senza abbandonare o abiurare la prospettiva e il taglio tematico precedente[16], Butler inizia a pubblicare dei testi in cui la costitutività del soggetto viene posta in tensione con la formulazione di una rivendicazione politica molteplice. Essa muove da una critica delle forme di potere, delle norme sociali, degli istituti nonché delle istituzioni ufficiali – quel che Butler definisce una critica sociale[17].
Ciò che concorre a segnare irrimediabilmente la sua riflessione e, dunque, a rappresentare una sorta di spartiacque è senz’altro l’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 e la risposta americana dell’infinta guerra preventiva. Butler si orienta ora verso l’obiettivo di dare un ruolo costruttivo/costitutivo alle rivendicazioni delle varie minoranze[18], ingiuriate e oltraggiate dall’organizzazione etico-politica dominante della società. «È come se la drag queen protagonista di Gender Trouble», osserva ancora Bernini, fosse uscita all’aperto, nello spazio pubblico, e, «confrontandosi con i grandi eventi del proprio tempo», aggiunge, «fosse arrivata a stringere alleanze con altri soggetti oppressi […] e a rivendicare pieno diritto all’esistenza pacifica non solo per sé, ma per tutti, in nome di una comune umanità»[19]. In L’alleanza dei corpi, Butler stessa si interroga sulla comparsa, nella propria riflessione, di questo alternativo punto di vista affermando che, se «in Gender Trouble, scritto nel 1989, l’ipotesi era che determinati atti individuali volessero o potessero sortire effetti sovversivi sulle norme di genere», ora ciò che le interessa sono le
forme di alleanza tra le varie minoranze o parti di popolazione considerate dispensabili; più in particolare, [… il] modo in cui la precarietà […] potrebbe operare, o già opera, come luogo di alleanza tra gruppi di persone che, al di là di essa, hanno poco in comune, o tra i quali c’è talvolta perfino diffidenza e antagonismo[20].
Secondo questo taglio di lettura, formazione del sé, responsabilità verso l’Altro, relazionalità sociale e critica sociale sono tra loro interdipendenti nel segno della precedenza della costitutività del soggetto (aperto all’alterità). In particolare, il tema della responsabilità diventa ora centrale. Butler vi individua lo strumento attraverso il quale disinnescare i meccanismi di reazione vendicativa all’oltraggio[21], alimentando di contro la sensibilità verso l’alterità[22]. La responsabilità diventa la nozione «che chiama in causa il tentativo di proteggere l’altro/a dalla distruzione»[23]. Butler può così passare dal problema della vita «maggiormente vivibile»[24] per il singolo e per chi si trova ugualmente soggetto assoggettato alle «dimostrazioni di massa che si svolgono per le strade e nelle piazze»[25], dove «i corpi si uniscono, si muovono e parlano assieme, rivendicando un certo spazio in quanto pubblico»[26], dove quindi si realizzano «alleanze difficili e imprevedibili nella lotta per la giustizia sociale, politica ed economica»[27].
Di conseguenza, prendono forma più compiuta i temi delle rivendicazioni collettive[28], della pluralità fisica e sociale[29] e, dunque, della coabitazione con una molteplicità di altri che non sono stati scelti. È questo il frutto dell’incontro con il pensiero di Hannah Arendt, che inizia a essere citata e richiamata proprio a partire dai primi anni 2000[30]. La riflessione filosofica della pensatrice tedesca fornisce le coordinate del quadro generale per pensare il sociale e il politico all’interno del quale si dispiegano l’etico e il morale. E, d’altra parte, la definizione e la rivendicazione delle coordinate etiche[31] forniscono la base e il supporto di ogni enunciazione di filosofia politica e di critica sociale.
Gli argomenti della vulnerabilità altrui e comune, della responsabilità etica e della politica relazionale caratterizzano poi la formulazione della tematica della violenza: «Se per violenza si intende l’atto per cui un soggetto tenta faticosamente di riassumere una padronanza e un’unità di sé, allora non-violenza sarà lasciare aperta la sfida ininterrotta che i vincoli che abbiamo nei confronti degli altri inducono e impongono alla nostra autorità egoica»[32]. Accettare il dettato normativo sociale senza accenti critici è riprodurre la violenza, tanto quella che il soggetto fa a se stesso nel costituirsi quanto quella che esercitano le istituzioni e le dinamiche del biopotere. Allo stesso tempo, per Butler è impossibile pensare di potersi sottrare ai meccanismi della violenza solo con un atto di volontà, che rivela piuttosto la «posizione delle anime belle come chi è per definizione alieno/a all’aggressività violenta»[33]. Né l’opposizione alla violenza può passare per una contro-violenza; deve invece prendere la forma incerta, faticosa e probabilmente fallimentare di un agire differente. È così che gesto, discorso e azione si costituiscono precisamente come «il “legame” o lo “sforzo” che è la non-violenza»[34]. La nonviolenza si configura, dunque, come la forma che assume la sospensione della ripetizione dei processi e meccanismi violenti, l’interruzione di un circolo vizioso e perverso che consuma la vita, le vite[35]. È nella coesistenza della condizione in cui si subisce la violenza e del tentativo di non riprodurla che «lo sforzo esiste e che la possibilità della non-violenza emerge entro i termini di quello sforzo»[36]. Tale «sforzo» non è «esattamente una virtù o una posizione, e non è una serie di principî che possano essere applicati universalmente»[37]. È, invece, una pratica che «denota la posizione di impantanamento e conflitto di un soggetto che è offeso e pieno di rabbia, che ha accesso alla punizione violenta e tuttavia lotta contro questa azione»[38]. Il suo carattere propositivo è affermato:
La resistenza nonviolenta necessità di un corpo che […] mira a costituire un mondo diverso da quello che affronta. [… Essa] non si limita a dire «no» alla violenza del mondo, ma tenta di elaborare il proprio sé e la sua relazione costitutiva con il mondo in modi nuovi, cercando di incorporare, per quanto provvisoriamente, l’alternativa per la quale lotta[39].
La nonviolenza assume così in maniera chiara le forme pubbliche della resistenza passiva e della «disobbedienza civile nonviolenta»[40]. Elaborate attraverso la rilettura del pensiero di Gandhi e M.L. King, tali forme, nella visione di Butler, consentono di praticare un’alternativa concreta alla disposizione del reale, sebbene questa alternativa non oltrepassi i confini né dei «luoghi liberati» (strade, piazze, edifici) da chi protesta né del corpo stesso di chi si dispone secondo un’etica alternativa. È in questa prospettiva che Butler interpreta proprio gli scioperi politici della fame. Chi adotta questo strumento politico, osserva nel dialogo con Athanasiou, vuole interrompere i processi di cui l’istituto carcerario lo rende ingranaggio e complice. La «volontà di morte»[41] che il prigioniero incarna vuole essere una denuncia del carattere inumano dell’istituzione carceraria e un’interruzione concreta, ancorché puntuale, dell’unione tra vita e morte che l’impersonalità dell’apparato repressivo sancisce. Ma vi è di più, vi è anche un carattere pubblico di quest’azione estrema, secondo Butler, che corrisponde all’«appello a sentimenti morali umanitari»[42] e al richiamo a una solidarietà dell’opinione pubblica. Ritroviamo qui una parziale risposta alle domande che ho posto in apertura del testo, una risposta tutta incentrata sulla singolarità etica e, dunque, lontana ancora dal soddisfare la richiesta dal punto di vista politico:
Non c’è modo di costituirsi come soggetti sotto uno di questi regimi (negligenza, incarcerazione, isolamento forzato), quindi l’unica resistenza possibile è attraverso la pratica di de-istituire il soggetto stesso. Espropriare se stesso diventa il modo per espropriare la forza coercitiva e privativa di quella forma di potere[43].
Butler rivendica la resistenza come dichiarazione di un’eticità rigorosa individuale. Ci troviamo di fronte a un’utopia debole, minore. Infatti, in questa prospettiva, la nonviolenza parte dall’accettazione del fatto «che ci sia la possibilità della violenza»[44] e non «ha niente a che vedere con il purificare il dominio della normatività dalla violenza o con l’eliminare quest’ultima da esso espiandola»[45].
In questo punto di vista, anzitutto, si ribadisce con chiarezza la fondazione etica di ogni agire politico. È necessario passare per una possibile trasformazione della soggettività che trova la sua vera chance nella «responsabilità sperimentale»[46] e nell’alleanza dei corpi. La nonviolenza consente di aprirsi, «in negativo,» verso «un altro tipo di legame sociale»[47], a partire dalla propria posizione di soggetto. Ci si può adunare, alleare ma senza che le comunità in cui lo si fa appaiano altro dall’essere una composizione di singoli individui[48]. In secondo luogo, emerge la rinuncia a intervenire per via diretta e immediata nella trasformazione del mondo. La nonviolenza si presenta sotto il segno di una strategia di sopravvivenza (se non del sé fisico quantomeno della tensione etica stessa). Non a caso Butler fa ancora della nonviolenza uno «sforzo» e non una «forza».
Lo stimolo che conduce di recente Butler ad approfondire il piano politico ponendosi degli interrogativi che prefigurano un nuovo punto di vista mi sembra si possa rintracciare nel fatto che gli esperimenti di resistenza e protesta non riescano a riprodursi durevolmente, cioè mostrino di non avere la forza sufficiente per diventare generatori «mimetici» di quell’eticità e moralità alternative a cui hanno dato corpo puntualmente[49].
I segnali di tale esigenza di ripensare la dimensione politica e la sua relazione con il piano etico si possono rintracciare già in alcuni fuggenti passaggi degli scritti di questi ultimi anni. Affiorano laddove la filosofa sottolinea la superiore e anteriore importanza della dimensione vitale generale[50] e, in relazione a ciò, si spinge verso la ricerca di una capacità normativa universalizzabile[51] delle rivendicazioni politiche: «l’opposto della precarietà» è «la lotta per un ordine politico e sociale egualitario in cui una interdipendenza vivibile divenga possibile – sia come condizione del nostro autogoverno in quanto democrazia, sia come suo obiettivo normativo»[52]. Affiorano anche laddove l’autrice si interroga sul valore «assoluto» delle affermazioni di uguaglianza in mezzo all’ineguaglianza generale: «l’incarnazione dell’uguaglianza nella pratica delle assemblee, l’accento sull’interdipendenza, l’occupazione di un luogo, tutto questo fa sorgere una versione dell’uguaglianza» che è la base imprescindibile «di qualunque futura rivendicazione politica»[53]. Alla base senz’altro, ma non già quella rivendicazione politica in essere.
Tornando a considerare i raduni politici più o meno spontanei che hanno attraversato diverse parti del mondo nella seconda metà degli anni Dieci, osserva che «questi corpi, insieme, esercitano il potere performativo di rivendicare la sfera pubblica in un modo che non è ancora stato codificato giuridicamente»[54] e si domanda:
Come dobbiamo intendere questo agire di concerto che apre un tempo e uno spazio esterni, e contrapposti, all’architettura e alla temporalità prestabilite dal regime, che rivendica materialità, che si appoggia sui supporti disponibili ma che, al contempo, tenta di rielaborarne le funzioni, sia tecniche sia materiali?[55]
Si tratta, appunto, del riconoscimento di un fondamento condiviso e globale della dimensione etica e della necessità politica di andare oltre la limitatezza della proposta delle rivendicazioni di piazza che, pur reali, non sono in grado di superare il loro carattere effimero. In altre parole, Butler ricerca la soluzione per l’impasse che si è posta con regolarità e ineluttabilità davanti alle manifestazioni popolari: la risposta violenta (a volte accompagnata da una dialogica ben poco reale e sincera) da parte dell’apparato statale[56]. La forma di socialità libertaria[57] che si manifesta come incarnazione della resistenza ha bisogno di formulare in termini nonviolenti l’alternativa alla violenza pubblica, in particolare quella statale, e di definire una «formula» pubblicamente valida, politica, per la posizione etica e morale dell’opposizione alla violenza. Politica, etica e morale cercano qui di dispiegarsi in maniera al contempo autonoma, reciproca e corale.
Butler è, dunque, alla ricerca della definizione di una pluralità universalizzabile in modo da produrre nei fatti le vite comuni alternative[58]. Un «agire di concerto»[59] che apra alla possibilità di una organizzazione politica della società diversa e altrettanto forte rispetto a quella attuale. In tal senso, a mio avviso, vanno posti in un’unica costellazione i concetti di equality, global obligations e independent lives – a cui rinviano tanto la vulnerabilità quanto la precarietà costitutive dei soggetti.
Quest’ultimo punto di vista non è certo pienamente sviluppato; d’altra parte, credo sia ora emerso con chiarezza dall’orizzonte. Assume i tratti della radicalizzazione dell’esigenza di dare seguito al potenziale teorico della nozione di coabitazione involontaria e non scelta, senza cadere in un volontarismo irrealista o in un irenismo illusorio. È il tentativo di individuare «qualche fugace spiraglio di utopia [some fleeting glimpse of utopia]»[60] come apertura del presente a un futuro migliore. È il tentativo di proporre un’alternativa complessiva capace di sfidare allo stesso livello il modello vigente – dunque al di là, anche se senza prescinderne, di riaffermazioni e rivendicazioni contingenti (sia generi che forme di riconoscimento di condizioni precarie e di lutto pubblico). È in questa prospettiva che ritengo lavori l’ultimo scritto di Butler su The Force of Nonviolence.
- Critica della violenza
All’interno dell’Alleanza dei corpi, Butler ha affermato che «le condizioni sociali della vita vivibile»[61] sono alla base degli «ideali per i quali dobbiamo lottare, e il processo passa per il problema della violenza»[62]. È questa una petizione che chiede di ripensare la violenza nei suoi termini generali e che, all’interno di The Force of Nonviolence, si sviluppa secondo tre differenti piani che si attraversano reciprocamente: il piano epistemologico, quello etico (piuttosto che morale) e quello politico[63].
Anzitutto, la critica della violenza necessita di una definizione precisa[64] del proprio oggetto, dato l’uso ambiguo, insidioso e proditorio che ne viene fatto dal potere[65]. Rispondendo alle obiezioni di Catherine Mills[66], Butler era già stata categorica su un aspetto: la violenza non deve essere associata al piano ontologico. Lì osservava:
Non so che cosa sia la violenza ontologica, ma mi preoccuperei di qualunque tentativo di ontologizzare la violenza […] non sono del tutto sicura che si tratti di affermare o negare una tesi trascendentale che esautorerebbe il potere dall’omologazione in questione e renderebbe la violenza essenziale a qualunque ontologia. Dal mio punto di vista, l’«ontologia» è un effetto del potere […]. Dunque, parlare di violenza ontologica è estraneo al mio modo di pensare[67].
Butler rifiuta qui sia la concezione della violenza intesa come un carattere proprio all’ontologia, a ogni ontologia, sia una ontologizzazione della violenza, cioè la trasformazione della violenza in una sostanza, per il dichiarato motivo che ogni discorso sull’essere «è un effetto del potere». In The Force of Nonviolence Butler esplicita come debba essere intesa la violenza: «Non possiamo andare direttamente al fenomeno stesso», afferma, «senza passare attraverso gli schemi concettuali che organizzano l’uso del termine in varie direzioni e senza un’analisi del funzionamento di tali disposizioni»[68]. La desostanzializzazione della violenza passa per la sua reimmissione nelle dinamiche discorsive – che, come si ricorderà, costituiscono prima di tutto il soggetto. Si tratta di una «pratica di nominazione [naming practice]»[69], dunque, che consente il monopolio della violenza nelle più varie forme (quella della coercizione legale, della violenza dissimulata o della sua paradossale attribuzione discorsiva a chi invece in realtà la subisce). Butler può così spostare l’attenzione sui modi in cui «la violenza è rappresentata e attribuita all’interno di un campo di potere discorsivo, sociale e statale»[70]. Nel testo, in realtà, non considera le forme di violenza palesemente ingiuste e dirette a esacerbare la precarietà, rifiutare la dignità al lutto o, ancora, a incrementare la vulnerabilità, a cui rinvia sempre fugacemente[71]. Né considera la violenza dal punto di vista della costituzione del soggetto e da quello dei processi di riconoscimento[72], pur presupponendole in un qualche modo. Ciò che le interessa ora è definire lo spazio dove la forza della nonviolenza possa dispiegarsi. Per Butler, è dunque urgente sgombrare criticamente il campo da quelle forme di violenza che possono rivendicare un ruolo oppositivo nei confronti della violenza biopolitica e sovrana prefigurando una falsa soluzione diretta.
È a partire da queste premesse che Butler si rivolge contro le forme di violenza richiamate come potenzialmente giuste e/o costruttive, soprattutto a sinistra. Riprende qui ragionamenti presentati nei testi precedenti. Già nel saggio sugli scritti di Frantz Fanon, per esempio, aveva sviluppato un discorso diretto a sottrarre il pensiero del rivoluzionario originario della Martinica all’argomentazione della violenza giusta[73]. Ora, contro questo tipo di giustificazione presenta due argomenti. Il primo prende la forma della critica a ogni atteggiamento paternalistico: «Chi appartiene al gruppo di quelli che “preservano”, e le vite di chi si immaginano come bisognose di “essere preservate”?»[74]. Questa domanda ne richiama altre classiche come: quale identità mette in campo questa violenza alternativa? In base a quale principio essa è portatrice di una verità superiore? Come è posta la relazione veritativa con la realtà dei fatti? Il secondo argomento riprende una tesi freudiana. Butler recupera l’idea che la violenza è un meccanismo, psichico e sociale, che, una volta innescato, può facilmente travalicare i limiti e gli obiettivi che si era posti: «anche la cosiddetta “guerra giusta” corre il rischio di avere una distruttività che supera i suoi scopi dichiarati, la sua intenzione […] una distruttività senza limiti»[75]. La violenza è un «fenomeno»[76] e uno «strumento» che «può usare chi la usa»[77], di cui bisogna dunque diffidare.
In secondo luogo, Butler riprende la domanda su cui si è già più volte soffermata: si può agire violentemente, fino all’uccisione, quando c’è in gioco l’autodifesa?[78] Quand’è che la responsabilità nei confronti dell’altro può condurmi in una situazione in cui rinuncio alla generalità dell’altro per prendere le parti della specificità di un qualche altro tra gli altri, che sia io stesso o qualcuno che sento prossimo a me in una comunità esclusiva? Sebbene Butler sia stata sempre esplicita nell’accusare tutte le forme di identitarismo e, in particolare, il nazionalismo[79], questa domanda la tocca direttamente: come evitare che il tema dell’autodifesa si insinui nel proprio argomentare in soccorso dei più vulnerabili e precari creando così una nuova cesura tra quanti sono degni di essere difesi e quanti non lo sono? Per risolvere questa criticità, la stessa autrice sente l’esigenza di passare al livello metateorico ed esplicitare quali siano i principî che consentono di dare una base rigorosa alla presa di posizione assoluta in favore della nonviolenza[80]. In realtà, Butler aveva identificato in precedenza una strada per uscire da questa possibile impasse, quella del comandamento «non uccidere» – tema emerso prima dal confronto con Lévinas[81] e poi da quello con Benjamin[82] – e della sua relazione con la teoria della responsabilità[83]. Non si era comunque mai addentrata lungo questa strada fino a includere come soggetto agente la comunità, che, invece, Benjamin individua come possibile altro soggetto collettivo del rapporto con il comandamento[84]. Per Butler il tema della relazione al comandamento è sempre rimasto legato alla posizione etica dell’individuo aperto e non alla posizione politica collettiva. Dunque, è significativo che in The Force of Nonviolence non riprenda queste argomentazioni[85]. È il chiaro segnale che ora il problema è proprio che questa posizione etica singolare non ha la capacità di incidere efficacemente sul piano sociale e politico. Altrettanto significativo è allora il fatto che anche il concetto di responsabilità sia del tutto assente. La normatività morale a cui rimanderebbe sarebbe troppo astratta e di sapore kantiano[86]. La forma «solitaria»[87] e «anarchica»[88] di relazione che istitutiva con il comandamento può ora solo insegnarci che l’eccezione non può che essere singolare, rara e non istituzionalizzata e, in secondo luogo, che deve riguardare un Altro singolare e specifico.
«Quello che inizia come un quadro morale […] si trasforma in un altro tipo di problema – un problema politico»[89], un problema che riguarda il superamento della ripartizione delle vite tra vite degne di lutto e vite che non lo sono, che attiene alla considerazione dello stato di precarietà in cui le popolazioni si trovano. È il problema che ritengo pongano i prigionieri politici in sciopero della fame: destituire il potere che li ha incarcerati a partire da un movimento popolare di rivendicazione di un’autonomia democratica; sviluppare un’articolazione della politica che si prenda cura di loro. Nella prospettiva di Butler, prende segnatamente la forma di un problema di demografia, del modo in cui la «gente [people] (demos) è scritta (graphos) o rappresentata»[90]. In sintesi, per lei si tratta ora di assumere uno sguardo che «richiede un ripensamento della politica sociale, delle istituzioni e dell’organizzazione della vita politica»[91] – certo, sempre in un legame serrato e imprescindibile con l’etica. Se non sono presenti entrambi questi caratteri, ribadisce Butler, allora vuol dire che, al di là di ogni possibile dichiarazione, è in corso di nuovo una giustificazione della violenza fondata sulla distinzione, sulla separazione di parti della popolazione a partire da norme che appartengono a un’insostenibile e ingiustificabile «ampia operazione di biopotere»[92].
In questi passaggi teorici, assistiamo al recupero del riferimento all’universale e alla sua formulazione nei termini arendtiani della constatazione/imperativo della convivenza caratterizzata dalla non scelta. Da questo complesso intreccio di rinvii e meta-riflessioni mi sembra emergano due elementi. Da un lato, l’argomento dell’autodifesa non può essere usato esimendosi dalla propria posizione all’interno delle dinamiche sociali e politiche di cui si è parte. Dall’altro, esso deve sempre tener conto della normatività etica che non può venir meno, quella per cui bisogna riconoscere la comune vulnerabilità originaria e precarietà costitutiva senza istituire distinzioni discriminatorie e di modo che tutti siano ugualmente in grado di essere compianti e partecipare alla socialità e agli «obblighi globali [global obbligations]»[93]. Se è vero che Butler ha sempre pensato all’unità nella distinzione tra etica e politica, ecco che ora, per la prima volta, dà a questa unità una forma costruttiva e propositiva generale partendo proprio dal secondo dei due termini[94]:
In altre parole, quella che potremmo chiamare «l’uguaglianza radicale di ciò che può essere pianto [radical equality of the grievable]» potrebbe essere intesa come il presupposto demografico per un’etica della nonviolenza che non faccia eccezioni[95].
4. L’ideale della nonviolenza
La nonviolenza deve sempre confrontarsi con «tutte queste sfide fantasmagoriche e politiche»[96]. Come si definisce ora la sua autonomia a partire dall’obiettivo che si è data, cioè mostrare la propria forza come capacità di generare un modello politico alternativo universalizzabile? Butler elenca alcune caratteristiche che la riguardano.
Anzitutto, «la nonviolenza è un ideale che non sempre può essere pienamente onorato nella pratica»[97]. Il concetto di ideale a cui pensa l’autrice è quello definito da Hegel. Esso permette di porre concretamente la relazione tra il determinato e l’infinito, di movimentare il determinato verso il possibile[98]. Questo movimento si dà sia a livello della soggettività del singolo individuo, come dinamizzazione della sua costitutività etica, sia a livello della soggettività comunitaria. Inteso in questo secondo quadro, l’ideale della nonviolenza è l’orizzonte di possibilità della comunità dei soggetti che non si riconoscono nelle dinamiche violente dominanti e che si oppongono alla loro reiterazione. Il riferimento tanto all’uno quanto all’altro livello non è privo di tensioni e complicazioni; vi ritornerò nell’ultimo paragrafo.
In secondo luogo, la nonviolenza è una pratica che necessariamente «affronta fondamentali ambiguità etiche e politiche, il che significa che la “nonviolenza” non è un principio assoluto, ma il nome di una lotta in essere [ongoing struggle]»[99]. La nonviolenza è una «lotta in essere» o una «lotta aperta [open-ended struggle]»[100], perché apre incondizionatamente al futuro, si fa carico del possibile nella forma di un suo faccia a faccia pratico e diretto con l’ambiguità che caratterizza sia l’etica che la politica, quando si confrontano con la realtà storica determinata che vogliono modificare.
In terzo luogo, la nonviolenza non è una passivizzazione, una «azione omessa» bensì «un’affermazione fisica [physical assertion] delle rivendicazioni di vita, un’affermazione vivente, una rivendicazione [claim] fatta con la parola, il gesto e l’azione»[101], è il modo di «impegnarsi in una forma di persistenza». La pratica nonviolenta è un comportamento attivo, non un sacrificio eroico[102], né una disposizione pacifica e sottomessa. Esprime e rende produttiva la carica di rabbia e aggressività[103] per l’ingiustizia del mondo, come, per Butler, hanno dimostrato Gandhi e King. Quel «non-» che la lega alla violenza non può vincolarla alla posizione di suo opposto negativo. Ma come articolare la relazione tra piano etico e piano politico in questa nonviolenza che si autonomizza dalle dinamiche responsive? Attraverso la formulazione di una pratica sociale e politica assunta in concerto e non solo al fine di opporsi alle manifestazioni sistemiche di distruzione; ma anche e più di tutto – Butler usa il verbo frasale coupled with – «un impegno nella costruzione del mondo che onori l’interdipendenza globale del genere che incarna ideali di libertà e uguaglianza economica, sociale e politica»[104]. La nonviolenza è un ideale che consente ad altri ideali di prendere corpo. Lo fa attraverso un’azione collettiva utopica, aperta al futuro come realizzazione dei suoi possibili, che si concretizza anzitutto nel corpo come forma che supera i propri «confini individuali»[105] e che «lavora sulla soglia del suo potenziale sociale e politico»[106]. Butler pensa qui al potenziale dell’uomo nuovo che ha rintracciato nei testi di Fanon[107]. Il corpo diventa la materia prima dell’ideale della nonviolenza:
Questa persistenza non è una questione di individualismo eroico, né della ricerca in profondità di risorse personali sconosciute. Il corpo, nella sua persistenza, non è espressione dell’individuo o della volontà collettiva. Infatti, se accettiamo che una parte di ciò che un corpo è […] esiste nella sua dipendenza da altri corpi – dai processi viventi di cui fa parte, dalle reti di sostegno a cui contribuisce – allora stiamo sostenendo che non è del tutto giusto concepire i corpi individuali come completamente distinti l’uno dall’altro; non sarebbe nemmeno giusto pensare a essi come completamente fusi, senza distinzione. […] Non è solo che questo o quel corpo è legato in una rete di relazioni, ma che il confine contiene e mette in relazione; il corpo, forse proprio in virtù dei suoi confini, si differenzia da un mondo materiale e sociale che rende possibile la propria vita e la propria azione ed è insieme esposto a esso. [...] Questo è un punto materialista che neghiamo solo a nostro rischio e pericolo[108].
Per un verso, dunque, Butler continua a insistere su un «ethos e una pratica contro-istituzionali»[109], una rivendicazione nonviolenta in cui ciascun soggetto riconosce il «diritto a perdurare [persist]» come un «diritto sociale», come «l’istanza soggettiva di un obbligo sociale e globale che abbiamo verso l’altro»[110]. Anzi, si può dire che esso sia ancora quello predominante[111], come mostra il continuo rinviare a lavori descrittivi di quel che succede nello spazio appartato, benché pubblico, isolato benché poroso alle dinamiche di potere, di luoghi di protesta come Gezi Park, Occupy Wall Street o piazza Syntagma, dove i corpi resistenti – descrive Gambetti, citato da Butler, – «producevano una socialità alternativa», uno «spazio in cui la resistenza fisica avrebbe potuto trasformarsi in un modo di vita»[112]. A questa disposizione corrisponde «la pratica etica che è consapevole del suo proprio potenziale distruttivo»[113] e può opporvisi.
Per l’altro verso, ora Butler avanza autonomamente la pretesa universalistica, di tipo normativo e che assume la forma dell’alternativa politica radicale e affermativa: «affermare […] che ogni vita dovrebbe poter essere pianta [grievable], stabilendo così un orizzonte utopico all’interno del quale la teoria e la descrizione devono funzionare»[114]. L’orizzonte utopico consente di pensare la nonviolenza al di là della sua manifestazione concreta e come segno di un modo di vita socialmente riconosciuto, politicamente tutelato e dotato di una potenza universalistica. Ma come mettere in campo una positività assoluta e insieme non astratta? Affermando l’uguaglianza, sostiene Butler, e, contestualmente, «una coabitazione parzialmente definita da un’interdipendenza che si discosta dai confini individuali del corpo, o», ancora, «che lavora questi confini a favore del suo potenziale sociale e politico»[115]. La nonviolenza intesa politicamente prende la forma di una politica dell’eguaglianza radicale[116]. È possibile interpretarla come lavoro diretto alla trasformazione delle condizioni oggettive tanto sottraendo il terreno alla riproduzione micrologica del sostrato violento che abita il sociale, quanto operando per la realizzazione concreta degli ideali universali della libertà e delle uguaglianze. Ma, allora, questa politica come può prendere concretamente forma? E, ancor più, una «stabile [durable] forma politica»[117]?
- Sul nodo tra etica e politica
Le due letture, quella etica e quella politica, attraverso cui Butler reinveste il tema della nonviolenza hanno acquisito pari dignità e trattazione ma non si sono fin qui conciliate. Nei primi tre capitoli il suo discorso oscilla tra questi due poli che il sottotitolo unisce indissolubilmente. Ma, se probabilmente Butler usa il termine «Bind» solo per indicare un legame produttivo, la trattazione che fin qui ha svolto mi sembra mostri piuttosto un rapporto problematico e scabroso che involontariamente richiama gli altri significati custoditi tanto dal sostantivo quanto dal verbo to bind[118]. Affrontare separatamente gli ambiti etico e politico non è dunque sufficiente. È necessario saldare assieme i due campi risolvendo la complessità della loro relazione. L’ultimo capitolo – Political Philosophy in Freud: War, Destruction, Mania, and Critical Faculty – è il tentativo esplicito di arrivare a tale unione e armonizzazione.
Due sono sostanzialmente gli esperimenti, tra loro annodati, che propone la filosofa. Il primo riprende il concetto di «massa». Butler sembra preferire riferirsi a questa nozione, d’altra parte già adottata anche in scritti precedenti, in sostituzione dei concetti di «popolo» e, ovviamente, di «comunità particolare». Il concetto di massa le consente, infatti, di continuare a pensare un allearsi di soggetti che non si costituiscono in un’identità omogenea e che, al contempo, non sono già decisi nella loro unità da quella determinazione storica e sovrana che si chiama Stato-nazione. La massa informe è vista come il soggetto potenziale dell’agire politico, di un agire in grado di essere più esteso rispetto a quello di cui sono capaci gruppi di soggetti che, ancorché non organizzati, si riuniscono in base a una certa consapevolezza di esigenze che attengono alla dimensione politica. Ma come evitare di ricadere nel ben noto dibattito di inizio Novecento intorno alla massa, che ha mostrato tutti i suoi limiti? La via di uscita che individua Butler è, ancora una volta, quella della singolarità universale determinata dalla psicoanalisi. Butler ricorda che Freud ha costantemente riflettuto sulla «psicologia della massa e sul suo potenziale distruttivo»[119]. Sulla base delle riflessioni dello psicoanalista austriaco, si chiede: «La capacità distruttiva è da ricercarsi all’interno dei vincoli [bonds] che tengono insieme tali gruppi – una sorta di legame [tie] distruttivo – o è piuttosto un potere che “taglia tutti i vincoli comuni” – una spinta [impetus] antisociale che lacera le relazioni sociali?»[120]. Butler continua a seguire Freud, il quale osserva che i gruppi possono dirigere al proprio interno la capacità distruttiva oppure rivolgerla all’esterno, verso altri gruppi. In ogni caso ciò che permette a questa distruttività di scatenarsi è l’«inibizione della facoltà critica»[121]. Ora, Butler si sofferma proprio su quest’osservazione riguardo alla facoltà critica, individuandovi una via di uscita all’impasse freudiana. Mentre Freud associa tale facoltà alla capacità di giudizio, Butler la associa alla mania[122]:
Troppo spesso si traccia direttamente una linea che dalla malinconia va al super-Io, ma la tendenza contrapposta, la mania, può contenere indizi di un diverso tipo di resistenza alla distruzione. La forza maniacale [manic force] che cerca di rovesciare il tiranno è per certi versi il potere [power] dell’organismo di rompere quelli che sono stati considerati vincoli essenziali di identificazione [sustaining bonds of identification]. L’organismo è già un concetto-soglia in cui somatico e psichico si incontrano, quindi non si tratta di una recrudescenza di vita ribelle puramente naturalistica. La dis-identificazione diventa un modo per contrastare i poteri di autodistruzione e per assicurare il perpetrarsi dell’organismo stesso[123].
Alternativa alla funzione auto-repressiva svolta dal super-io, la mania consente a ciascuno di orientarsi verso «forme irrealistiche di solidarietà insurrezionale [unrealistic forms of insurrectionary solidarity]»[124] senza che vengano reiterati i meccanismi governamentali e sovrani dominanti. Così, mentre anche la «guerra condotta contro regimi fascisti o genocidi in nome della democrazia […] corre il rischio di una distruttività che supera i suoi scopi dichiarati, il suo intento deliberato»[125], la mania provoca una posizione critica che la fa finita con tutte le «forme di tirannia» senza uscire dal perimetro «della solidarietà dei sentimenti»[126]:
L’«irrealismo» della mania suggerisce il rifiuto di accettare lo status quo, e attinge al desiderio di vivere, che intensifica, da parte di chi lotta contro forme di amplificato auto-rimprovero. La stessa crudeltà su di sé o autodistruzione può essere provvisoriamente migliorata anche attraverso il ripiegamento sulla solidarietà sociale del fallimento [social solidarity of failure], dato che nessuno di noi è all’altezza dell’ideale, e questo fallimento condiviso fonda la nostra solidarietà e il nostro senso di uguaglianza[127].
Sembrerebbe qui che la mania e la solidarietà sociale del fallimento[128] siano due forme distinte, più complementari che alternative l’una all’altra. Butler, infatti, si chiede ancora: «la mania può forse prendere forma all’interno di quei “sentimenti comuni” e “legami emotivi” che sono necessari per raggiungere questo obiettivo»? La risposta «sembra dipendere da come interpretiamo la “comunità di interessi”»[129].
Arriviamo così al secondo tentativo. Dato che non dipende da un patto o da un contratto, che Butler rifiuta categoricamente, come intendere questa dimensione comunitaria di massa? Abbiamo visto che la massa può (e deve) comporsi di individui che rinunciano all’auto-rimprovero e alla violenza esterna sviluppando invece la mania e, sulla sua base, la facoltà critica[130]. Potremmo chiederci provocatoriamente se qui Butler ci stia proponendo e stia rivendicando una comunità di maniaci? È chiaro che per la filosofa la mania non può diventare modello di comportamento e di azione[131].
Per procedere, è utile qui richiamare nuovamente uno scritto precedente. In Vite precarie, Butler aveva affermato: «sono favorevole all’autodeterminazione dei soggetti, purché comprendiamo che nessun soggetto, nemmeno il soggetto nazionale, esiste al di fuori di un contesto internazionale»[132]. Presentava così un parallelismo diretto tra la dimensione psichica individuale e quella «nazionale» che, in un altro punto dello stesso testo, era ancor più chiaramente esplicitata: «Le nazioni non funzionano come menti individuali, ma in entrambi i casi si può parlare di “soggetti”, seppur di ordine differente»[133]. Già in quel testo la difficoltà di articolare questa analogia emergeva nella problematica spiegazione: «Quando gli Stati Uniti agiscono, stabiliscono per principio cosa significhi agire da americano, stabiliscono la norma per comprendere tale soggetto»[134]. In The Force of Nonviolence il livello nazionale viene semplicemente obliterato e l’analogia è spostata a una non meglio specificata dimensione generale, priva di confini e informe. La comunità che si fa massa politica, a cui pensa Butler, è quella che si riferisce al «più ampio quadro internazionalista [broader internationalist frame]»[135] – un riferimento, questo, che sembra suggerire l’appello a un internazionalismo anarchizzante. D’altra parte, questa operazione di allargamento indefinito e an-archico viene sviluppata ancora una volta ricorrendo alla riflessione psicoanalitica freudiana:
una linea di pensiero abbandonata nelle sue riflessioni di psicologia di gruppo: la prima strada che esplora richiede una resistenza alle euforie del nazionalismo; la seconda invita a tener conto delle basi «organiche» della nostra natura di esseri umani. […] la mobilitazione dell’«Eros […]», e la formazione di forme condivise/comunitarie [communal forms] di identificazione[136].
La mania ha sostituito l’eros/amore[137] e rappresenta la prima forma di mobilitazione. Le «forme condivise/comunitarie di identificazione» indossano le vesti di una solidarietà che deve iniziare da quella parte delle «nostre nature organiche»[138] che si oppongono radicalmente alla violenza.
Il tema della «natura organica» che caratterizza l’essere umano è allora l’ultima strada che Butler percorre attraverso lo strumentario psicoanalitico[139] per pensare una dimensione immediatamente comunitaria di massa. Di tale natura organica, a cui in quest’opera accenna solo, ha trattato in un altro recente breve testo dedicato al pensiero del giovane Marx:
Marx fa delle locomotive e delle ferrovie gli «organi del cervello umano», il che indica che queste istituzioni umane si sviluppano a partire da idee che nascono dalla coscienza umana, e pure che queste istituzioni emergono anche dalla parte organica del cervello […] Questo è solo un esempio del fatto che il postulato secondo cui gli organi si situano all’interno del corpo non è del tutto corretto[140].
Gli organi sono anche «nei mezzi di produzione (le ferrovie e le locomotive)»[141]. Si tratta di una vera e propria «estensione tecnica del corpo»[142] e, insieme, di un allargamento sociale della dimensione psichica. Quello che qui Butler propone è un tentativo che presenta una certa somiglianza con quanto abbozzato da Benjamin in vari punti dei suoi materiali di lavoro sul Passagen-Werk. La differenza essenziale tra i due tentativi, è che in Benjamin il pensiero dello psichico collettivo trova il suo punto di mediazione nella trasformazione della realtà circostante che informa ed educa gli individui[143] mentre in Butler «seguace» di Freud il passaggio dall’individuale soggettivo al collettivo soggettivo è immediato, diventando anzi questo stesso passaggio la mediazione per gli altri livelli[144].
Il transito per Freud è, in definitiva, un singolare tentativo, visto che nel riferimento alla psicoanalisi lo sviluppo del piano politico trova più fonti di tensione che un vero e proprio consolidamento. Tale rimando risulta, infatti, problematico sotto due aspetti. Da un lato, pensare il politico attraverso lo psicoanalitico sembra istituire parametri trans-storici che confermano in Butler la tendenza a un uso della psicoanalisi che ne fa, osserva Bernini, il «deposito di verità sull’umano»[145]. Dall’altro lato, il tentativo di passare dal livello costitutivo dei soggetti a quello dell’intera società contemporanea si affida a un processo analogico che, carente nei suoi sviluppi freudiani, non trova una maggior stabilità nella formulazione della filosofa. Nel leggere le questioni e problematiche teoriche pulsionali in chiave sociale, là dove si interroga sul rapporto che intrattengono soprattutto con la massa[146], la sua elaborazione più recente non è in grado di sostituirsi in maniera convincente alle forme di alleanza già teorizzate in precedenza. Inoltre, là dove richiama il «più ampio quadro internazionalista»[147] non mette a fuoco la relazione, lasciandola in una nebbia che è senz’altro un impulso per nuove riflessioni.
Lo sciopero politico della fame da cui sono partito richiede a fianco della rivendicazione etica un parallelo e concertato agire politico che trovi un suo precipitato in una (o più) forme organizzate. Per corrispondere alla domanda di giustizia universale di cui si fa espressione, è indispensabile riflettere sulla capacità di aggregare stabilmente intorno a una partecipazione democratica, che trovi corpo in strutture elastiche, periture ma, al contempo, solide e durature. Si potrebbe dire, riprendendo le parole di Öcalan, rivoluzionario e teorico che ha lungo a meditato su questi temi: «Uno stile democratico richiede […] una coscienza sociale, un modo di agire scientifico e la conoscenza dei processi di governo sociali»[148]. La sua spontaneità è artificiale poiché «richiede formazione ed esperienza intensive»[149]. Senza questo passaggio, come sarebbe possibile non ricadere nel quadro descritto da Benjamin nelle tesi Sul concetto di Storia, in cui l’oblio prevale ricoprendo le azioni politiche e il modello di cui si fanno espressione concreta, poiché «i morti non saranno al sicuro dal nemico» fintanto che il nemico non avrà «smesso di vincere»[150]? Il ripensamento della relazione tra etica e politica richiesto dal gesto dei prigionieri che protestano con lo sciopero della fame non mi sembra dunque trovare un adeguato accoglimento nel pensiero di Judith Butler, che in The Force of Nonviolence propone in definitiva ancora una volta una confricazione che rallenta, impedisce, intralcia i meccanismi del biopotere[151] e che ipotizza una dimensione comune d’azione che rimane indefinita.
[1] «Cresci, su, e tuo padre / cresci, su, cresci / ti comprerà celle sotterranee, / oppressioni, torture, / manette e galere» (tr. it. su www.antiwarsongs.org [ultima consultazione 31.05.2020]). Canzone dell’album «Sıyrılıp Gelen», 1987.
[2] A. Öcalan, Scritti dal carcere. Oltre lo Stato, il potere e la violenza (2004), tr. it. Ed. Punto Rosso – Iniziativa Internazionale “Libertà per Abdullah Öcalan – Pace In Kurdistan”, Milano 2016, p. 481. Öcalan cita qui la spiegazione che diedero Kemal Pir, Mehmet Hayri Durmuş, Mazlum Doğan e Ferhat Kurtay iniziando lo sciopero della fame che li portò alla morte, nel 1982. La storia si ripete, ma senza farsa.
[3] Butler utilizza i concetti di «etica» e di «morale» in base a una differenza che è ben sintetizzata da Nancy Fraser in N. Fraser - A. Honneth, Redistribuzione o riconoscimento? Lotte di genere e disuguaglianze economiche (2003), Meltemi, Milano 20202, pp. 40-41: «le questioni di giustizia riguardano il “giusto” [right] e appartengono rigorosamente alla sfera della “moralità”. Invece, le questioni di auto-realizzazione riguardano il “buono” [good] e appartengono al dominio dell’“etica”. […] Le norme di giustizia sono universalmente vincolanti; come i principi della Moralität kantiana […] Le rivendicazioni per l’auto-realizzazione, invece, sono generalmente più circoscritte. Esse dipendono, come i canoni della Sittlichkeit hegeliana, da orizzonti di valore storico-culturale specifici».
[4] L. Bazzicalupo, Prefazione all’edizione italiana, in J. Butler, E. Laclau, S. Žižek, Dialoghi sulla Sinistra. Contingenza, egemonia, universalità (2000), tr. it. Laterza, Roma-Bari 2010, p. XXIV.
[5] J. Butler, The Force of Nonviolence. An Ethico-Political Bind, Verso, New York 2020 [trad. mia di tutte le citt. dal volume].
[6] Cfr. J. Butler, Vite precarie. Contro l’uso della violenza in risposta al lutto collettivo (2004), tr. it. Meltemi, Roma 2004, pp. 118-125.
[7] Così Lefebvre nel suo noto saggio sul Diritto alla città: «L’utopia controllata dalla ragione dialettica costituisce l’antidoto alle finzioni cosiddette “scientifiche” e a un imaginario fuorviante e permette alla riflessione di sottrarsi all’ipoteca del programmato. Il movimento dialettico si presenta come un rapporto tra la scienza e la forza politica, come un dialogo, il che attualizza i rapporti tra “teoria-pratica” e tra “positività-negatività critica”», H. Lefebvre, Il diritto alla città (1968), tr. it. ombre corte, Verona 2016, p. 111. E ancora: «l’utopia concreta si fonda sul movimento di una realtà di cui essa scopre le possibilità», H. Lefebvre, Spazio e politica. Il diritto alla città II (1974), tr. it. ombre corte, Verona 2018, p. 83.
[8] Per esempio, come si vedrà oltre, ciò succede con i concetti di vulnerabilità e precarietà, di alleanza, di violenza e di sovversione delle dinamiche di potere.
[9] Mi riferisco, in particolare, a: l’idea della dislocazione soggettiva del potere che non supera i confini della sua singolarità; il modo in cui rendere universali e universalmente condivisibili le rivendicazioni delle minoranze; la questione di come creare alleanze non esclusive; come dare forza alla normatività etica una volta che si è rinunciato a farle assumere una qualche forma dottrinale; come costituire la comunità umana alternativa.
[10] W. Benjamin, Premessa gnoseologica a Il dramma barocco tedesco (1925), in Opere complete. II. Scritti 1923-1927, tr. it. Einaudi, Torino 2002, p. 70.
[11] Si veda per esempio l’affermazione in J. Butler, Corpi che contano. I limiti discorsivi del sesso (1993), tr. it. Feltrinelli, Milano 1996, p. 81. Cfr. R. Kelz, The Non-sovereign Self, Responsibility, and Otherness. Hannah Arendt, Judith Butler, and Stanley Cavell on moral philosophy and political agency, Palgrave Macmillan, New York-Basingstoke 2016, in particolare p. 65.
[12] L. Bernini, F. Zappino, Quale futuro per il soggetto queer, in J. Butler, La vita psichica del potere. Teorie del soggetto (1997), tr. it. Mimesis, Milano, 2013, p. 211. Per questo sintetico quadro, non sono rilevanti altre differenze, presenti tra i testi di questa prospettiva, come gli accenti più volontaristici che si rinvengono in Questione di genere (Gender Trouble) di contro a quelli meno volontaristici che si rinvengono in La vita psichica del potere.
[13] J. Butler, Critica della violenza etica (2005), tr. it. Feltrinelli, Milano 2006, pp. 135-136. Era già questa formulazione un’evoluzione di quanto esposto all’interno della parte finale di La vita psichica del potere.
[14] G. Boucher, The politics of Performativity: A critique of Judith Butler, in «Parrhesia», 1, 2006, p. 112 [trad. mia].
[15] Su queste prime due prospettive si sofferma già Lorenzo Bernini nel paragrafo Dalla sovversione drag all’etica della vulnerabilità in Id., Riconoscersi umani nel vuoto di Dio. Judith Butler, tra Antigone ed Hegel, in L. Bernini - O. Guaraldo (a cura di), Differenza e relazione. L’ontologia dell’umano nel pensiero di Judith Butler e Adriana Cavarero, ombre corte, Verona 2009, pp. 16-22.
[16] Un tentativo interessante di rileggere con le lenti e gli strumenti forniti dagli scritti di questo secondo punto di vista i testi del primo periodo si trova in S.A. Chambers, T. Carver, Judith Butler and Political Thepry. Troubling politics, Routledge, New York-Londra 2008, in particolare il cap. Normative violence, pp. 75-91.
[17] J. Butler, Critica della violenza etica, cit., p. 178.
[18] Cfr. ibid., p. 112.
[19] L. Bernini, Riconoscersi umani nel vuoto di Dio..., cit., p. 18.
[20] J. Butler, L’alleanza dei corpi. Note per una teoria performativa dell’azione collettiva (2015), tr. it. nottetempo, Milano 2017, pp. 46-47.
[21] L’oltraggio è una forma relazionale costitutiva della soggettività. Dipende dalla «suscettibilità subita e non voluta» (J. Butler, Critica della violenza etica, cit., pp. 124-125) che la abita inevitabilmente.
[22] Cfr. B. Schippers, The Political Philosophy of Judith Butler, Routledge, New York-Londra 2014, in particolare p. 54.
[23] J. Butler, La non-violenza è necessaria e impossibile. Risposta a Catherine Mills e Fiona Jenkins (2007), in «aut-aut», 344, 2009, p. 140.
[24] Id., L’alleanza dei corpi…, cit., p. 56.
[25] Ibid., p. 115.
[26] Ibid., pp. 115-116.
[27] Ibid., p. 115.
[28] Ciò secondo la prospettiva peculiare che tali collettività non istituiscono macro identità, punto questo su cui Butler pone l’accento ritenendo che le «ontologie identitarie» siano «insufficienti per pensare il problema dell’alleanza», ibid., p. 112.
[29] Cfr. O. Guaraldo, Figure di una relazione. Sul pensiero di Judith Butler e Adriana Cavarero, op. cit., pp. 90-121, in particolare p. 112.
[30] Per la genealogia e lo sviluppo della mediazione del pensiero di Cavarero su questo incontro si veda in generale il volume L. Bernini, O. Guaraldo (a cura di), op. cit.
[31] Un’«etica a partire da un ambito di radicale inintenzionalità» vuol dire «assumere la stessa insopportabilità di questa esposizione come segno e monito di una comune vulnerabilità, di una comune fisicità e di un comune rischio – anche quando “comune” […] non equivale a “simmetrico”», J. Butler, Critica della violenza etica, cit., pp. 135-136.
[32] Ibid., p. 89. Sulla all’antecedenza dell’ego rispetto al soggetto: cfr. ibid., p. 82.
[33] J. Butler, La non-violenza è necessaria e impossibile…, cit., p. 134.
[34] Ibid., p. 134.
[35] Cfr. R. Kelz, The Non-sovereign Self, Responsibility, and Otherness. Hannah Arendt, Judith Butler, and Stanley Cavell on moral philosophy and political agency, Palgrave Macmillan, New York-Basingstoke 2016, in particolare p. 162.
[36] J. Butler, La non-violenza è necessaria e impossibile…, cit., p. 134.
[37] Ibid.
[38] Ibid.
[39] Id., L’alleanza dei corpi…, cit., p. 294.
[40] Ibid., p. 297.
[41] J. Butler, A. Athanasiou, Spoliazione. I senza casa, senza patria, senza cittadinanza (2013), tr. it. Mimesis, Milano-Udine 2019, p. 131.
[42] Ibid.
[43] Ibid., pp. 131-132.
[44] J. Butler, La non-violenza è necessaria e impossibile…, cit., p. 134.
[45] Ibid.
[46] Ibid., p. 144.
[47] Ibid., p. 143.
[48] Anche l’«interdipendenza corporea» a cui rinvia l’autrice in L’alleanza dei corpi è sostegno e supporto reciproco dei corpi nella loro indipendenza singolare: cfr. J. Butler, L’alleanza dei corpi…, cit., p. 295.
[49] Sul riscontro di questa necessità all’interno della riflessione di Judith Butler si chiude l’articolo di C. Lo Iacono, Parole che contano: vulnerabilità, narratività e obbligazione in Judith Butler, in «Consecutio temporum», 4, 2013, su www.consecutio.org [ultima consultazione 15.05.2020].
[50] «L’essere umano in quanto creatura dotata di agency può emergere solo nel contesto di un mondo vivente, un mondo nel quale è la dipendenza dagli altri esseri umani e dai processi vitali a innescare la stessa capacità di agire. […] chiedersi cosa rende vivibile una vita precede la domanda su qual è il tipo di vita che devo condurre; il che significa che ciò che qualcuno chiama il biopolitico condiziona le domande normative che poniamo a proposito della vita», J. Butler, L’alleanza dei corpi…, cit., p. 73.
[51] Si veda qui l’autocritica contro il rigetto assoluto dell’universale e una sua più “equilibrata” comprensione: «lavorando, prima come parte del direttivo e poi come presidente dello stesso, con uno straordinario gruppo di attivisti e attiviste, nella International Gay and Lesbian Human Rights Commission (1994-1997), […] sono arrivata a capire che il termine svolge un importante ruolo strategico proprio in quanto categoria aperta e non-sostanziale. È lì che ho compreso come asserire l’universalità possa essere un atto prolettico e performativo, poiché evoca una realtà che non esiste ancora e tende alla possibile convergenza di orizzonti culturali che non si sono ancora incontrati. Sono quindi arrivata a un secondo modo di intendere l’universalità, per cui è definita quale lavoro di traduzione culturale orientato verso il futuro», J. Butler, Prefazione all’edizione 1999, in Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità (1990), tr. it. Laterza, Roma-Bari 2013, pp. XVII-XVIII.
[52] J. Butler, L’alleanza dei corpi…, cit., p. 113.
[53] Id., «Noi, il popolo». Riflessioni sulla libertà di riunione, in A. Badiou, P. Bourdieu, J. Butler, G. Didi-Huberman, S. Khiari, J. Rancière, Che cos’è un popolo? (2013), tr. it. DeriveApprodi, Roma 2014, p. 55.
[54] J. Butler, L’alleanza dei corpi…, cit., p. 122.
[55] Ibid., p. 123.
[56] Si aprirebbe qui un altro campo di riflessione, a cui accenno solo in questa nota. Infatti, Butler difficilmente adotterebbe l’espressione althusseriana di cui ho fatto qui uso, ma è indubbio che ci siano degli elementi di filosofia politica poco elaborati nella sua riflessione – o che quanto meno andrebbero affrontati in un discorso autonomo – come la relazione tra apparati statali e strutture sovra-statali e dinamiche globali, come il tipo di soggettività a cui vengono attribuite le dinamiche globali e violente di governo, spogliazione, arricchimento, come, ancora, la trasformazione della relazione tra governamentalità e sovranità a partire dal primo ripensamento avvenuto in Vite precarie (cfr. in particolare il cap. Detenzione infinita, pp. 73-125). Sulle ragioni di questo impensato torno nel paragrafo finale.
[57] «Tali azioni erano eminentemente politiche per il semplice fatto di sovvertire la convenzionale distinzione tra pubblico e privato, al fine di stabilire nuove relazioni di uguaglianza», J. Butler, L’alleanza dei corpi…, cit., p. 144. E in maniera ancora più esplicita: «è probabile che questi che ho elencato costituiscano momenti anarchici, o passaggi anarchici, nei quali viene messa in discussione la legittimità di un regime, o delle sue leggi, quando nessun nuovo regime legale è ancora giunto a prenderne il posto», ibid., p. 122.
[58] Vari sono i passi in cui Butler dichiara questa intenzione. Ne riporto qui solo uno: «La nonviolenza richiede una critica di ciò che conta come realtà e afferma la possibilità [power] e la necessità del contro-realismo in tempi come questi» (J. Butler, The Force of Nonviolence…, cit., p. 10).
[59] J. Butler, L’alleanza dei corpi…, cit., p. 237.
[60] J. Butler, The Force of Nonviolence…, cit., p. 177.
[61] J. Butler, L’alleanza dei corpi…, cit., p. 192.
[62] Ibid.
[63] Butler ne sintetizza le connessioni nelle prime pagine: cfr. Id., The Force of Nonviolence…, cit., pp. 6-7.
[64] Cfr. ibid., p. 4.
[65] Si veda per esempio ibid., pp. 3-4.
[66] Cfr. C. Mills, Normative violence, Vulnerability and Responsibility, in «differences. A Journal of Feminist Cultural Studies», 2, 2007, pp. 133-156.
[67] J. Butler, La non-violenza è necessaria e impossibile…, cit., p. 132.
[68] Id., The Force of Nonviolence…, cit., p. 6 (corsivo mio).
[69] Ibid., p. 5.
[70] Ibid., pp. 5-6.
[71] Si veda, per esempio, ibid., p. 61.
[72] «La violenza che persiste nel farsi e nel sostenersi del soggetto», Id., La non-violenza è necessaria e impossibile…, cit., p. 133.
[73] Cfr. J. Butler, Violenza, non-violenza: Sartre su Fanon (2006), in «aut-aut», 344, 2009, p. 56; Id., The Force of Nonviolence…, cit., pp. 7, 12-13. Cfr. Id., A chi spetta una buona vita ? (2012), tr. it. nottetempo, Milano 2013, poi parzialmente confluito in Id., L’alleanza dei corpi…, cit.
[74] Id., The Force of Nonviolence…, cit., p. 69. Cfr. anche ibid., pp. 70-71. Sul tema aveva già lavorato, riflettendo sull’impossibilità di risolvere le attuali ingiustizie che distinguono soggetti degni di lutto e soggetti che non lo sono semplicemente facendo ricorso ad atti legislativi regolativi, in J. Butler, E. Laclau, S. Žižek, Dialoghi sulla sinistra…, cit., pp. 137-182.
[75] J. Butler, The Force of Nonviolence…, cit., pp. 154-155.
[76] Ibid., p. 14.
[77] Ibid., p. 19. Si tratta di uno sviluppo e, di certo, anche a una complicazione della tesi dubbia e incerta che aveva accompagnato alcuni testi precedenti intorno a una capacità della violenza di riprodursi mimeticamente. Cfr. Id., L’alleanza dei corpi…, cit., p. 145
[78] Cfr. Id., The Force of Nonviolence…, cit., p. 52.
[79] Cfr. ibid., pp. 53-54.
[80] Una obiezione sull’assenza di fondazione è mossa in L. Bernini, Riconoscersi umani nel vuoto di Dio..., cit., pp. 37-38.
[81] Cfr. J. Butler, Vite precarie…, cit., pp. 162-168. Si può considerare questa come un’esplorazione preliminare del potenziale teorico della nozione.
[82] Cfr. W. Benjamin, Per la critica della violenza (1921), in Opere complete. I. Scritti 1906-1922, tr. it. Einaudi, Torino 2008, pp. 485-486.
[83] «… il mio suggerimento è che il comandamento, così come lo pensa Benjamin, costituisca non solo la base per una critica della violenza giuridica, ma anche la condizione per una teoria della responsabilità che ha al suo centro una lotta continua con la non-violenza», J. Butler, Critica, coercizione e vita sacra in “Per la critica della violenza” di Benjamin (2006), in «aut-aut», 344, 2009, p. 72.
[84] Butler così interpreta e formula con originalità: «il comandamento non può dettare l’azione, costringere all’obbedienza o emettere un giudizio contro colui o colei che adempie o manca di adempiere al suo imperativo. Più che costituire un criterio di giudizio per una serie di azioni, il comandamento funziona come un principio-guida [Richtschnur des Handelns]. E ciò che il comandamento ordina è una lotta con il comandamento stesso la cui forma finale non può essere determinata a priori. Nella sorprendente interpretazione di Benjamin, si lotta con il comandamento in solitudine. Come forma di appello etico [ethical address], il comandamento è ciò contro cui ogni individuo deve lottare senza avere alcun altro modello. […] La responsabilità è qualcosa che ci si prende in relazione al comandamento, ma non è dettata dal comandamento stesso. In realtà essa è chiaramente distinta dall’obbligo e, sicuramente, dall’obbedienza. Non esiste la libertà di ignorare il comandamento. Si può, per così dire, lottare con se stessi/e in relazione a esso», J. Butler, Critica, coercizione e vita sacra…, cit., pp. 86-87. Da qui conclude: «(1) che la responsabilità deve essere intesa come una forma solitaria, se non anarchica, di lotta con una domanda etica; (2) che l’obbedienza coatta o forzata uccide l’anima e mina la capacità di una persona di fare i conti con la domanda etica che le viene posta; (3) che il contesto della responsabilità giuridica non può rivolgersi a, né rettificare, le condizioni piene della sofferenza umana», ibid., pp. 92-93. Il testo, rivisto, è stato poi inglobato nel volume, di sei anni successivo, Strade che divergono: di rilievo il fatto che il passaggio in questione sia riportato senza variazioni, cfr. Id., Strade che divergono. Ebraicità e critica del sionismo (2012), tr. it. Raffaello Cortina Editore, Milano 2013, pp. 111-112.
[85] Vi è solo un breve e passeggero richiamo all’inizio dello sviluppo del ragionamento che stiamo qui seguendo: cfr. J. Butler, The Force of Nonviolence…, cit., p. 51.
[86] Cfr. ibid., pp. 77-79.
[87] J. Butler, Critica, coercizione e vita sacra…, cit., pp. 92.
[88] Ibid.
[89] Id., The Force of Nonviolence…, cit., p. 55.
[90] Ibid., p. 104.
[91] Ibid., p. 76.
[92] Ibid., pp. 55-56.
[93] Ibid., p. 50.
[94] È questa poi la base sulla quale distingue la sua posizione dalle rivendicazioni dei “pro-life”: cfr. ibid., pp. 57, 109.
[95] Ibid., p. 56 (corsivo mio).
[96] Ibid., p. 143.
[97] Ibid., p. 21.
[98] Leggiamo nella Logica dello Spirito: «L’idealità può esser chiamata la qualità dell’infinità. Ma essa è essenzialmente il processo del divenire, e quindi un passaggio, come quello del divenire nell’esser determinato, passaggio che è ora da assegnare. Come togliersi della finità, vale a dire della finità come tale e in pari tempo della infinità a lei soltanto contrapposta, soltanto negativa, l’infinità è ritorno in sé, riferimento a se stesso, essere. Poiché in questo essere v’è una negazione, è essere determinato. Ma poiché l’infinità è inoltre essenzialmente negazione della negazione, cioè la negazione che si riferisce a se stessa, essa è quell’essere determinato, che si chiama esser per sé», G.W.F. Hegel, La logica dello Spirito (1841), tr. it. Laterza, Roma-Bari 2004, p. 154, Libro I, Sez. I, Cap. II, C. L’infinità; Il passaggio.
[99] J. Butler, The Force of Nonviolence…, cit., p. 23.
[100] Ibid., p. 56.
[101] Ibid., p. 24.
[102] Cfr., per esempio, Id., L’alleanza dei corpi…, cit., p. 295; J. Butler, A. Athanasiou, Spoliazione…, cit., p. 67.
[103] J. Butler, The Force of Nonviolence…, cit., p. 21.
[104] Ibid.
[105] Ibid., p. 148.
[106] Ibid.
[107] Cfr. Id., Violenza, non-violenza: Sartre su Fanon, cit., p. 56; si veda anche Id., The Force of Nonviolence…, cit., pp. 112-114.
[108] Id., The Force of Nonviolence…, cit., pp. 197-198.
[109] Ibid., p. 61. Cfr. anche Id., L’alleanza dei corpi…, cit., pp. 119, 125, 137, 155, 333.
[110] Id., The Force of Nonviolence…, cit., p. 64. Ancora: «Dunque, la nonviolenza come materia della moralità individuale cede così il passo a una filosofia sociale del vivente e di legami sostenibili», ibid., p. 15.
[111] È in effetti di questo tenore anche la formulazione sintetica che Butler fornisce verso la fine del testo: ibid., p. 201.
[112] In particolare, rinvia alla descrizione fenomenologica in Z. Gambetti, Occupy Gezi as Politics of the Body, in U. Ozkirimli, The Making of a Protest Movement in Turkey: #occupygezi, Palgrave, Londra 2014, pp. 89-102; qui p. 96 [trad. mia].
[113] J. Butler, The Force of Nonviolence…, cit., p. 172.
[114] Ibid., p. 106. Per il concetto di grievable rinvio segnatamente ai capitoli Violenza, lutto, politica e Vite precarie in Id., Vite precarie…, cit., pp. 39-72, 157-181.
[115] J. Butler, The Force of Nonviolence…, cit., p. 148.
[116] Cfr. ibid., p. 202. A essa si associa un «giudizio extra-legale», ibid.
[117] Ibid., p. 152.
[118] «Bind» in inglese significa, infatti, «legame» ma anche «impaccio, imbarazzo, noia, grana» e, nella sua forma verbale, «legarsi, amalgamarsi, formare un legame, stringere» ma anche «indurire», fino ad arrivare ai più forti significati di «obbligare, costringere».
[119] Ibid., p. 162.
[120] Ibid.
[121] Ibid.
[122] La mania assume nell’ultimo testo di Butler il ruolo che veniva svolto dall’amore fino a La vita psichica del potere e dalla responsabilità già in J. Butler, La non-violenza è necessaria e impossibile…, cit. Questo diversa importanza assegnata alla mania passa per un’interpretazione più penetrante delle riflessioni di Melanie Klein: cfr. Id., The Force of Nonviolence…, cit., pp. 92-97.
[123] Ibid., p. 167.
[124] Ibid., p. 168.
[125] Ibid., pp. 154-155.
[126] Ibid., p. 170.
[127] Ibid.
[128] Sul modo propositivo di intendere il fallimento come mancata restaurazione dell’ordine a discapito della differenza si veda l’interpretazione del pensiero butleriano proposta da Athanasiou: J. Butler, A. Athanasiou, Spoliazione…, cit., p. 115.
[129] J. Butler, The Force of Nonviolence…, cit., p. 175.
[130] «Queste forme di solidarietà non si basano sull’identificazione con il leader, ma su una dis-identificazione che opera sotto il significante “vita” senza essere per questo riduttivamente vitalista: tale significante sta per un’altra vita, una vita futura», ibid., p. 169.
[131] Cfr. ibid., p. 170.
[132] Id., Vite precarie…, cit., p. 124.
[133] Ibid., p. 62.
[134] Ibid.
[135] Id., The Force of Nonviolence…, cit., p. 176.
[136] Ibid., p. 177.
[137] Cfr. la nota 116.
[138] J. Butler, The Force of Nonviolence…, cit., p. 180.
[139] Dove per lei psichico e biologico vengono appunto a incontrarsi: cfr. ibid., p. 157.
[140] Id., Le corps inorganique chez le jeune Marx, in Deux lectures du jeune Marx, Editions sociales, Paris 2019, pp. 14-15 [trad. mia]. In Butler, il tema è di origine hegeliana e in quel contesto vi fa riferimento in Che tu sia il moi corpo (2010), tr. it. Mimesis, Milano-Udine, pp. 80-82.
[141] Id., Le corps inorganique chez le jeune Marx…, cit., p. 15 [trad. mia].
[142] Ibid., p. 16.
[143] Oltre al fatto che esso non pretende di giocare su un livello politico. L’unico tentativo svolto in questo senso rimane quello di inizio anni ‘20 quando l’autore berlinese si confronta con due conferenze di Erich Unger: cfr. E. Unger, Politica e metafisica. Tentativi filosofici in politica (1921), tr. it. Cronopio, Napoli 2008.
[144] Uno spunto si trova nel testo freudiano su cui più lavora Butler in The Force of Nonviolence, cioè Il disagio della civiltà: S. Freud, Il disagio della civiltà (1929), in Id., Opere. 1924-1929, tr. it. Boringhieri, Torino 19802, vol. X, pp. 581-582.
[145] L. Bernini, F. Zappino, Quale futuro per il soggetto queer…, cit., p. 225.
[146] Cfr. J. Butler, The Force of Nonviolence…, cit., pp. 162, 165. Butler ritorna così ex abrupto a un concetto tutto moderno a cui fa riferimento senza rielaborarlo concettualmente.
[147] Ibid., p. 176.
[148] A. Öcalan, op. cit., p. 426.
[149] Ibid.
[150] W. Benjamin, Sul concetto di storia (1940), in Opere complete. VII. 1938-1940, Einaudi, Torino 2006, p. 485 (VI tesi).
[151] La figura del despota non è altro che una concrezione particolare: «Il tiranno, dopo tutto, è un antropomorfismo sostenuto da reti di potere», J. Butler, The Force of Nonviolence…, cit., p. 168.