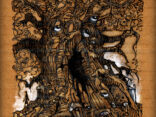Autore
Mariangela Caporale
Università degli studi di Napoli
insegna Bioetica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
Indice
- Premessa
- L’ausiliare potere
- La natura dei diritti
- Morire: un nuovo diritto?
S&F_n. 01_2009
Per questo gli uomini muoiono, perché non hanno la forza di ricongiungere il principio alla fine.
(Alcmeone, VI sec. a.C.)
- Premessa
“Diritto di morire” è un’espressione che non smette di imporsi alla mia riflessione come espressione di inciampo: essa è evidentemente ‘nuova’ ma la sua novità ha l’invadenza del mai prima a ora concepito e la difficoltà che è propria di tutto quello che esige, da un certo momento in poi, di diventare pensabile, di essere pensato e giustificato razionalmente.
Molto si è scritto intorno alla natura euristica delle tecnologie e delle tecnologie applicate alla vita umana: il progresso biomedico ci mette nella condizione di valutare la specificità morale delle proprie applicazioni, inaugurando uno spazio di interrogazione davvero originale, interrogazione che da subito ci impone di considerare la presunta produttività, da parte dei saperi biotecnologici, di diritti mai prima d’ora considerati tali. Invenzione del bene morale, creazione di diritti da quel nulla che è il loro non essere ancora pensati come diritti. È l’impensabilità propria di contenuti intorno ai quali le biotecnologie consentono di porre la domanda di senso, fino a spingerla nella dimensione dell’assolutezza e della fondatività che è propria del diritto.
- L’ausiliare potere
Prima ancora di proporre una riflessione sulla presunta creatività morale delle biotecnologie, credo sia utile fermarsi a esaminare una questione per così dire preliminare.
Bisogna riconoscere che non è immediatamente dato come contenuto problematico il fatto che il progresso della medicina e delle biotecnologie ci interroghi sull’equivalere o meno delle possibilità applicative dei risultati scientifici con il contrassegno morale che a questi da molti è ritenuto intrinseco. Vale a dire che il poter compiere determinate azioni soprattutto nei confronti della vita umana attraverso tecniche specifiche che ne modificano la natura ‘data’, non per tutti è oggetto di confronto col potere di ordine morale che a molti, invece, sembra semplicemente consequenziale alla mera effettività della tecnica.
Un verbo ausiliare che tiene in serbo la ricchezza della sua ambivalenza: posso tenere in vita indefinitamente un malato che versi in condizione comatose. Posso determinare la fecondazione umana nonostante la sterilità o l’infertilità di una coppia. E così via. Cosa intendo dire quando dico ‘posso’?
Il verbo può descrivere l’agire causalistico e il suo medium, che è la tecnica, la quale traduce la conoscenza teorica in azione pratica. In questo caso potere è un verbo usato per indicare la messa in atto di conoscenze trasformative del dato di natura attraverso strumenti e mezzi messi a punto e dunque capaci di tale mutamento dell’oggettività naturale. Posso, ossia sono nella condizione di compiere una determinata azione, il cui contenuto mira a superare il limite dell’ordine naturale.
In questo caso è definito come limite ciò che, prima dell’avvento di ogni forma di potere tecnologico, era considerato la trama delle leggi che danno corpo al reale, il modo di costituirsi della corporeità fisica e, dunque, il sistema che costituisce l’identità propria del mondo fenomenico, la sua ragion d’essere, non certo il limite, a meno che per limite non si intenda il termine di definizione del reale stesso, il suo spazio di determinazione. Limite che è taxis, ordine scritto secondo la lingua dell’oggettività, ordine matematico, dunque, che vale l’identità del mondo, la sua struttura effettiva, il suo poter essere esperito, il suo essere natura.
L’identità, dunque, è la determinazione del reale, il suo venire a essere secondo la specificazione dell’essere che non è ancora qualcosa; l’identità è la riconoscibilità di tutto ciò che è, riconoscibilità che dipende dall’uguaglianza di sé con se stessa di ogni realtà e dalla necessità che tale uguaglianza di sé con se stessa debba mantenersi tale, che sia, cioè, immutabile. L’immutabilità dell’essere così di tutto ciò che è, implica che tutto ciò che è, non possa essere altrimenti affinchè possa essere. Essere esige essere se stesso, e l’essere se stesso, l’essere così, implica il non poter essere altrimenti. È il così, necessario al poter essere di tutto ciò che è, il così necessariamente immutabile di ciò che è per il fatto che è se stesso.
La scienza, e la tecnica che ne è il logos, possono conoscere questa profondità, possono conoscere la causa dell’essere così e non altrimenti del reale naturale. Ma soprattutto possono mutare la legge che presiede all’identità del reale, legge che ne costituisce l’essenzialità e che garantisce l’oggettività di ogni conoscenza che chieda di essere considerata incontrovertibile perché ha questa legge per contenuto. La scienza e la tecnica possono conoscere e mutare la natura biologica, che più di ogni altra realtà è costretta entro le maglie della necessità poiché la natura è senza volontà, possono conoscere e mutare l’ordine delle cause che determina l’esserci sostanziale, la mera presenzialità di ogni realtà e di ogni fenomeno che la esprime. La scienza e la tecnologia smentiscono l’immutabilità della legge di natura e l’incontrovertibilità della sua oggettività, traducendo proprio quanto è stato concepito come legge del reale fenomenico in termini di limite e di limite relativo alla scienza che giunga a considerarsi tale tecnologicamente. Potere trasformativo della trama causale, potere che è semplicemente tale, possibilità che si realizza, secondo la sua propria intenzione. Superamento del limite, superamento che è neutro agire, passaggio dal ‘saputo’ al ‘realizzato’, che non significa e chiede di non significare, sapere che si traduce tecnologicamente e che, per questo, non ha altro senso che il suo accadere, meccanico divenire effetto di una causa, effetto metamorfotico del ‘dato’ naturale perché effetto di quella causa che è la scienza, la quale sa come ciò che è ‘dato’ è così e sa come mutarlo, sa come farlo essere altrimenti.
Ma un’azione indifferente nei confronti di ciò verso cui è diretta può mantenersi nella sua neutralità soltanto rispetto a quella parte della realtà verso cui è diretta che non è consapevole del suo essere in gioco, del suo venire a mutare, del suo essere non solo trasformata ma del suo essere trasfigurata.
Potere conoscere e modificare il dato di natura è altra cosa quando questo potere è compreso come tale, e ancora di più quando tale potere riguarda la vita umana.
Comprensione che può rimanere semplice constatazione: in questo caso l’atto a cui pone capo la scienza biotecnologia è considerato ‘dato’ come ‘dato’ era il fenomeno naturale che essa scienza ha mostrato di modificare, di sottrarre a questa datità. Molti sono coloro che constatano: si sa che la scienza è nella condizione di conoscere e che la sua conoscenza conduce a trasformare, ma questo sapere non va oltre se stesso. Si potrebbe credere che tale constatare non implichi alcuna curiositas morale, nessuna domanda di senso. E, va da sé, neanche risposte, come se il semplice rendersi conto del potere, causalisticamente tale, della scienza e il lasciare che essa sia tale potere, non tenga in sé un giudizio, non contenga una convinzione. Io credo che non sia così. Il semplice constatare, che si mantiene nella convinzione di valere come sapere puro e semplice e che non si apre alla domanda che chieda conto alla scienza di sé, risponde alla posizione secondo la quale ciò che la scienza sa e ciò che essa è in grado di fare è per se stesso buono: essere in grado di compiere determinate azioni implica che esse debbano essere compiute: il passaggio è immediato, senza pausa interrogativa, ma questo non vuol dire che tale passaggio non sia dichiarativo di una valutazione morale. Si deve perché si può. In questo caso il potere della scienza e della tecnologia ha la stessa consequenzialità della legge di natura: scienza e tecnica ereditano l’oggettività immutabile del ‘dato’ di natura che esse possono mutare, la causalità efficiente e meccanicistica che lo regola, l’irreversibilità. La natura ha ceduto la necessità delle leggi del suo accadere alla scienza che sa mutare queste leggi. La natura ne è stata svincolata, mentre la considerazione del potere della scienza come un non-poter-non, consegna la scienza al determinismo naturale che essa è nella condizione di contraddire!
Ma potere è verbo che conduce anche altrove. Non a tutti, infatti, sembra così autoevidente la spontaneità necessitante della possibilità tecnologica: non è immediato il corrispondere del potere causalistico e procedurale col potere morale. Posso ma non per questo devo. Posso anche non voler potere. La linearità immediata che è del constatare è interrotta dalla libertà che chiede di valere ancora come miracolo nel mondo dei fenomeni - secondo l’efficace espressione kantiana -, essa che è tale perché decide e si separa dal determinismo naturale, libertà che proprio per questo è ragione d’identità dell’umano, identità in divenire, identità senza ‘natura’. La libertà ci restituisce l’atto del ‘potere’ come atto difficile: posso ma posso anche non potere. La distanza tra la possibilità tecnologica e quella morale sussiste ed è segnata dalla libertà. È distanza che si apre con l’interrogazione mossa dall’esigenza del significato: il potere biotecnologico deve attraversare il vaglio della domanda di senso, deve presentarsi al cospetto della libertà, perché essa è il primo potere, il potere di decidere, che accade nella pausa del riflettere, nell’interruzione del pensiero. Il potere biotecnologico deve potersi sapere anche come impossibile.
La libertà che chiede conto alla scienza del perché del suo potere agìto come tale, ossia automaticamente possibile, può a sua volta rendere impossibile questo potere, può rendere impossibile la possibilità più possibile, quella possibilità che, assunta in questi termini, è già ormai una necessità.
Quando invece le biotecnologie diventano oggetto del pensiero critico e interrogativo, quando costituiscono un appello alla decisione, esse valgono ad ampliare l’orizzonte dell’identità umana, contribuiscono al suo divenire tale perché la libertà, che ne è l’essenza, accade come interposizione tra la natura data e la natura mutata, tra la prima e la seconda natura e il suo essere in entrambi i casi semplice destino. Ed è allora che comincia a porsi la questione dei nuovi diritti.
- La natura dei diritti
Ho detto da subito che la novità contenuta nell’espressione ‘nuovi diritti’ riguarda prima di tutto la loro concepibilità: in passato il contenuto di quelli che oggi si definiscono come diritti non solo non era pensato in questi termini, ossia come diritto: esso non era nemmeno pensabile. Mi spiego. Cinquant’anni fa non si poteva ritenere che la maternità e la paternità costituissero un diritto perché la ragione che oggi consente di definirli in questi termini è data dalla possibilità propria delle tecniche di fecondazione assistita e cinquant’anni fa questo potere biotecnologico non esisteva: la maternità e la paternità erano un ‘dato’ naturale, come un ‘dato’ naturale erano l’infertilità e la sterilità. Potere che consente alle biotecnologie di mutare questi ‘dati’, il loro essere così e non altrimenti: potere che, solo laddove sia immediatamente lasciato essere, capovolge l’ordine naturale e la sua immutabilità. E questo capovolgimento rende ‘naturale’ il ‘dato’ mutato.
La naturalità vale come ragione del suo essere considerata contenuto di un diritto. Diritto naturale, dunque, nuovo giusnaturalismo.
Mi chiedo se il contenuto del diritto che è definito naturale possa essere deciso, se, cioè è possibile scegliere di prescinderne. Credo che la risposta a questa domanda dica l’essere ‘naturale’, ossia l’incontrovertibilità di un contenuto che proprio per questo ha lo statuto di un diritto. Sappiamo che la tradizione giusnaturalista ritiene che proprio l’evidenza immediata e intuìta del suo valore costituisce la ‘naturalità’ del contenuto del diritto e per conseguenza la sua assolutezza, la sua imprescindibilità. Dato e constatato è il diritto naturale. La questione, dunque, riguarda la verosimiglianza della conclusione intorno alla giusnaturalità delle biotecnologie.
Se alla applicazione delle tecniche messe a punto dalla scienza per intervenire sulla vita biologica e modificarne l’identità naturale, si attribuisse una legittimità di fatto, si affermerebbe che questo potere biotecnologico ha valore per se stesso: ma un giudizio di questo tipo, che rinunci a confutare la bontà che si presume intrinseca a questo potere, è un giudizio insostenibile, che porta in sé le ragioni della sua inconsistenza, della sua irrealtà. Qualunque sia la matrice ideale e filosofica che giustifica l’esistenza di diritti cosiddetti naturali, ossia di diritti, la cui realtà dà forma all’identità umana, comune a ogni impostazione teorica è il tratto di oggettività che il contenuto di questi diritti mostra da sé e che, per questo, li rende indisponibili, fuori dallo spazio della libertà e della decisione. Per quanto si ritenga che il potere delle biotecnologie non debba essere posto in questione, non debba essere confrontato con il potere morale, per quanto si consideri che l’uno equivalga all’altro, secondo la formula classica per cui ciò che è tecnicamente possibile è moralmente giusto, per quanto dunque si tenti di dare alle biotecnologie la medesima autoevidenza morale che è del diritto naturale, sempre più appare chiaro che si tratta di difendere una posizione che, di autoevidente, ha solo la sua contraddittorietà. Incontrovertibile è soltanto l’effettività della procedura biotecnologia: non si può negare la capacità della genetica e della medicina di intervenire sui processi biologici mutando il loro corso cosiddetto ‘naturale’. Come indiscutibile è questa abilità così altrettanto indiscutibile è il suo carattere moralmente problematico. Se così non fosse le biotecnologie perderebbero il loro tratto più proprio, smetterebbero di valere come sapere ‘umanistico’. Questo vuol dire che esse, proprio per l’effetto rivoluzionario che hanno sulle dinamiche della vita biologica, proprio perché sono in grado di modificare il dato naturale, proprio perché contraddicono l’immutabilità oggettiva della legge di natura, sono generate dalla libertà. E questo dà conto del loro costituire un sapere e un potere propriamente umanistico. La conseguenza di questa genesi delle biotecnologie è che esse devono dar conto della libertà umana che le ha poste in essere: le biotecnologie sono per sé stesse oggetto di interpellanza e così esse accrescono la consapevolezza della libertà come ragione d’identità dell’umano.
La mia riflessione, dunque, vale a considerare il non equivalere della possibilità che la tecnica mette in campo per mutare i processi naturali di vita e di morte con la definizione di queste possibilità come diritti. Una consequenzialità di questo tipo si regge sull’esclusione dall’agire biotecnologico della dimensione di quel domandare che mira al discernimento e alla valutazione, al giudizio e alla decisione, atto che realizza compiutamente la ragione umana, la quale non è soltanto mezzo di conoscenza, ma anche e soprattutto condizione di inveramento della libertà.
Perché le possibilità garantite dalle biotecnologie vengano considerate contenuto di diritto devono costituire l’oggetto della ragione etica.
- Morire: un nuovo diritto?
Tra quelli che si definiscono come ‘nuovi diritti’ il diritto di morire si segnala davvero come autenticamente nuovo. Perché difficile da restituire alla razionalità morale non è la novità in quanto tale, quanto piuttosto il riconoscimento dello statuto di diritto a un contenuto che è sempre stato considerato come realtà di negazione del diritto.
Non si può affatto mettere in discussione che l’unico diritto assolutamente tale, in relazione al quale si può definire ogni altro diritto è il diritto alla vita e alla sua difesa. Nessun diritto può essere formulato se non in relazione a questo diritto che è fondativo di ogni altro. Non è possibile mettere in discussione il diritto alla vita senza mettere in discussione la possibilità stessa del diritto. Il diritto alla vita e alla sua difesa è l’unico diritto propriamente tale. Può essere oggetto di discussione e avere carattere positivo il contenuto di ogni altro diritto, anche di quello che ci sembra abbia la stessa imprescindibilità del diritto alla vita. In realtà anche il valore che riconosciamo come intrinseco ad altri diritti è tale solo perché relativo al diritto alla vita.
Il ‘diritto nuovo’ che è il morire può essere definito come diritto solo in relazione ai risvolti del progresso biomedico. Si tratta di riflettere sulla morte in relazione al perfezionamento delle tecniche rianimative e in relazione al differimento della morte stessa, per il quale queste tecniche sono applicate.
Se è possibile, come è possibile, prolungare artificialmente la vita di un malato, se è possibile allontanare nel tempo il momento del morire, se, meglio ancora, quel momento non è più tale, perché l’opera delle macchine o la cura farmacologica consentono che il morire sia un processo che si distende nel tempo, piuttosto che un istante imprevisto e irreversibile, allora la scienza medica muta profondamente l’esperienza della fine della vita, perché anche in questo caso essa è nella condizione di intervenire sulla sua ‘naturalità’. In che modo questa possibilità della medicina e della tecnica è produttiva dell’idea di diritto in relazione al morire? È tecnicamente possibile mantenere in vita artificialmente un individuo ma, ancora una volta, è posta la domanda che chiede se questa possibilità della tecnica sia per ciò stesso moralmente accettabile. Proprio perché sottratta all’imperscrutabilità e all’immediatezza, alla spontaneità e alla imprevedibilità, proprio perché non più naturale, la morte può anche essere programmata. La formulazione del diritto di morire dipende dall’uso delle macchine e da quello delle terapie farmacologiche che consentono di evitare che la morte accada secondo il tempo che la natura ha fissato per il suo accadere. Si può decidere il tempo del morire, non certo il morire stesso. La scienza offre i mezzi per prolungare la vita laddove sussistano condizioni di inguaribilità. Ma la cura di colui che la scienza sa di non poter più guarire comporta al malato sofferenze grandissime. Così anche la sopravvivenza di un individuo che continua a vivere grazie alle macchine comporta una dipendenza essenziale dalla macchina stessa sia che questa sostituisca le funzioni vitali sia che le sostenga, laddove esse siano compromesse. Questi due scenari esistenziali rivelano come a mutare non sia il morire in sé ma il tempo del suo accadere e che questo cambiamento ha comportato la messa in discussione della fondamentalità del diritto alla vita perché essa, nelle condizioni descritte, può essere non riconosciuta come bene in sé: le condizioni nelle quali è vissuta sono considerate ragione di definizione della vita stessa e, di rimando, del suo stesso valore. Le biotecnologie mettono nella condizione di poter non morire nel momento in cui naturalmente si morirebbe. Dunque, conseguenzialmente, si può decidere di procrastinare questo momento o decidere di lasciarlo essere secondo i suoi tempi naturali. Una possibilità che trasforma il dato naturale, la sua destinalità: ho ritenuto precedentemente di sottolineare come non possa essere negata alla libertà umana ciò che la costituisce come tale, ossia la sua ragione etica; per questo ho più volte dichiarato che è evidente non solo che la tecnica non è per se stessa morale, che la possibilità procedurale non risolve in sé l’interrogazione etica, ma che essa esprime il suo valore solo laddove solleva domande di senso. Dunque nemmeno nel caso del morire differito, del morire tecnologico possiamo evitare di porre queste domande: il diritto di morire non è giustificato dalla tecnica: esso può trovare ragioni per sussistere come tale solo di fronte alla risposta che si dà alla domanda sul significato dell’affermazione della morte come diritto.
E questa domanda può essere posta solo quando la vita per se stessa smette di essere un diritto e comincia a esserlo il modo in cui essa è vissuta.
Dico da subito che la morte non è un diritto. E non lo è perché il diritto è tale in quanto condizione necessaria dell’espressione di sé della vita. Lo abbiamo detto che uno solo è il diritto assolutamente tale, ed è il diritto alla vita. La morte non può essere un diritto perché mette fine a ciò per cui il diritto è tale. Sono consapevole dell’ambiguità dell’espressione ‘diritto alla vita’: una cosa è il diritto che riconosce valore assoluto alla vita già nata, altra cosa è il diritto che si attribuisce alla possibilità di scegliere che la vita nasca indipendentemente dalla legge naturale, o più ancora, oltrepassandola. Ma, sebbene non sia questo il contesto per discutere le ragioni di questa evidente differenza, pure bisogna dire che il diritto che riguarda la vita, comunque sia inteso, è diritto ‘dell’inizio’: il diritto è tale in quanto esplicita la libertà come potere creativo e, dunque, esso non può che essere sempre diritto alla vita.
Sia che si riferisca a colui che è già nato ed è nato, diciamo così, ‘naturalmente’, sia che si riferisca all’atto biomedico che fa essere la vita indipendentemente e nonostante le dinamiche e le regole della natura, in entrambi i casi siamo di fronte all’idea di diritto applicata a una realtà che, nel primo caso, è e vuole continuare a essere o, nel secondo caso, che non è e vuole venire a essere.
Al contrario, le espressioni ‘diritto di morte’ o ‘diritto di morire’ si riferiscono al non essere più, sia che si riferiscano all’atto eutanasico transitivo e diretto, sia che si riferiscano alla scelta della sospensione della cura a cui seguirà inevitabilmente la morte. Il morire e la morte non sono diritti, perché definire diritto il non essere più è intrinsecamente e incontrovertibilmente contraddittorio, ma di una contraddittorietà non solo logico-razionale o etica e spirituale, ma soprattutto reale, semplicemente ed evidentemente reale. Il diritto riguarda solo la vita che vive e vuole vivere. La morte ne è la contraddizione compiuta, l’antitesi perfetta.
Se morire non è un diritto, morire con dignità può esserlo. Ma la parola dignità è scivolosissima. Si può ritenere legittimo chiedere che si riconosca alla persona il diritto di morire con dignità perché la vita per se stessa è considerata ragione di dignità: essa non è attributo del vivere ma equivale al vivere stesso, non si aggiunge alla vita ma le è medesima: in questo caso morire con dignità vorrà dire prima di tutto decidersi per non sottrarre al malato le condizioni mediche utili affinché la vita finisca senza che le siano sottratte i mezzi necessari per essere tale. Se le macchine consentono di alimentare un malato, esse sono essenziali a custodire la vita di questa persona e perciò stesso la sua dignità.
Laddove si pensi invece che siano i modi del vivere la condizione per riconoscere alla vita la sua dignità, se cioè la dignità si aggiunge alla vita, nella misura in cui essa è vissuta nei modi e nelle forme che si ritiene diano valore alla vita stessa, valore che è, per così dire, ‘aggiunto’, allora per consentire al malato di morire con dignità bisogna scegliere di intervenire sui modi e sulle forme che rendono impossibile al vivere l’attribuzione del valore utile a definirla degna.
Morire con dignità, l’espressione che sembrerebbe condivisibile indiscutibilmente, vera ‘naturalmente’, mostra di esigere necessariamente il confronto e il dialogo perché questa espressione è anfibolia che dà ragione dell’evidenza equivoca propria della definizione, in termini di diritto, del morire con dignità e questo perché ciò che, in relazione alla dignità del morente, è definito come il diritto di morire, è in realtà l’affermazione piena del diritto alla vita.
Che sia questo il nodo gordiano da svolgere e risolvere lo dimostra il tentativo articolato di dare assetto giuridico alla questione. Non mi riferisco all’affermazione del diritto all’informazione e al consenso ai trattamenti medici, quanto piuttosto alla valutazione della proporzionalità delle cure rispetto ai benefici della persona malata e alle direttive anticipate che ciascuno può indicare per il proprio trattamento medico, nel caso della perdita della capacità di intendere e di volere. Dare risposta al diritto di morire con dignità vuol dire discutere delle ragioni che portano a giudicare proporzionato o meno un qualunque trattamento che tenga in vita un malato terminale. Così come vanno discusse le ragioni che inducono a decidersi per il futuro possibile della propria vita laddove ci si prefiguri un evento di malattia che ci sottrae consapevolezza e capacità esplicita di autodeterminazione.
Io ritengo che sia ragione difficile quella che prova a definire i termini di entrambe le questioni risolvendole nell’universalità della legge. La difficoltà è legata all’ambivalenza del giudizio sulla vita e sulla sua dignità, ambivalenza che mostra il rischio straordinario della libertà della ragione, potendo essa evocare la polivocità del significato che si traduce nella debolezza inevitabile delle soluzioni giuridiche relative alla scelta del tempo del vivere o del morire.
Davvero la legge può risolvere la decisione sulla morte e includere nella sua trama il vero e il bene a cui la libertà di ognuno prova incessantemente a dare corpo? Certo la legge che tenta risposte alla domanda sul tempo del morire e del vivere, tempo trasfigurato dalla medicina e dalla sua tecnologia, serve ad arginare la misura insondabile della libertà, per sostituire l’inquietudine della ragione irrisolta della vita, nella quale la libertà accade e alla quale, dunque, essa appartiene, con la serenità a cui porta la decisione e la regola, senza però che la profondità della ragione del morire e del vivere possa essere attraversata e compresa dalla decisione e dalla regola che la realizza. Opportuno sarebbe, in definitiva, che, se anche una legge fosse scritta per dare conto della questione del morire difficile, del morire tecnologico, il legislatore e il cittadino fossero consapevoli di questa costitutiva debolezza giuridica e, a partire da questa consapevolezza, sarebbe necessario che una legge di questo tipo fosse scritta con leggerezza, la leggerezza che distingue l’umiltà feconda di chi riconosce l’indisponibilità del vero dalla prepotenza grottesca di chi si illude di possederne la ragione.
Così il corpo non è più follia (Platone, Fedone, 66b-67a), non ci separa dalla verità, ma vissuto fino all’estremo limite che alla vita è dato, corpo vissuto e non pensato, attraversato nella sua anatomia mortale dal dolore e dalla malattia, conteso dall’idea di ognuno e dalle sue ragioni, costretto nelle soluzioni della legge, il corpo sfugge dalla sua materialità problematica, che è oggetto della scienza come della filosofia e del diritto, e appare esso stesso come l’indeducibile verità della vita.