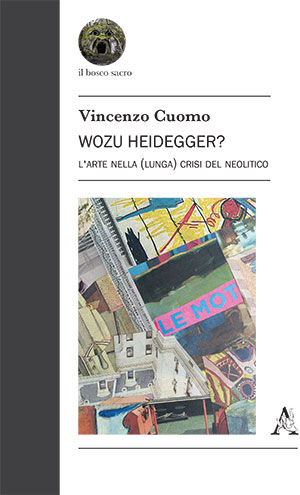Romano Gasparotti
L’opera senza mondo. Interrogazioni e riflessioni su Wozu Heidegger? di Vincenzo Cuomo
- Heidegger nostro contemporaneo?
- Intrecci aporetici dell’ultraontologia
- Il mondo è dell’uomo
- La verità dell’opera d’arte
- Heidegger nostro contemporaneo?
Il libro Wozu Heidegger? di Vincenzo Cuomo ha, innanzitutto, il pregio di riaprire la discussione su un saggio heideggeriano – frutto della rielaborazione, pubblicata nel 1950 nel volume Holzwege, di una serie di conferenze sull’arte tenute dal filosofo tedesco nella prima metà degli anni ‘30 – che, da qualche tempo, sembrava addirittura caduto nel dimenticatoio. L’origine dell’opera d’arte, dopo il progressivo scongelamento della filosofia heideggeriana iniziato in Europa negli anni ‘60, aveva riscosso una grande fortuna soprattutto negli anni ‘80 e ‘90, da una parte presso gli studiosi di estetica e, più in generale, presso coloro che avevano fatto di Heidegger una sorta di bandiera della filosofia detta continentale in contrapposizione con gli indirizzi analitici in prepotente ascesa e, dall’altra, in special modo nel nostro Paese, presso gli ambienti dell’arte, dell’architettura e addirittura delle scienze e tecnologie della costruzione (Cfr. R. Gasparotti, Abitare, pensare, fare. Sul dialogo tra prassi filosofica e prassi architettonica dagli anni ‘70 agli anni ‘90, Roma 1992) affascinati dalla tesi, ivi sviluppata, secondo la quale l’arte è il porsi in opera della verità. Dopodiché, con l’inizio del nuovo millennio, l’interesse degli studiosi e degli accademici nei confronti della filosofia di Heidegger in generale si è andato via via intiepidendo e di quel saggio in particolare quasi non si è più parlato sia a livello di filosofia estetica sia nel mondo dell’arte. È come se la sentenza derridiana secondo la quale il saggio si inserisce a pieno titolo nel ciclo di quelle «grandi narrazioni sull’arte» (J. Derrida, La verità in pittura, Roma 1981), che hanno caratterizzato la modernità post-settecentesca, unita alla non incoraggiante constatazione del fatto che l’opera artistica più recente a cui si riferisce espressamente il filosofo tedesco è quella di Van Gogh, avesse finito per relegare l’heideggeriana Erörterung ed Erläuterung sull’arte al di qua dei margini delle questioni cruciali del contemporaneo. E invece il libro di Vincenzo Cuomo rilegge non solo quel saggio, ma a partire da esso, l’intero complesso della galassia del pensiero heideggeriano, proprio nella luce del contemporaneo e a partire dalle problematiche urgenti, tanto filosofiche quanto artistiche, che maggiormente stanno a cuore all’autore.
- Intrecci aporetici dell’ultraontologia
Wozu Heidegger? dipana un paziente e rigoroso lavoro ermeneutico, che si realizza in una “esposizione” – secondo l’accezione plotiniano-porfiriana del termine – della filosofia heideggeriana dalle marcate componenti decostruttive, la quale sfocia in una sorta di riappropriazione dal carattere postproduttivo.
Molte e di peso sono le questioni sollevate e discusse. Ci soffermeremo, in quest’occasione, sulla costellazione tematica più rilevante, ovvero sul nesso tra l’heideggeriano progetto ultraontologico, il senso della verità, la Tecnica e il destino dell’opera d’arte.
Il filosofo tedesco intese ripensare – inizialmente attraverso la riappropriazione e radicalizzazione del metodo fenomenologico appreso dal maestro Husserl – l’Essere, al di là tanto della sua declinazione onto-teo-logica, che la tradizione occidentale dominante ha finito per identificare al Summum Ens, nell’oblio della “differenza ontologica”, quanto di ogni forma di neoparmenidismo, ovvero la via coraggiosamente intrapresa da Emanuele Severino a partire dagli anni ‘50, proprio in un serrato confronto con l’Überwindung heideggeriana e l’attualismo gentiliano (Cfr. E. Severino, Heidegger e la metafisica, Milano 1994).
Innanzitutto, Cuomo rileva, nei modi attraverso i quali il filosofo tedesco ripensa il nodo metafisico-ontologico, un vero e proprio intreccio aporetico. “Essere”, infatti, a volte sembra indicare il proprium esistenziale della dimensione umana in quanto tale, ovvero l’orizzonte del Dasein, altre volte il “mondo simbolico”, nel quale e in virtù del quale l’Esserci, com’è scritto nella Lettera sull’umanismo, viene a ek-sistere, ovvero a proiettarsi fuori di sé e, altre volte ancora, l’assolutamente Altro in un’accezione kierkegaardiana. Inoltre, nel trattare l’avvento epocale della civiltà della tecnica, in quanto compimento della metafisica (omni e iper) onticizzante nei modi della Seinsvergessenheit, Heidegger, da un lato, afferma che «dell’essere non è più niente», mentre, dall’altro, continua a parlare di «epoche della storia dell’essere» e a considerare quella della Tecnica un’epoca destinalmente inviata dall’essere stesso. Infine, nella prospettiva dischiusa dai Beiträge e incentrata sull’Ereignis, quest’ultimo a volte sembra coincidere con l’essere ultrametafisicamente pensato e altre volte, invece, costituire l’arché dell’essere stesso, nel sostituirsi così di un’articolazione ternaria, se non addirittura implicitamente trinitaria, alla dualità ontologico-ontica essere/ente (p. 76 e sgg.).
La prospettiva ermeneutica assunta e applicata da Cuomo – che non vuole cadere in alcuna forma di problematicismo fine a se stesso – non intende stare nelle oscillazioni, ma si propone di risolverle, trasponendole nella linearità di un percorso il più coerente possibile non a livello meramente formale, bensì in relazione alla possibilità di saggiare l’eredità dell’elaborazione di pensiero heideggeriana nel campo delle tendenze non solo oltreumanistiche, ma anche post-antropocentriche, che stanno emergendo da qualche tempo nel dibattito filosofico contemporaneo. Pertanto, il punto di fuga heideggerianamente più congruente e fecondo, per non farsi vanamente risucchiare dall’aporia ultraontologica, sembra dischiudersi, per Cuomo, nel considerare la metafisica e la Tecnica non come oblio dell’essere tout court, bensì come dimenticanza – e non nientificazione – dell’essere in quanto pura arché possibilitante, ovvero come «l’oblio(…)della assoluta contingenza e imprevedibilità delle origini della Lichtung» (p. 77). Vale a dire nel senso della dimenticanza di ciò che Heidegger, nello scritto Vom Wesen der Wahrheit, presenta come “libertà” quale essenza della verità. Attraverso il compiuto globalizzarsi della Machenschaft insita nella Tecnica, di conseguenza, la metafisica, dalla quale il Ge-stell proviene, finisce per autonegarsi, come il filosofo tedesco afferma più volte, in virtù della irresistibile tendenza, da parte di ogni impresa tecnica, di ridurre, sino a colmare, qualsiasi forma di separazione e trascendenza più si procede nella realizzazione della tecno-natura a opera delle tecnoscienze. Ecco perché, ne conclude Cuomo, è proprio grazie al dispiegarsi della Tecnica – «là dove c’è il pericolo, cresce anche ciò che salva» (Hölderlin) – che possono maturare le condizioni epocali per un ritorno alle origini, il quale si annuncia quale “nuovo inizio”, nella misura in cui, da un lato, è immune da ogni astratta trascendenza e, dall’altro, lasciando emergere l’incalcolabile e il gigantesco, ovvero ciò che si sottrae a ogni misurazione e a ogni pianificazione, risveglia il senso purificato della verità come alétheia e mistero. Una volta coerentizzato il pensiero di Heidegger all’interno di tale prospettiva, ne conclude Cuomo, «l’essere sarebbe l’orizzonte di verità all’interno del quale gli enti vengono innanzitutto compresi» (p. 78). Il non abdicare di fronte all’aporia ontologica è affidato, dunque, al disobliarsi, in virtù del compiersi totalizzante della Tecnica, del senso della verità quale alétheia e mistero. L’operazione ermeneutico-attualizzante messa all’opera da Cuomo dà, così, il massimo risalto possibile al nesso cruciale tecnica-verità, nel quale è necessariamente implicata la questione dell’opera d’arte.
La prospettiva adottata risulta fortemente innovativa, rispetto alle interpretazioni più assestate del pensiero heideggeriano, nella misura in cui non considera l’heideggeriana “filosofia dell’arte” come un’applicazione o un corollario del ripensamento della metafisica, bensì come la principale via di accesso al nucleo più fecondo e attuale dell’intera Besinnung heideggeriana.
Rispetto a tutto ciò, se abbiamo ben inteso, poniamo innanzitutto due domande. La prima radicale: perché voler decidere a ogni costo l’oscillazione? E se essa costituisse la disposizione della potenza naturale stessa del pensare, nonché ciò che immerge quest’ultimo nelle variabili atmosfere della vita intelligente, al di là dell’esclusività dell’anima razionale e del mondo umano, troppo umano? (Cfr. R. Gasparotti, Le inafferrabili oscillazioni del fare. La caduta del pensare, 2019; e Id., L’immagine iconoclastica e l’assoluto mediale. Metafisica dell’interfacciarsi). E se il pensare, proprio in quanto sottratto alle sue costitutive e vitali oscillazioni, divenisse inevitabilmente un esercizio metafisico(secondo l’accezione negativa del termine), ovvero ipostatizzante, astrattamente diairetico, teleologico e ideologico?
La seconda domanda ha un carattere più specifico: siffatta linearizzazione degli ondivaghi sviluppi dell’Andenken hedeggeriano consente realmente e sino in fondo il portarsi oltre l’intreccio aporetico legato alla questione metafisico-ontologica? Chiariamo: se quello di alétheia in quanto Unverborgenheit è il movimento, perpetuamente rinnovantesi, attraverso il quale qualcosa viene a manifestarsi, ri-velandosi nel suo originario e costitutivo nascondimento, ciò che si manifesta e manifesta rivelandosi – e quindi ritraendosi nell’apparire di ogni essente manifesto – non è, per Heidegger, l’Essere stesso? È l’essere medesimo nella misura in cui si comporta attivamente come Soggetto onto-teo-logico originario, dal cui fare o non fare dipende la sorte degli enti mondani. E l’oscillazione, a questo punto, ricomincia. Infatti, per un verso, la verità come alétheia sembra concernere essenzialmente il Dasein, sia pure nella misura in cui esso è “ingaggiato” dall’Essere, senza esserne né il signore, né il produttore, bensì il medium investito del compito di assecondarne il manifestarsi, come si evince dal cosiddetto “primo Heidegger”. Per altro verso, come maturato in seguito alla “svolta” degli anni ‘30, essa appartiene propriamente all’Ereignis quale libertà dell’Ereignung. Con il conseguente riproporsi dell’indecidibilità della questione già rilevata da Cuomo: qual è il rapporto dell’Ereignis con l’essere e con il Dasein stesso?
L’elaborazione sviluppata in Wozu Heidegger? cerca di uscire dall’impasse riconoscendo che il limite generale della ricerca filosofica heideggeriana sta nel fatto che il filosofo tedesco è rimasto invischiato in una prospettiva legata all’«abitare una casa del linguaggio in grado di “dire” il “fuori”, in grado di trasporre (come direbbe Sloterdijk) il pericolo dentro la casa simbolica; perché la funzione simbolica non è stata mai altro che questa: quella di arginare il terribile e di “dire” l’indicibile. Ma forse, nell’epoca della Tecnica, sarebbe stato necessario portare avanti il movimento contrario» (p. 88). Ulteriori domande: tale movimento contrario, come accade in tutti i meri rovesciamenti, non condivide la medesima matrice di ciò che è rovesciato e non resta, quindi, comunque, un modo di dire ciò che non viene detto e di pensare il non pensato? E se, invece, l’intreccio ontologicamente aporetico lucidamente denunciato da Cuomo dipendesse dal fatto che Heidegger, nonostante gli sforzi evidenti, non è mai riuscito a liberarsi dai vincoli di un metodologismo logocentrico dal carattere metafisicamente, idealisticamente e teologicamente metaempirico, nonché aprioristicamente inferenzialistico? È nota l’enfasi che l’esperienza filosofica heideggeriana ha sempre attribuito al suo realizzarsi quale “cammino verso” una meta trascendente mai attualmente raggiunta e, in linea di principio, irraggiungibile, per quanto anticipata nella sua pura datità abscondita dalla prospettiva intenzionalmente scopica e pre-veggente di un pensante-essere-pensato, che, in fondo – nonostante le velleità heideggeriane di sperimentare, in una certa fase, un pensare puramente poetante – mantiene, in fondo, tutte le caratteristiche discorsive e logico-semiotico-semantizzanti di quella che Benjamin aveva definito «lingua degli uomini» (Angelus Novus). Di conseguenza, quello di Heidegger resterebbe, sotto questo punto di vista, un sistema di pensiero metafisicamente umanistico e metafisicizzante – senza alcun ultra – nella stessa accezione del termine, che il filosofo tedesco aveva ricavato e rigorizzato a partire dalla sua lettura dell’opera di Nietzsche e pertanto profondamente affetto da quella che quest’ultimo aveva chiamato malattia. A tale proposito, il metodologismo fenomenologico non solo applicato, ma addirittura sbandierato dal cosiddetto “primo Heidegger” da un lato conferma in pieno ciò e, dall’altro, palesa, nel contempo, tutta la sua costitutiva impotenza nel cogliere l’Oggetto/Soggetto anticipato aprioristicamente e inferenzialmente sul piano metaempirico.
Se, inoltre, heideggerianamente il domandare costituisce la più profonda pietas del pensare, la domanda – prima e dopo la presunta Kehre – viene a essere posta come ciò che è dettato e guidato dalla Risposta originariamente domandante, nonché da sempre e per sempre già data. La Risposta c’è già e attende nella trascendenza. E se anche, come scrive Heidegger «per la domanda fondamentale(…), l’essere non è una risposta né un ambito in cui rispondere, ma ciò che più di tutto è degno di domanda» (M. Heidegger, Contributi alla filosofia), ciò che è in primo luogo degno di essere domandato, da valorizzarsi «come ciò che non può essere mai in alcun modo dominato» (ibid.) non è, per l’appunto, questo o quel significato, bensì, nel senso trascendentale, il Significato di tutti i significati, ovvero l’equivalente dell’Idea platonica. O, se vogliamo, l’essere come sommo ente o super-ente metaempirico e trascendente. Non “l’ultimo Dio”, ma nietzschianamente Dio, il Dio della metafisica. Insomma, l’ontoteologia cacciata dalla finestra ritornerebbe per la porta principale, rendendo il filosofare di Heidegger l’ennesima nota a margine su Platone a ulteriore conferma della nota sentenza di Alfred North Whitehead.
- Il mondo è dell’uomo
L’esposizione attualizzante di Cuomo vuole uscire costruttivamente da ogni deriva aporetica e cerca di farlo utilizzando come chiave ermeneutica privilegiata le posizioni più recenti di Peter Sloterdijk, o meglio l’interfacciamento tra la filosofia di Sloterdijk e la teoria dell’iperoggetto di Timothy Morton. Le armi in questo caso utilizzate da Cuomo rischiano, però, di essere piuttosto spuntate. La sferologia di Sloterdijk, infatti, appare al di sotto della radicalità del pensiero heideggeriano, nel suo essere ancora esplicitamente incentrata sulle dinamiche metafisico-logicistiche legate dell’archiopposizione dentro/fuori, la quale per Nietzsche – la cui opera, non dimentichiamolo, costituì a lungo la palestra di pensiero di Heidegger stesso – è proprio uno dei contrassegni dell’ordine iperapollineo del cosmo metafisico, che non ha ancora conosciuto e metabolizzato la morte di Dio. Se quindi il simbolico – come riconosce Cuomo – consiste nelle pratiche del dire il fuori addomesticandone così il carattere inquietante e pericoloso, rovesciare la prospettiva, cercando di dire il dentro a partire dal fuori – oltre che testimoniare quanto già si è criticamente rilevato poc’anzi – sembrerebbe indicare proprio ciò che si ripropose di fare Heidegger dopo la presunta svolta: dire il Dasein e tutto il dicibile a partire dall’Essere stesso quale assolutamente Altro.
La prospettiva di Morton, a sua volta, se da un lato ha il merito di aver messo in luce l’impianto criticistico-kantiano caratterizzante il pensiero di Heidegger e di averne denunciato l’idealismo di fondo, sia prima che dopo la svolta, dall’altro propone come alternativa positiva il realismo di Graham Harman declinato nella nuova prospettiva degli iperoggetti. Come vengono definiti questi ultimi? «Non semplici costrutti mentali(o ideali), ma entità reali, la cui essenza ultima è preclusa agli esseri umani» (T. Morton, Iperoggetti, Roma 2018). Essi così «fungono da piattaforma per pensare ciò che Harman definisce oggetti in generale» (ibid.).
Vale a questo punto la pena di chiedersi: idealismo e realismo sono davvero prospettive alternative e reciprocamente escludentisi? Il realismo, al pari dell’idealismo, non è, forse, frutto del medesimo pensiero onto-teo-logico incentrato su un originario Supersignificante – il quale si rivela nascondendosi e ritraendosi – e totalmente dipendente da esso? Morton, oltretutto, usa il più tipico linguaggio metafisico, parlando espressamente di «essenza ultima dell’iperoggetto», la quale necessariamente sfugge a ogni umano coglimento e possesso, nella riproposizione di una prospettiva di pensiero, nella quale l’iperoggetto realistico viene presentato e definito come l’equivalente, solo un po’ più aggiornato linguisticamente, della Cosa in sé kantiana. E allora se, sin dall’inizio degli anni ‘50, Emanuele Severino, anticipando il rilievo di Morton, sosteneva che la metafisica heideggeriana era fortemente debitrice nei confronti della prospettiva criticistica kantiana, alla quale restava legata, potremmo concluderne che, più di cinquant’anni dopo, nemmeno il realismo di Morton si è liberato da tale ingombrante vincolo, nel suo fondare la teoria dell’iperoggetto su, per dirla con Severino, «un’inferenza che conduce a qualcosa di non appartenente alla totalità dell’essente originariamente manifesto e che dunque è inferenza metafisica, metaempirica» (E. Severino, op. cit.).
Anche rispetto alle questioni legate all’arte, che sono al centro del saggio heideggeriano L’origine dell’opera d’arte, Cuomo decide di dare pieno credito a Morton, sino al punto di esplorare sino in fondo l’ipotesi sollevata ancora dal filosofo inglese, secondo la quale se si eliminasse dal pensiero di Heidegger la concezione razionalistico-ontologica, che assegna il Mondo esclusivamente agli esseri umani, questa filosofia darebbe adito non solo a una inedita prospettiva onto-ecologica, ma anche alla comprensione e piena legittimazione di «buona parte delle più interessanti e avanzate sperimentazioni artistiche contemporanee» (p. 94).
Nel mettere così in risalto la natura profondamente ecologica dell’arte in quanto tale, come suggerito già nel 1970 da Gene Youngblood (Expanded Cinema, Bologna 2013), come ricorda Cuomo, il risultato sarebbe che «lo “spazio umano” risulterebbe necessariamente parte di interconnessioni parassitarie (simbiotiche e/o predatorie), per niente rassicuranti, ma che sono state, e sono, le condizioni (contingenti) della sua comparsa e sopravvivenza» (p. 102).
Il fatto è che, in e per Heidegger, la “partizione ontologica” tra l’avere un mondo, l’essere povero di mondo e l’essere senza mondo non solo c’è, ma svolge un ruolo imprescindibilmente fondante.
- La verità dell’opera d’arte
Ciò che riteniamo più interessate del percorrimento di questo classico ragionamento per assurdo sta, piuttosto, nel fatto che Cuomo, mettendo in luce ciò che molti interpreti heideggeriani anche assai autorevoli non hanno colto o non hanno saputo valorizzare, distingue, nel testo dell’Ursprung, tre momenti epocali dell’opera d’arte: quella sacra, quella sradicata e quella moderna. L’opera d’arte sacra è quella che sorge nell’età mitico-religiosa in quanto legata al senso dominante del sacer (che non è il sanctus). Il secondo momento è quello in cui l’opera si presenta sradicata «da tutte le sue relazioni con ciò che è diverso da essa, in modo da lasciarla requiescere su se stessa, unicamente per sé» (M. Heidegger, Holzwege). L’opera d’arte moderna, infine, è quella che si è lasciata definitivamente alle spalle, come perfectum, ogni legame con luoghi, mondi, significati, in modo da venirci incontro nella modalità dello Stoss, ovvero dell’“urto” senza violenza. Questa è la condizione dell’opera d’arte nell’epoca della Tecnica compiutamente realizzatasi su scala globale nella nientificazione dell’Essere. Una nientificazione, che – oltre Heidegger e malgrado Heidegger – non è, però, un accadimento epocale coincidente con un determinato periodo dell’umana storicità, ma un processo che si realizza e continuamente si rinnova grazie alla superpotenza dell’opera d’arte. L’arte, pertanto, non è epifenomeno, né mera conseguenza della nientificazione ontologica, bensì agisce come decisivo shifter della nientificazione stessa intesa quale processo sempre in corso d’opera.
E se fosse proprio questa la chiave d’uscita non solo dalle aporie ultraontologiche, ma anche da ogni forma di ontoteologismo metafisico? L’arte come mettersi all’opera della nientificazione dell’essere e quindi anche della sua metaempirica trascendenza attraverso gli effetti e gli affetti del lavoro di opere creative senza soggetto, senza oggetto, senza significato e senza mondo. E quindi anche senza più né dentro né fuori, dal momento che il dentro e il fuori sono sempre inerenti e relativi a un mondo. L’arte nel contemporaneo, in questa prospettiva, non sarebbe, quindi, altro che il porsi performativamente all’opera di un fare non poieticamente producente, la cui “urtante” potenza è analoga a ciò che Nietzsche aveva denominato nichilismo attivo. Un’arte che, quindi, non è poiesis. Né poiesis, né poietiké téchne. Ma solo pura praxis, prassi ritmico-poliritmante senza soggetto, senza oggetto e senza mondo, nel metamorfico e pulviscolante vibrare e pulsare della mixis. Una prassi per-formante – secondo il modello della musica e della danza (R. Gasparotti, L’amentale. Arte, danza e ultrafilosofia, 2019) – i cui urtanti processi non sono altro che accenti del puro ritmarsi e modularsi dell’energia di una Mescolanza priva di sé e priva di mondi, nell’oscillante continuità del possibile interfacciarsi di tutto con tutto, senza provenienza e senza destinazione alcuna.
L’arte, dunque, quale porsi all’opera della verità non già dell’ente, bensì dell’immagine nella sua intima natura iconoclastica e assolutamente mediale.
Romano Gasparotti
S&F_n. 25_2021