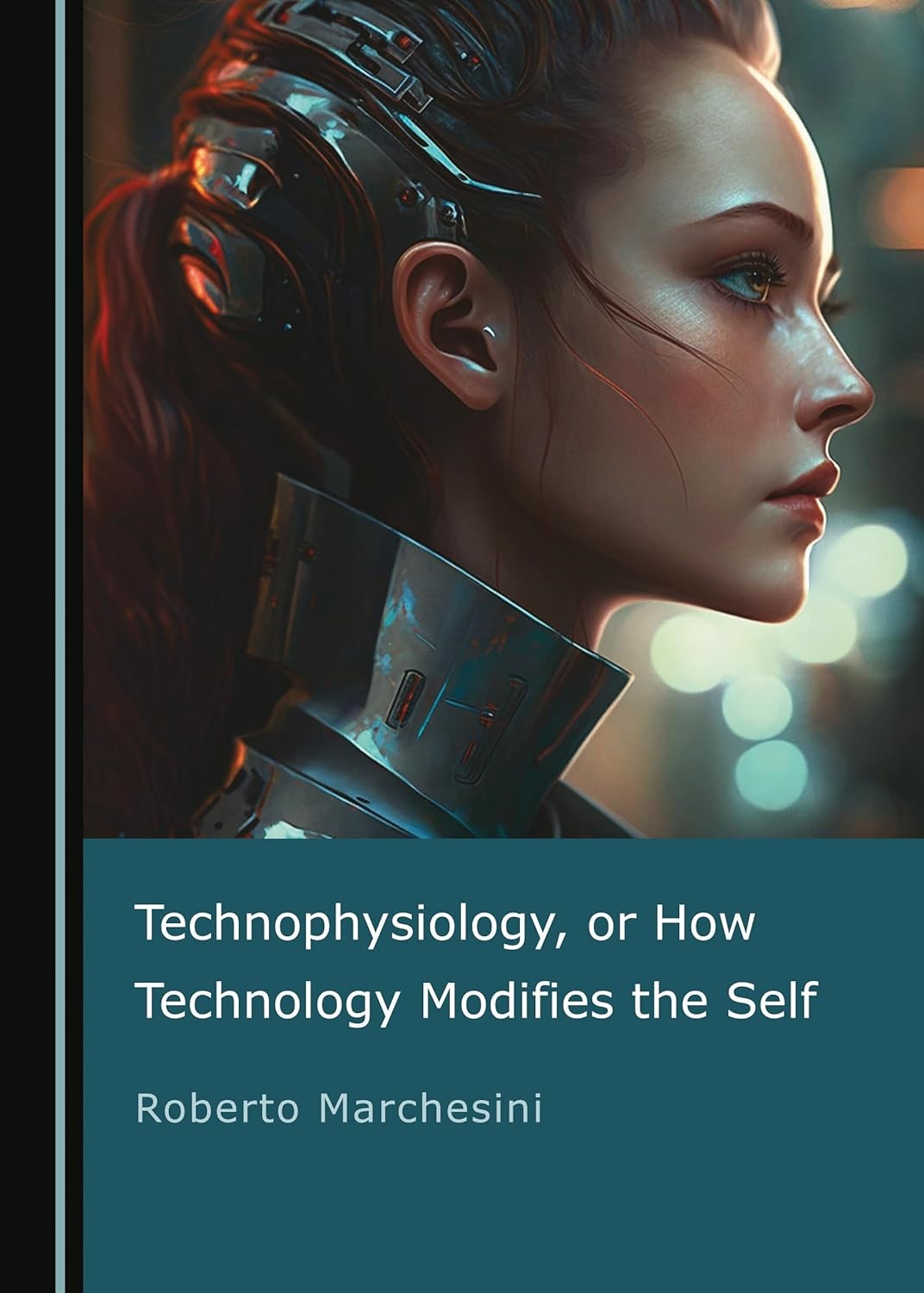La tecnologia non è un insieme di utensili, ma un sistema che modifica la nostra nicchia ecologica, ovvero cosa e quanto ci serve per vivere sul pianeta: relazioni (pure col pianeta) comprese. Anche un guanto quindi, sebbene sembri separato dalla mano, in realtà richiede una continua interazione con l’intero organismo e ne influenza la matrice biologico-cognitiva: s’infiltra nel corpo, viene somatizzato per entrare nella quotidianità. A partire da questi due assunti il filosofo Roberto Marchesini propone nel suo ultimo libro in inglese (Technophysiology or how technology modifies the self, Cambridge Scholars Publishing, pp. 242) una ‘Tecnofisiologia’, cioè lo studio del funzionamento del corpo umano ibridato con la tecnologia e i relativi impatti su identità e relazioni. L’obiettivo dichiarato è arrivare a una nuova filosofia della techné, che indaghi le implicazioni profonde dell’impatto tecnologico sul nostro esistere nel mondo: un compito che, scrive l’autore, non può essere assolto dalla science fiction. Nell’era dell’Internet of Things, ovvero dei chip inseriti negli oggetti per collegarli alla rete, e dell’Intelligenza Artificiale, ovvero delle tecniche di raccolta ed elaborazione di grandi quantità di dati attraverso algoritmi matematico-statistici, mentre la Food and Drug Administration ha autorizzato Neuralink, la startup di Elon Musk, a impiantare chip nel cervello umano, l’obiettivo è quantomai urgente.
Il volume si inserisce nel dibattito sul postumanesimo filosofico, di cui Marchesini con la sua ultratrentennale esperienza di ricerca è uno dei rappresentanti più autorevoli. Il postumanesimo filosofico, con accezioni diverse, si propone di andare oltre sia l’Umanesimo, inteso come ideale universale di uomo razionale e autosufficiente che esclude le altre soggettività, sia l’antropocentrismo, inteso non come punto di vista specie-specifico, ma come tendenza al dominio e alla supremazia di specie. L’immagine-simbolo dell’Umanesimo è l’uomo vitruviano, ideale di un’umanità autarchica, capace di realizzare la propria dignitas emancipandosi dai condizionamenti esterni grazie alla razionalità e al libero arbitrio, che la distinguono dagli animali e le consentono di usare tutti gli strumenti per realizzare la propria ontogenesi. Da questa concezione umanista per Marchesini deriva l’idea della tecnologia come rimpiazzo o potenziamento umano, e, soprattutto, quale strumento che si adatta al corpo.
In questo modello ‘classico’ il dispositivo è considerato come esterno al corpo, soggetto al controllo totale dell’individuo, creato per uno scopo specifico e usato per agire sul mondo in un’unica direzione. Ma, dimostra Marchesini in un intero capitolo del volume – il quarto – in realtà l’interazione è biunivoca: anche il dispositivo, sia uno smartphone o un chip o un vaccino o una tecnica di produzione del cibo (ad esempio, la pastorizzazione o la fermentazione), agisce sull’individuo: il «device come agente somatico» (p. 104) è proattivo perché cambia il range di possibilità di pensiero e di azione del soggetto; è cooptabile con canoni che vanno oltre quanto immaginato inizialmente nella programmazione; non si adatta completamente al corpo, ma costringe il corpo, plastico, ad adattarsi, modificandolo a livello metabolico (bioritmo), ontogenetico (crescita differenziale in tempi diversi) e filogenetico (cambiamento dei parametri di pressione selettiva che influenza la traiettoria evolutiva).
Oltre che dal corredo genetico, la traduzione epigenetica, le condizioni di sviluppo dell’embrione prima e del feto poi, i processi formativi dell’età dello sviluppo (specie sessuali), gli eventi importanti e traumatizzanti, la morfologia del corpo umano è determinata dalla nicchia ecologica di cui fa parte anche la tecnologia: «Ogni device è una macchina che costituisce il corpo, ne modella l’organizzazione individuale e funzionale, ne modifica la nicchia in modo sistematico» (p. 22). L’esempio di questo approccio eco-ontologico è dato dal rapporto tra il ragno e la propria tela: la ragnatela non è uno strumento con cui il ragno si adatta al mondo, ma la nicchia attraverso cui il mondo viene vissuto e adattato dal ragno. Il ragno agisce sulla tela che agisce su di lui, non solo in termini di possibilità di azione, ma anche in termini di proiezioni su cosa è a lui davvero accessibile. Seguendo questo esempio e la riflessione degli ultimi sviluppi delle scienze cognitive, sappiamo che conosciamo solo grazie e attraverso il nostro corpo in movimento, che co-costruisce l’ambiente esterno mappando lo spazio intorno a sé a partire dai cinque sensi, in particolare, nei primi anni di vita, dal tatto. La mediazione della tecnologia o tecnomediazione, spiega Marchesini, incide proprio sulla bolla prossemica intorno al corpo e si comporta come una nicchia che influisce sull’espressione fenotipica della nostra specie: modula e filtra le variabili ambientali, stabilizza in zone periferiche le fluttuazioni potenzialmente pericolose per l’equilibrio raggiunto, produce a propria volta fattori di variazione fenotipica. «Il movimento è dato dalla tendenza a proiettarsi in condizioni non ancora sperimentate. La tecnologia estende e modifica anche l’immagine del nostro corpo dello spazio» (p. 55): più si estende lo spazio delle potenzialità, ovvero lo spazio virtuale in senso proprio, più il nostro centro di gravità fisiologico e filogenetico sembra spostarsi fuori dal corpo. Lungi dall’essere una membrana fetale che ci protegge dalla contaminazione, come sostenuto dal filosofo Peter Sloterdijk, in questa visione la tecnologia è come l’aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, un sistema «che realizza disposizioni inerenti alla nostra natura» (p. 20). Come l’introduzione dell’abbigliamento ha cambiato il significato dell’essere nudi, così la metamorfosi della percezione (capitolo 2) operata da una innovazione tecnologica produce la creazione di un differente livello fenomenologico della realtà. Somatizzare un dispositivo, integrarlo dentro il corpo, comporta da una parte l’interiorizzazione di un nuovo standard di accesso e interpretazione del mondo, dall’altro la trasformazione dello stesso dispositivo in un organo relazionale, da cui dipendiamo per avere quel livello di connessione sociale di cui non possiamo più fare senza, a meno di non sentirci amputati.
Secondo la visione classica della tecnologia quale strumento, l’introduzione e la domesticazione di un nuovo dispositivo comportano un potenziamento umano, ovvero una riduzione dell’esposizione a variabili esterne pericolose, una diminuzione dei bisogni, una maggiore protezione da fattori disturbanti, una limitazione delle variazioni funzionali biologiche quindi un maggiore distacco dall’animalità, un aumento dell’immunità da fattori esterni e di disgiunzione dalla biosfera, con conseguente maggiore capacità emancipatoria e autarchica degli individui.
In realtà, spiega Marchesini, l’interiorizzazione di un nuovo standard tecno-sociale aumenta la dipendenza verso l’esterno e può anche accrescere le paure anziché eliminarle: il cambiamento richiede nuove e diverse funzioni all’individuo e aumenta la sua insicurezza e la sensazione di inefficacia e inutilità. Il corpo da una parte subisce la sempiterna accusa di essere inutile, segno dell’”uomo antiquato” di Günther Anders, perché mortale, animale, inabile ad adattarsi; dall’altra è sotto pressione per gli stimoli che la nicchia eco-tecnologica gli impone. Si arriva alla ridicolizzazione della dimensione somatica e al tentativo di abolirla attraverso la sostituzione delle componenti e delle funzioni indesiderate con controparti tecnologiche che consentano di eliminare il dolore e l’invecchiamento e raggiungere, in ultima analisi, l’immortalità: un ultraumanesimo derivato dalla concezione dell’uomo autosufficiente e dominatore del mondo che prende forma nelle dottrine filosofiche del transumanesimo. L’Antropocene che viviamo dovrebbe spingerci a ben altre considerazioni, e ricordarci l’estrema interdipendenza che lega la nostra specie alle condizioni biologico-ambientali.
E se l’identità è una costruzione basata sullo spazio esperienziale, quindi percettivo e operazionale, gli impatti della tecnologia come componente della nicchia ecologica sono evidenti (capitolo 5): l’identità prossemica, ovvero il nostro ‘essere con’, è sempre più digitale, quindi delocalizzato e dematerializzato. Come già sottolineato, l’esperienza è data non da una cognizione disincarnata (sul modello delle reti neurali artificiali), ma dal sistema corpo-mente in movimento, che esplora lo spazio intorno a sé coinvolgendosi emotivamente. Proprio il coinvolgimento emotivo-affettivo e i processi di attaccamento influenzano l’organizzazione coerente di memorie e di socializzazione ambientale: in che modo cambiano nell’era dello smartphone o del tablet come oggetto transizionale? Dopo i primi decenni di educazione sentimentale tecnomediata, sottolinea Marchesini, si nota una perdita di contatto con la natura, di fisicità nelle relazioni, una difficoltà a contestualizzare nello spazio e nel tempo nonché a rapportarsi con la materialità delle cose e con l’irreversibilità della termodinamica delle relazioni. Al contrario, si sviluppano atteggiamenti di «totipotenza funzionale» (p. 150) alla costruzione di ego staccati da aderenza alla realtà. L’esperienza diventata tecnoprassi (p. 152) sta portando alla disaffezione rispetto agli oggetti da possedere e maneggiare, all’esternalizzazione di alcune funzioni cognitive che diventano più facilmente tracciabili, all’inondazione di tracce del passato che influiscono sulla percezione del futuro, alla frammentazione dell’identità, ovvero della perdita del collante che tiene insieme le nostre esperienze. Una frammentazione che secondo Marchesini è dovuta agli effetti del disordine somatico dovuto al disallineamento tra le pressioni della nicchia tecnologica e il bioritmo dell’organismo: in un passaggio del volume particolarmente convincente, l’autore descrive il senso di naufragio digitale che le generazioni più anziane provano rispetto all’assenza di punti di riferimento spazio-temporali e alla perdita di controllo associate alla smaterializzazione, con impatti sul senso di appartenenza, di territorialità, sulla cooperazione come connessione emotiva. Più che aver raggiunto l’immortalità, mette in luce Marchesini, finora siamo circondati da «spettri digitali» (p. 170) come i profili social dei defunti e i ricordi che le stesse piattaforme, «contenitori ad alta viscosità» (p. 148), ci ripropongono ciclicamente. Il paradigma dei replicanti come virus (p. 156) si afferma con i furti a opera di bot algoritmici che rubano la nostra immagine e pubblicano a nostro nome grazie all’IA: e se, si chiede l’autore, questi bot animassero invece i profili di chi non c’è più, con post e interessi diversi dall’originale? Senza il corpo vivente e quindi mortale, si potrebbe parlare di immortalità attraverso la simulazione? Se tra le dimensioni dell’identità, oltre credenze, valori, aspirazioni, opinioni degli altri su noi stessi, biografie ufficiali, false pretese, aspettative esterne, inibizioni sociali, esistono anche le consapevolezze del limite e del passato, quanto incide vivere sempre di più in un eterno presente dove tutto è potenzialmente riattualizzabile di continuo?
Marchesini, etologo oltre che filosofo, è attento a sottolineare le caratteristiche della nostra specie: da mammiferi, teniamo alle forti parentele; da primati, abbiamo un’indole giocosa e competitiva; da scimmie, eccelliamo nell’imitazione; da raccoglitori, tendiamo a collezionare e catalogare; da artigiani, a utilizzare oggetti e fenomeni che a loro volta influiscono su di noi. Allo stesso modo, alcune predisposizioni innate specie-specifiche regolano il nostro rapporto con la tecnologia: la meraviglia verso un nuovo dispositivo che ci cattura; la tendenza a delegargli compiti e funzioni per pigrizia; quella di vedere gli apparecchi come figli da educare assumendo un punto di vista genitoriale e sopravvalutando al tempo spesso le macchine; l’attitudine al pensiero superstizioso che spinge al bias di conferma; la spinta al sublime come brivido rassicurante che crea dipendenza; l’obiettivo dell’autoefficienza che porta ad accelerare e semplificare l’esecuzione dei compiti; la facilità nell’acquisire nuove abitudini e consolidare i risultati raggiunti senza dover ricominciare daccapo. «Ogni innovazione genera disparità di esercizio tra differenti apparati […]; assembla e disassembla funzioni […]; altera la dinamica funzionale degli organi […]; induce processi di sottoregolazione esternalizzando dei compiti […]; spinge alla sovraregolazione alcuni apparati […]; favorisce dipendenza, come alcune sostanze psicotrope» (p. 177). Un intero capitolo, il sesto, è quindi dedicato alla tecnodipendenza, che manipola il coinvolgimento motivazionale, amplia le opportunità di esercizio espressivo e nello stesso tempo rinforza le aspettative sugli altri e su noi stessi attraverso il bias di conferma. In particolare, Marchesini sottolinea che l’interazione con la tecnologia influisce sui meccanismi di sotto e sovraregolazione tra recettori e neurotrasmettitori: se una funzione viene assolta dal dispositivo (es. ricordare), il corpo regola verso il basso il meccanismo fisiologico associato a quella funzione; al contrario, se l’interazione col dispositivo richiede al corpo di sviluppare nuove funzioni (es. orientarsi su Internet), il corpo reagirà allo stress regolando verso l’alto gli sforzi necessari a raggiungere l’obiettivo o gli obiettivi. Tutto questo ci cambia, profondamente.
Secondo la visione tradizionale del corpo umano come incompleto, poco specializzato, dell’uomo “animale carente”, per citare la celebre espressione dell’antropologia filosofica di Gehlen, la tecnologia costituisce una stampella per lo sviluppo di un essere umano che resta intero e in controllo: Marchesini dimostra invece come la tecnologia non sia un prodotto del principio di scarsità ma, viceversa, dell’abbondanza delle potenzialità della natura umana (capitolo 1), che consente di potare la ridondanza delle proprie connessioni a seconda dei contesti e delle condizioni in cui si trova. Il corpo umano per Marchesini «non è un assemblaggio di funzioni morfomodulari ma un organismo» (p. 181): ovvero un sistema formato da strutture fisiologiche connesse e interdipendenti, con una organizzazione in grado di mantenere un equilibrio instabile (la vita) attraverso gli scambi di materia, energia e informazione con l’ambiente. Un organismo, scrive Marchesini riprendendo Prigogine e Stengers, è una struttura dissipativa fuori dall’equilibrio termodinamico, quindi aperta alle fluttuazioni e alle sollecitazioni ambientali, che gli consentono di adattarsi e continuare a vivere, evolvendosi. Questa caratteristica prende il nome di plasticità, «l’abilità di esprimere il potenziale producendo una configurazione peculiare che riflette le condizioni al contorno senza tradire le caratteristiche proprie e intrinseche» (p. 9): un’apertura che non è passività, fluidità o condizione amorfa, ma «manifestazione creativa delle inerenze nella loro capacità morfogenetica» (p. 17). Più un organismo è complesso, più è plastico. Infatti, più l’organismo si differenzia ed evolve aumentando le proprie funzioni e capacità, più ha bisogno di materia, informazione ed energia dall’esterno, sia per mantenersi in vita sia per produrre le condizioni di abbondanza necessarie al fine di far fronte ai cambiamenti. Come sopra, il sistema corpo-mente conosce attraverso un movimento che è anche proiezione, immaginazione, virtualità in senso proprio: più questo spazio si allarga e approfondisce, più aumenta il fabbisogno da e dell’esterno. Non a caso, Marchesini definisce il «gradiente di virtualità» come «l’ampiezza e le caratteristiche del campo di possibilità ontogenetiche che implica» un corpo (p. 11). Questa virtualità è poi attualizzata a seconda delle condizioni di contesto, date quindi dalla nicchia tecnoecologica, per cui l’organismo modifica l’ambiente che lo modifica. Questa dinamica è stata definita dai biologo-filosofi Maturana e Varela “accoppiamento strutturale”: una interazione che incide sull’organismo, ma non lo determina interamente. Infatti, per Maturana e Varela gli organismi viventi sono autopoietici, cioè in grado di mantenere la propria organizzazione interna in un equilibrio instabile attraverso la produzione e la riproduzione delle proprie stesse componenti, ovvero dei processi che consentono loro di vivere. In questa visione, i sistemi viventi sono contemporaneamente aperti e chiusi: esiste un dentro, da cui emerge il sé, ed esiste un fuori, da cui questo sé dipende ma non del tutto. Da questo percorso è nata la cognizione enattiva, che ben si collega a quanto descritto da Marchesini nel volume. Ma l’autore rifiuta l’autopoiesi, intendendola come un processo per cui «l’identità si basa solamente sull’autodeterminazione» (p. 144), associandola al sogno autarchico e impossibile di totale indipendenza dalle condizioni tecnoambientali.
Fin dall’introduzione, Marchesini dichiara invece di aderire alla teoria della mente estesa del filosofo cognitivista Andy Clark, secondo cui la mente non risiede nel sistema mente-corpo, quindi nell’individuo, ma si estende a tutto il mondo fisico: ne deriva un flusso di cognizione onnicomprensivo che equipara la cognizione biologica e quella artificiale secondo il principio di parità. Nella teoria della mente estesa non esiste una differenza tra dentro e fuori perché, nelle parole dello stesso Clark, quella della mente estesa è una no self theory: l’io non esiste, è considerato una coalizione frettolosa di elementi biologici e non biologici, ovvero una costruzione prevalentemente culturale. L’assemblaggio che Marchesini dichiara di voler rifiutare? Adottando la teoria della mente estesa, l’interazione tra il sistema corpo-mente e l’ambiente tecno-ecologico diventa ibridazione indistinguibile: non a caso, un intero capitolo del volume è dedicato alla fenomenologia del cyborg, rappresentazione iconica di questa ibridazione, che esprime «una presenza fuori dal corpo che si trasforma in esistenza postcorporale» (p. 75). La figura del cyborg, nata negli anni Venti dalla fantascienza americana come alieno tecnologizzato, ha trovato la propria consacrazione all’interno della corsa allo spazio degli anni Sessanta, descritto in una rivista scientifica come un organismo che incorpora elementi esterni per sopravvivere durante l’esplorazione extraorbitale e che potenzia le proprie funzioni autoregolatorie attraverso interfacce chimiche. Una versione dell’umano con superpoteri, perfettamente funzionale alla dottrina transumanista (e ultraumanista) dello human enhancement. Le interfacce biochimiche del cyborg sarebbero diventate meccaniche con la svolta pop dovuta a romanzi e serie tv degli anni Settanta, fino ai diversi Robocop e Terminator nel decennio successivo. Nel 1985 la filosofa femminista Donna Haraway con il suo A Cyborg Manifesto ha reinterpretato il corpo ibrido del cyborg come possibilità di abbattimento dei confini tradizionali tra umano, animale e macchina nonché di rifiuto del pensiero binario, inaugurando il filone di ricerca cyberfemminista e costituendo un caposaldo per gli studi postumanisti che cercano di decostruire l’identità dell’uomo a vantaggio delle soggettività non incluse e spesso tuttora considerate marginali, quando non inumane. Anche Marchesini considera il cyborg come un «avvertimento per mantenere la coscienza critica sugli esseri umani e la tecnologia che producono […] e abbracciare […] una visione più inclusiva della biosfera» (p. 76), ma il suo cyborg che non può strapparsi i dispositivi di dosso non ha nulla di gioioso, è «un S. Sebastiano che si lascia trafiggere non per martirio ma per continuare a fluttuare nel mare in tempesta di un futuro distopico che ha sancito l’obsolescenza della nuda carne» (p. 88) perché «più la tecnologia infiltra il corpo, più la carne seguirà le sue coordinate» (ibid.), un trionfo dell’Informatica del Dominio di cui ha scritto la stessa Haraway. Per tentare di cambiare le strutture che ci cambiano, occorre avere un sé. Per avere un sé, occorre avere un organismo che non si annulli nel tecno-ambiente. Seguire la teoria della mente estesa significa invece arrivare a una simbiosi indistinta, dove, se non esistono soggetti, non esistono neanche responsabilità né la possibilità di adottare l’approccio critico che Marchesini auspica. Ne deriva un paradosso: per superare la tecnodipendenza, l’autore propone di «praticare la moderazione» (p. 207). Un invito a ibridarsi, ma non troppo? O piuttosto il riconoscimento di un senso del limite che presuppone l’interazione anziché l’ibridazione? È possibile esercitare la moderazione senza un senso del sé? Il cyborg è attraversato da una continua smania da ricongiungimento simbiotico, in cui annullarsi estaticamente, rientrando nel flusso della mente estesa che assomiglia alla psichedelia come stile di vita. Il confine tra corpo e dispositivo scompare se il primo viene equiparato al secondo in nome dell’elaborazione informatica, non se si mantiene la differenza tra la cognizione degli organismi viventi e quella delle macchine artificiali. In questo il sempre bistrattato corpo fragile ci può aiutare, perché, come scrive Marchesini, la fragilità umana è «una qualità molto potente, e riconoscere questa condizione è essere consapevoli di un comune destino che condividiamo con gli altri, evitando la trappola del narcisismo solipsistico» (p. 76). Il resto ricade in tentazioni umaniste, troppo umaniste. In conclusione, il volume, di agevole lettura e ricca bibliografia interdisciplinare, è consigliato a chi volesse accostarsi alle questioni più attuali del dibattito filosofico.
Josephine Condemi
S&F_n. 30_2023