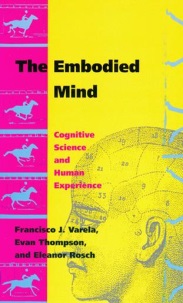Un viaggio affascinante nel mondo delle scienze cognitive alla ricerca di un nuovo criterio d’indagine scientifica: la via di mezzo della conoscenza. Gli autori aprono un’interessante prospettiva gnoseologica tesa a superare da un lato il tradizionale dualismo della filosofia occidentale soggettivismo/oggettivismo, dall’altro la necessità di un fondamento assoluto su cui la conoscenza possa basarsi, ossia il nostro Io, la nostra coscienza.
Ebbene, che cos’è la via di mezzo della conoscenza? Rispondere a questa domanda presuppone la comprensione di ciò che gli autori intendono per “conoscenza”. Siamo nell’ambito delle scienze cognitive che, nella loro accezione più ampia, indicano lo studio scientifico della mente, ossia un ambito di ricerca vasto e interdisciplinare dove la cognizione è intesa come un circolo in cui il soggetto e l’oggetto, la coscienza e il mondo si appartengono e si separano al tempo stesso. Da un lato il mondo e la mente sono uniti perché il mondo comprende anche la struttura logico-cognitiva necessaria per una riflessione su di esso, dall’altro la coscienza è separata dal suo oggetto, perché il mondo esiste prima ed indipendentemente dalla sua attività cognitiva, infatti, la mente si desta in un mondo già costituito e non da essa progettato. La via di mezzo della conoscenza si riconosce allora in quello spazio interposto fra la coscienza e il mondo e che Merleau Ponty chiamava entre-deux, uno spazio che «non esprimeva separazione, come un tratto di mare o una catena montuosa che separino due territori, bensì la distinzione fra sé e il mondo e insieme la loro continuità» (p. 25). Un entre-deux che la scienza non può ignorare, vincolandosi al dualismo soggettivismo/oggettivismo. Gli autori rifiutano di scegliere una di queste due possibilità perché entrambe commettono il medesimo errore: presupporre che la nostra conoscenza abbia nell’Io un punto di riferimento ultimo e inequivocabile. Noi possiamo decidere che il soggetto conosce il mondo o costruendolo secondo le leggi del proprio intelletto, o rispecchiandone le proprietà precostituite, in entrambi i casi, la conoscenza disporrebbe di un presunto fondamento unitario, ossia la nostra coscienza. Tuttavia, tramite un confronto tra la filosofia occidentale e quella orientale, gli autori scardinano questo pregiudizio per farci comprendere il tema dell’infondatezza o vacuità: la frammentazione del Sé e il non-dualismo buddista sono i capisaldi di un’inedita riflessione sulla teoria della conoscenza che si lascia alle spalle sia il soggettivismo, sia il realismo. Come? Individuando un approccio metodologico che non ha bisogno di riferire la propria pretesa di validità all’unità della nostra coscienza, perché il suo unico punto di riferimento è la storia dell’accoppiamento strutturale fra l’organismo e l’ambiente in cui vive. Tra mente e mondo esiste una “origine codipendente” per cui il soggetto influisce sull’ambiente circostante tramite le proprie costruzioni intellettuali e a sua volta è forgiato da quest’ultimo perché il nostro sistema cognitivo dipende dal processo di evoluzione e di selezione naturale cui il mondo ci ha sottoposto. Questa visione della conoscenza è il risultato di un progresso delle scienze cognitive condotto attraverso un’analisi più profonda sulla composizione biologica della nostra struttura cerebrale. Il criterio adottato è eliminare la distanza che separa la scienza dall’esperienza, in modo tale che la scienza non sia più una riflessione a posteriori sull’esperienza, ma l’esperienza stessa.
Gli autori partono da una critica alla fenomenologia di Husserl e di Merleau Ponty: «la svolta di Husserl verso l’esperienza e le cose stesse fu interamente teorica […] mancando completamente di ogni dimensione pragmatica» (p. 42), mentre Merleau Ponty «cerca di afferrare l’immediatezza della nostra esperienza non riflessiva e di darle voce nella riflessione cosciente. Ma proprio in quanto attività teorica a posteriori essa non può recuperare la ricchezza dell’esperienza ma solo essere un discorso su di essa» (p. 43). L’obiettivo è dunque esplorare la circolarità del sapere non ignorando l’immediatezza della nostra esperienza. A tal proposito, la tesi esposta in questo testo è che la riscoperta della filosofia asiatica possa rappresentare un nuovo Rinascimento per l’Occidente. La filosofia indiana non divenne mai un’occupazione astratta; essa era legata a metodi specifici e rigorosi per raggiungere la conoscenza, ossia a diverse tecniche di meditazione. Fondamentale è in essa la pratica dell’autopresenza: questo termine indica lo stato in cui la mente è presente nell’esperienza quotidiana concreta, infatti, le attività per ottenere tale condizione hanno come scopo quello di riportare la mente dal suo atteggiamento astratto alla situazione contingente della propria esistenza. Concentrandosi solo sul respiro, la mente scopre di non essere presente a sé in ogni momento ma di essere di continuo bersagliata da innumerevoli distrazioni e scoprirà inoltre di essere scoordinata rispetto al corpo. Allenandosi in questa pratica, la mente imparerà nella vita quotidiana a distinguere i momenti in cui è presente da quelli in cui non lo è, non più rispetto al respiro ma rispetto a qualsiasi cosa stia accadendo. Gli autori ci rendono nota questa tecnica per suggerirci una possibile modificazione della natura della riflessione, che da astratta e disincarnata diviene incarnata e illimitata. Incarnata perché radicata nel corpo e perché in essa mente e corpo si ricongiungono. Quando, infatti, ci chiediamo: “Che cos’è la mente?”, oppure ”Che cos’è il corpo?”, non includendo noi stessi nella riflessione, eseguiamo solo un ragionamento parziale perché ci riteniamo capaci di esprimere una visione disincarnata e obiettiva, come se non fossimo parte del nostro mondo, ma ne fossimo spettatori estranei e disinteressati, ed è ironico che questo sguardo disincarnato sul mondo sia invece limitato e ingabbiato da preconcetti. La pratica della consapevolezza e della presenza, al contrario, funziona direttamente con il nostro essere-nel-corpo, del quale è espressione. «Da Cartesio in poi l’interrogativo fondamentale nella filosofia occidentale è stato se il corpo e la mente fossero una o due sostanze […] distinte e quale fosse la relazione ontologica fra di esse.» (p. 52); ebbene, la pratica buddista della consapevolezza e della presenza salda la mente con il corpo, risolvendone la dissociazione.
Insomma questa tecnica non è un metodo di analisi dell’esperienza, perché essa è l’umana esperienza: infatti l’obiettivo degli autori è dimostrare che la conoscenza stessa possa essere una forma di esperienza, viva, consapevole e radicata nel corpo. Il testo ci propone perciò un excursus sulle varie teorie della scienza cognitiva, le quali se talora evolvono verso la tematica buddista dell’infondatezza, della frammentarietà del nostro Io, è perché in questo modo risulta possibile rimuovere il pregiudizio per cui la nostra coscienza, una e indivisa, sarebbe la base stabile e sicura della nostra riflessione. Le scienze cognitive vogliono rispondere alla domanda “Che cos’è la nostra conoscenza?” mettendo tra parentesi la tesi per cui essa sia o il riflesso del mondo nella nostra coscienza oppure l’applicazione delle regole dell’intelletto sui dati esperienziali. Una di queste teorie, il cognitivismo in senso stretto, considera la conoscenza come una manipolazione di simboli, condotta secondo precise regole di calcolo logico. La nostra mente riceve degli input dall’esterno ed elabora le informazioni attraverso simboli logici; questo sistema funziona correttamente se i simboli rappresentano le proprietà del mondo reale e se il calcolo logico porta a una soluzione soddisfacente del problema posto. È evidente che siamo ancora in una prospettiva realista perché i simboli devono riprodurre nel modo più fedele possibile le caratteristiche dell’oggetto, quindi fra la mente e il mondo c’è ancora dicotomia, non accoppiamento.
A uno stadio successivo la prospettiva emergentista o connessionista sostituisce i simboli logici con delle componenti subsimboliche che operano sinergicamente. La conoscenza, in questa sede, sarebbe l’emergenza di stati globali in una rete distribuita su livelli plurimi di componenti semplici che funziona grazie a regole di connessione degli elementi. L’emergentismo dunque sottrae all’Io la sua centralità nell’elaborazione delle informazioni in quanto essa viene compiuta da un sistema reticolare, cooperativo e decentrato. Ci stiamo così avvicinando alla via di mezzo della conoscenza, quella che gli autori riconoscono nella teoria dell’enazione, o produzione del mondo (da enacted ossia “prodotto”), la quale non riconosce nell’Io il fondamento unitario del sapere. Attraverso un’analisi dell’Abhidharma, una delle tre parti in cui è diviso il canone buddista, si comprende il tema dell’assenza dell’Io, ripreso con il termine sunyata ossia “vacuità”, dalla scuola Madhyamika, (in sanscrito “via di mezzo”), che fu fondata da Nagarjuna, un discepolo di Buddha, intorno alla prima metà del secondo secolo d.C. Chiediamoci allora cosa sia l’Io. Ne stiamo cercando un fondamento durevole e coerente per cui non possiamo ricondurlo al binomio corpo/mente o ai sentimenti, alle percezioni, alla personalità individuale o alla coscienza che tutto comprende, perché questi elementi, chiamati da Buddha “aggregati” , sono transitori, mutevoli e condizionati da molteplici fattori. Noi invece cerchiamo un fondamento del nostro Io che sia assoluto, incondizionato e indipendente, ma ammettiamo al tempo stesso che tutto in natura sia inserito in una trama di rapporti causali e spazio-temporali, ossia che nulla esista senza intrattenere legami con il mondo circostante. Gli autori allora concludono che gli aggregati devono necessariamente essere vuoti di Io per poter essere ricchi di esperienza, poiché nel vortice dell’esperienza nulla è privo di relazioni con l’esterno, nulla è assoluto. Dunque non possiamo cercare l’Io laddove esso non è mai stato. La teoria dell’enazione quindi, accetta l’infondatezza dell’Io, pur riconoscendo che la conoscenza del mondo si radichi sempre nella concreta esperienza soggettiva. La cognizione è quindi azione incarnata, in quanto consiste in un’esperienza derivante da precise capacità sensomotorie incluse in un contesto bio-psicologico e tali processi sensomotori sono strettamente connessi con l’azione e la percezione. Il punto di riferimento per comprendere la percezione non è il mondo prestabilito e indipendente da noi, né la nostra coscienza, è piuttosto il legame che unisce la mente e il mondo, il soggetto e l’oggetto, ossia il rapporto di reciproca specificazione e selezione fra l’organismo e l’ambiente in cui vive, che gli autori definiscono “origine codipendente” o “accoppiamento strutturale”. La conoscenza consiste pertanto nella storia della produzione del mondo da parte di un organismo complesso che a sua volta è forgiato dall’ambiente in cui vive perché è sottoposto alla legge dell’evoluzione naturale e della deriva genetica. Se ne deduce allora che le nostre capacità cognitive dipendono dalla storia che il genere umano ha vissuto in questo mondo, proprio come «alcuni sentieri esistono perchè sono stati tracciati camminando» (p. 207).
Dunque l’accoppiamento fra la corporeità umana e il mondo prodotto dalla nostra storia vissuta riflette solo una delle molteplici traiettorie evolutive possibili. Noi siamo vincolati dalla strada che abbiamo percorso ma non c’è alcun fondamento che ci indichi la strada da percorrere. Infatti è proprio tale assenza di fondamento che ci disorienta e ci spaventa, noi non accettiamo di vivere in un mondo privo di fondamenti. Gli autori a tal riguardo ricordano la filosofia di Nagarjuna, per la quale tutte le cose del mondo, ossia la coscienza e i suoi oggetti, le cose e gli attributi, le cause e gli effetti, stanno tra loro in un rapporto paritario di reciproca dipendenza: nulla ha un’esistenza assoluta, definitiva ed indipendente. Eppure essi rifiutano di accettare il nichilismo come reazione a tale assenza di fondamento, sia dell’Io sia del mondo. Infatti, grazie a tale infondatezza o vacuità, applicando la pratica della consapevolezza e della presenza, possiamo imparare ad abbandonare «la rissosa e guardinga mentalità dell’interesse personale» (p. 288) e a relazionarci in modo diverso al mondo che ci circonda. Se accettiamo l’infondatezza del nostro Io, il suo decentramento, la sua codipendenza con il mondo e ci alleniamo ad essere consapevoli, presenti e concentrati sull’unità della situazione presente, in noi sorgerà un interesse verso gli altri spontaneo e sincero e ci abitueremo a rapportarci a loro con generosità e rispetto. L’autopresenza è, infatti, un senso di calore e d’inclusione che ci spinge ad amare gli altri, a comprenderli e ad occuparci anche di loro, non solo di noi stessi, del nostro Io.
Così impareremo ad abitare mondi privi di fondamento senza averne più paura.
Maria Teresa Speranza
09_2009