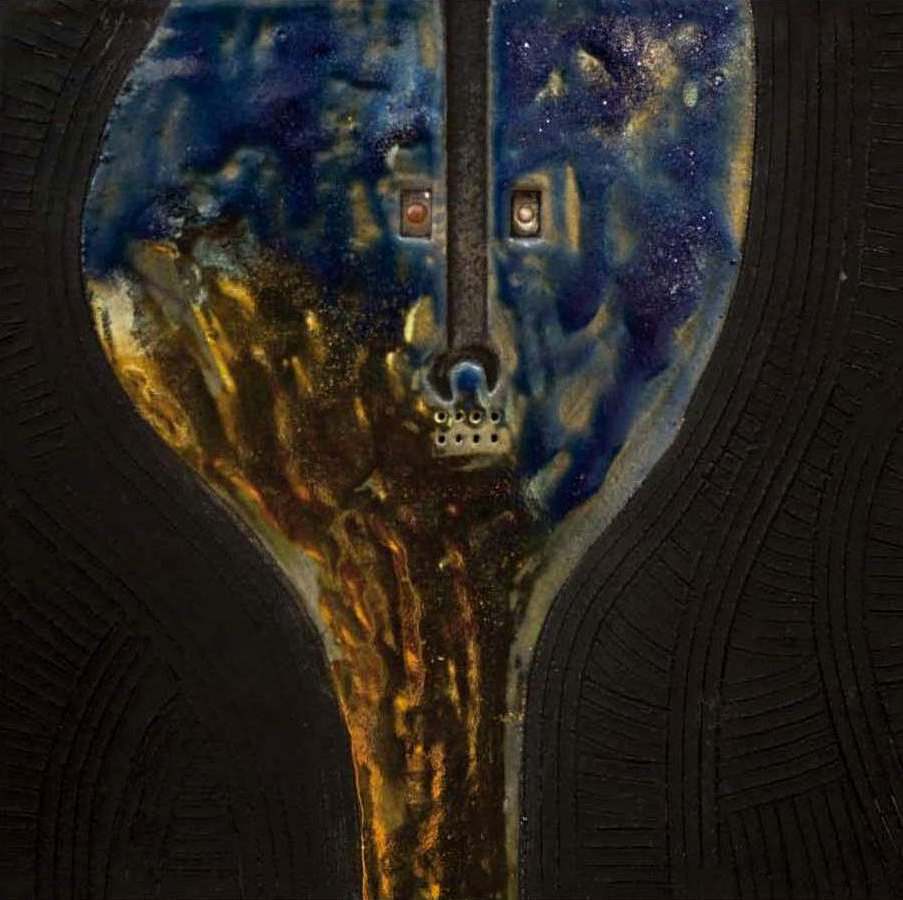Autore
Alberto Gualandi
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
svolge attività di ricerca all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Indice
- L’epoca contemporanea e la questione dell’uomo
- L’era «antropozoica»
- Evo-devo e antropobiologia
- Exaptation cerebrale e montaggi sensomotori
- Il paradosso antropologico e l’uomo postmoderno
S&F_n. 03_2010
- L’epoca contemporanea e la questione dell’uomo
Terreno di uno scontro politico e mediatico tanto esacerbato quanto superficiale, la questione dell’uomo continua a destare sospetto e imbarazzo in un dibattito filosofico e scientifico che, indebolito da impasses teoriche e contraddizioni interne, si rivela incapace di orientare l’opinione pubblica del nostro tempo. Esso si rivela incapace di porre freno a un marketing ideologico in cui, per evidenti ragioni performative, il modello più semplice e primordiale, dogmatico e brutale, sembra trionfare, con inevitabili ricadute in immagini ancestrali, ibridate postmodernisticamente dall’industria culturale.
Alle ragioni di tale paralisi riflessiva possiamo soltanto accennare. Spaccata a metà tra i due opposti schieramenti degli «analitici» e «continentali», la filosofia si trova divisa in due fazioni: da un lato, coloro che, motivati da un’esigenza di modellizzazione cibernetica o logico-formale, riducono il problema della natura umana a quello dell’identificazione di un «super-programma mentale», funzionalista o connessionista, implementabile «a piacere» nella materia cerebrale o nei circuiti (in feedback e in feedforward) di un potente calcolatore; dall’altro, coloro che, presaghi dei rischi di ogni formalizzazione, affermano con forza che, caratteristica della «natura umana, è quella di non averne una», poiché l’essere umano è quell’essere che costituisce la sua stessa natura nel corso della storia, tramite la società, il linguaggio, la cultura. Apparentemente unitaria, questa posizione continentale cela in realtà differenze rilevanti, che vanno da coloro che ritengono che ogni tentativo di porre il problema della natura umana nei termini di un «che cosa», implichi un inevitabile «scadimento antropologico» del «chi» (ontologico-trascendentale) di colui che interroga, a coloro che ritengono che l’uomo sia soltanto un «effetto di struttura», o un «segno» destinato ormai a dileguare come un volto di sabbia eroso dalle onde del mare. Essa si mostra tuttavia fragile soprattutto nei confronti delle sfide attuali. Il caso Habermas è in questo senso esemplare. Nel tentativo di argomentare laicamente contro l’«eugenetica liberale», l’ultimo grande erede della Scuola di Francoforte è stato accusato dai suoi detrattori di fare uso di un concetto metafisico di natura umana, mutuato dall’antropologia filosofica di Plessner, che lui stesso aveva liquidato come ideologico fin dalla metà degli anni ’50 nel suo confronto critico con l’antropologia filosofica tedesca[1]. In breve, uscito dalla porta, il problema della natura umana rientra dalla finestra, nonostante i legittimi sospetti e cautele della teoria critica.
Il caso del grande biologo Richard Lewontin basta forse a mostrarci che neppure la scienza più avveduta è al riparo da tali impasses. Dopo avere osservato che ogni teoria e pratica del potere politico presuppone in modo più o meno esplicito una dottrina della natura umana, e dopo aver denunciato l’uso ideologico che la società liberalista e individualista contemporanea fa della biologia, e in particolare di quel programma riduzionista che prende il nome di sociobiologia – programma che pretende ricondurre attitudini, comportamenti e sentimenti umani a moduli cognitivi e comportamentali, selezionati dalla specie nel corso dell’evoluzione e stoccati nel genoma umano sotto forma di pacchetti discreti di informazioni e regole, necessarie al funzionamento di quei robot preprogrammati dalla natura che, al pari di ogni altro vivente, sono gli esseri umani – Lewontin conclude citando Simone de Beauvoir: «un essere umano è l’essere il cui essere sta nel non essere»[2]. Secondo Lewontin, soltanto la coscienza di questo fatto fondamentale può restituire alla specie umana la coscienza delle sue responsabilità d’azione – responsabilità che, nel bene e nel male, non sono date a nessun altro animale, poiché a nessun’altra specie è data la possibilità di decidere della sua stessa estinzione.
Che morale trarre da questo fatto paradossale in seguito al quale la biologia attuale converge sulle stesse posizioni «metateoricamente negative» della filosofia continentale? Innanzitutto, esso ci mostra che, contrariamente a quel che sostengono alcuni, non ci si sbarazza di ogni ideologia della natura umana liquidando l’antropomorfismo e il dualismo metafisico presenti nella vecchia concezione teologico-filosofica dell’uomo in nome del naturalismo materialista, monista e contingentista presente nella rivoluzionaria dottrina darwiniana, o in nome della stretta continuità evolutiva che unisce l’uomo allo scimpanzé. Utilizzando il grimaldello teorico dell’adattamento/selezione, le ipotesi evoluzionistiche ad hoc, che Gould e Lewontin chiamano «storie proprio così», possono fungere perfettamente da strumento di legittimazione dello status quo della società e del potere; cosa cui, del resto, già il «rivoluzionario» Darwin si dedicava in L’origine dell’uomo. In secondo luogo, esso ci mostra che neppure il salutare ricorso di Lewontin – e, recentemente, di molti altri autori – alla biologia dello sviluppo, alla critica del riduzionismo genetista, e il ritorno a una concezione dialettica e costruttivista del rapporto tra istanze esterne e interne, tra geni e ambiente, contro ogni teoria (darwiniana o monodiana) della loro rigida opposizione, basta a produrre magicamente un’immagine in positivo della natura umana. Da una natura più creativa e contingente, dotata di temporalità e «storia» già al livello dello sviluppo embrionale di una drosofila o di un’ape, non si passa alla questione dell’uomo in modo graduale, bensì tramite un salto metateorico grazie al quale la natura umana finisce per essere pensata in modo adeguato soltanto per negazione: né creatura di Dio, né scimmia superdotata, né robot computazionale. Ma come rispondere allora positivamente al nostro compulsivo bisogno d’identificazione?
- Geni dello sviluppo e neotenia
Ripartiamo da un paradosso. Commentando i risultati pionieristici di King e Wilson[3], concernenti la differenza minima che separa il genoma dello scimpanzé da quello dell’uomo, in due celebri lavori della metà degli anni ’70[4], Stephen J. Gould osservava come questa prossimità genetica ed evolutiva strettissima rischi di sfociare in un’impasse paradossale. Come spiegare infatti che da una differenza genetica minima, pari all’1,4 per cento circa, possa derivare una differenza comportamentale così rilevante da far sì che nessuna scimmia riuscirà mai a scrivere l’Iliade (e, aggiungiamo noi, a scanso di equivoci: a godersi voyeuristicamente lo spettacolo dello struggle for life dell’Isola dei famosi; ad abbandonarsi al delirio storico-cosmologico-razziale di Hitler o del presidente Schreber; a pregustarsi i segni dell’estinzione in massa della specie, contemplando lo show delle Twin Towers in fiamme, davanti a un televisore)?
Sulla scorta di un’ipotesi avanzata dagli stessi King e Wilson, la soluzione di tale paradosso può solo risiedere, secondo Gould, in geni di tipo speciale – variamente denominati come «geni chiave», «master», «architetto» – responsabili di una serie di effetti a cascata, anatomici, cerebrali, cognitivi, e comportamentali, caratteristici della «differenza antropologica» esistente tra l’uomo e lo scimpanzé. Che cosa sono e dove sono localizzati tali geni? All’ora attuale, rispondeva Gould, purtroppo non lo sappiamo, ma conosciamo il modo in cui essi agiscono regolando i tempi di attivazione degli altri geni codificanti proteine. Sappiamo inoltre che, nell’uomo, i loro effetti sono stati descritti, fin dalla seconda metà degli anni ’20 da Bolk[5] e de Beer[6], nei termini di un generale rallentamento dello sviluppo che permette alla specie umana di conservare fin nell’età adulta circa venticinque tratti morfologici e comportamentali neotenici (“nudità”, ortognatismo, foramen magnum centrale, alluce non ruotabile, suture craniali persistenti, forma pelvica nella donna, denti piccoli, infanzia prolungata ecc.), tipici degli stadi giovanili, fetali e infantili, dello scimpanzé. Ma c’è dell’altro. Come ha mostrato in seguito Portmann[7], tale sviluppo ontogenetico è in realtà caratterizzato da un’eterocronia duplice in cui la fase di sviluppo rallentato è preceduta da una fase intrauterina accelerata che determina, dapprima, un aumento dei tassi di sviluppo del cervello, e una necessaria anticipazione (di quasi un anno) del momento del parto e, in séguito, la rallentata e prolungata sovraesposizione di un cervello «prematuro» e «quasi-fetale» agli stimoli dell’ambiente umano e naturale. Nonostante Habermas e altri detrattori, la concezione dell’uomo avanzata da Arnold Gehlen[8], sulla scorta di Bolk e Portmann, fin dalla metà del secolo scorso, trova qui un’importante corroborazione. Ma, dobbiamo ora chiederci, quali sono le prove che la biologia contemporanea offre a sostegno di quest’ipotesi avanzata da Gould alla metà degli anni ’70? E, inoltre, quali conseguenze filosofiche produce questo sviluppo eterocronico duplice, questo processo d’individuazione accelerato/rallentato del corpo e del cervello umano?
- Evo-devo e antropobiologia
È noto come lo stesso Gould, a metà degli anni ’90, nella sua ultima opera colossale[9], abbia salutato la messe di risultati prodotti in due decenni dalla neonata biologia evo-devo (Evolutionary developmental biology), come una conferma genetica e sperimentale delle sue precedenti teorie eterocroniche dello sviluppo e dell’evoluzione, costrette un tempo a rinviare a non ben identificati geni regolatori. Ipotizzati dapprima a livello macrodescrittivo, da pionieri come de Beer, Goldschmidt e Gould, tali geni sono stati infatti localizzati da alcuni decenni in quei geni Hox, e in altri geni regolatori dello sviluppo, che determinano, da un lato, il Bauplan del corpo di un individuo appartenente a una determinata specie e, dall’altro, i tempi di attivazione di altri geni strutturali. Anche l’ipotesi di Bolk, de Beer, Portmann, Gould, secondo cui l’essere umano non sarebbe altro che un primate dallo sviluppo accelerato/rallentato gode ormai di un certo credito anche presso biologi evo-devo lontani dall’eresia «saltazionalista» gouldiana[10]. Essa è del resto condivisa anche da neurobiologi contemporanei, come Alain Prochiantz, Gary Marcus e Steven Rose, che ci offrono argomenti preziosi a sostegno della tesi filosofica (quasi hegeliana) che vorremmo qui enunciare: il vantaggio offerto dalla natura a un primate che «nasce un anno troppo presto», che viene al mondo con un cervello sviluppato soltanto al 23 per cento, e che sovrespone il proprio cervello plastico e prematuro a un ambiente sociale e naturale per un periodo di sviluppo estremamente lungo è quello di consolidare delle relazioni intraspecifiche e sociali che vengono a iscrivere nella materia cerebrale le strutture simboliche, linguistiche e istituzionali, accumulate dalla specie (nel corso di un rapido processo lamarckiano di evoluzione culturale).
Prima di argomentare la «tenuta» neurobiologica di tale tesi, tentiamo di chiarirne brevemente le implicazioni antropologiche e psicologiche più generali. Per mezzo dei concetti dello psichiatra-fenomenologo Erwin Straus, si potrebbe sostenere che, nel corso del dilazionato sviluppo umano, il rapporto con l’Altro interumano (Heteros), «preceda» il rapporto con l’alterità del mondo (Allon)[11], il quale viene dialetticamente mediato, metaforizzato, compensato, dalla relazione comunicativa con l’Altro. Nei termini della psicoanalisi si potrebbe per altri versi affermare che la relazione comunicativa, affettiva e nutriva con l’Altro s’inscrive nelle strutture neurobiologiche del cervello tramite la mediazione dei montaggi sensomotori, «patico-comunicativi» (Straus), del corpo. È a questo punto preciso che, a nostro avviso, interviene una seconda tesi decisiva per la comprensione dell’«umano»: la tesi dell’eterocronia neotenica richiede come complemento necessario la tesi della struttura comunicativa dell’esperienza umana. Come ha mostrato Gehlen, l’essere umano può difatti compensare gli svantaggi procuratigli da tale condizione di prematurazione e sovresposizione solo stabilendo una relazione comunicativa con se stesso e con il mondo. Grazie a tale relazione comunicativa, l’occhio e la mano, l’orecchio e la voce giungono a intrattenere delle relazioni intersensoriali e sinestetiche, indisponibili per ogni altro animale[12]. Da tale relazione comunicativa prendono avvio una serie di processi di exattamento esonerante (anatomici, neurobiologici, cognitivi) che sono alla base, da un lato, della singolare struttura metaforica che Gehlen, e linguisti cognitivi come George Lakoff e Mark Johnson[13], attribuiscono all’esperienza dell’uomo e, dall’altro, della struttura proposizionale su cui si fonda il logos deliberativo dell’«animale razionale». Un risultato, quest’ultimo, cui l’essere umano giunge non perché predestinato da Dio o dall’evoluzione, ma poiché capace di sfruttare, nel corso del processo culturale di «ominazione», quello stratagemma «creativo» che, come hanno mostrato Jacob, Gould e Vrba[14], la natura utilizza ovunque: il bricolage exattante, ovvero l’esonero di una struttura da vecchi compiti, e la sua rifunzionalizzazione. Esonerata dalla deambulazione, la mano viene, per esempio, rifunzionalizzata per scopi comunicativi, che a loro volta vengono assunti dalla visione, del segno gestuale e pittorico, e infine dalla voce. In conclusione, la «voce della coscienza» non è solo una metafora del logos deliberativo di cui è dotato l’animale razionale, bensì la traccia quasi archeologica di un processo di «filogenesi culturale» che giunge a un risultato stabile ed efficace solo nel momento in cui l’apparato fono-uditivo, esonerato dalla stessa azione fonatoria, assume il ruolo di modello e guida dell’intero sistema sensoriale e motore. La coscienza delle proprie possibilità e responsabilità d’azione, che Lewontin attribuiva alla specie umana tramite una sorta di salto nel nulla, può forse esser fondata così in modo più graduale.
- Exaptation cerebrale e montaggi sensomotori
Per tentare di argomentare quest’insieme di tesi dal punto di vista neurobiologico, dobbiamo ripercorrere in modo schematico tre tappe che abbiamo sviluppato dettagliatamente in analisi cui possiamo qui solo rinviare[15].
a) Sulla scorta delle analisi di neurobiologi contemporanei come Alain Prochiantz e Gary Marcus, si è trattato innanzitutto di mettere in evidenza il ruolo fondamentale che i geni dello sviluppo giocano nei processi di differenziazione, costruzione ed evoluzione del cervello, poiché «il modello di base del cervello» – con le sue partizioni in rombencefalo, mesencefalo e prosencefalo, e fra emisfero destro e sinistro – «è fatto allo stesso modo in tutti i vertebrati attraverso geni regolatori (quelli, cioè, che producono proteine che regolano l’attivazione o la disattivazione di altri geni) come l’Otx e l’Emx»[16]. A differenza dei geni Hox, Otx e Emx non seguono però la regola di colinearità. Alla disposizione topologica dei geni sui cromosomi, non corrisponde in questo caso la struttura topologica delle diverse aree sensoriali e motorie del cervello. L’omuncolo sensori-motorio di Penfield e Rasmussen non può quindi derivare direttamente da essi, ma per via mediata dai geni Hox che presiedono alla costruzione del corpo. Un fatto che bisogna ricordare per comprendere il seguito.
b) In secondo luogo, a partire dalle analisi di Steven Rose[17] e Gary Marcus, si è trattato di mostrare che geni come il FOXP2, responsabili di processi cognitivi unicamente umani come il linguaggio proposizionale, non sono geni che determinano il possesso di un maggior numero di meccanismi sintattici e moduli cognitivi, delegati a funzioni specifiche, come vorrebbe insegnarci la psicologia evoluzionista sulla base del «modello del coltellino svizzero» o del «cervello di scimpanzé superdotato». (E come del resto potrebbe, ci suggerisce Carroll, se nell’uomo, rispetto allo scimpanzé, ci sono soltanto due differenti aminoacidi sui 716 che compongono la proteina codificata dal gene FOXP2?[18]). Essi sono piuttosto dei geni regolatori che agendo sui tempi di attivazione di altri geni consentono una maggiore plasticità cerebrale e una conseguente rifunzionalizzazione exattante di strutture percettive e cognitive già presenti negli altri primati. Come Gehlen e Plessner avevano già intuito, la caratteristica principale del cervello neotenico umano risiede in quella «iperconnettività diffusa» che, secondo Vilayanur Ramachandran[19], permette alle diverse modalità sensoriali di associarsi grazie a relazioni sinestesiche e metaforiche, exattanti ed esoneranti, che danno vita a schemi intersensoriali quasi-trascendentali indisponibili per gli altri animali. Tali relazioni sono alla base tanto della percezione simbolica, del linguaggio vocale e grafico, quanto della funzione di esonero fonatorio e di anticipazione/ricognizione (feedforward/feedback)[20] che la nostra «coscienza silenziosa» ha exattato da quella modalità sensoriale che fin dai primi giorni di vita, o addirittura fin dalla «notte uterina», ci mette in comunicazione con l’Altro: il nostro udito. Tacciato spesso di anti-darwinismo (benché le sue critiche vertessero principalmente sull’uso indiscriminato del concetto di adattamento e sul dogma paleoantropologico dell’«anello mancante»), Gehlen non ha soltanto anticipato il concetto gouldiano di exattamento, definendo letteralmente l’esonero in termini di rifunzionalizzazione di strutture preesistenti per scopi non prescelti dall’evoluzione, ma ha fornito la prima spiegazione rigorosamente materialista della genesi fono-uditiva della «coscienza secondaria». Una teoria che l’estesiologia fenomenologica e la psichiatria[21], l’audio-fonologia e le teorie della lateralizzazione[22], la paleoantropologia[23] hanno confermato per altre vie.
c) Ritornando ai geni dello sviluppo e alle analisi di Alain Prochiantz, si tratta infine di mostrare che i montaggi sensomotori e gli schemi intersensoriali che hanno permesso agli esseri umani di parlare e di pensare in modo peculiare sono resi possibili dal fatto che i geni Hox dello sviluppo agiscono sul cervello, determinando l’omuncolo sensoriale e motore di Penfield e Rasmussen, solo tramite la mediazione del corpo, ovvero tramite la retroazione del sistema (sensoriale e motore) periferico sul sistema nervoso centrale nel corso del lungo processo di individuazione. Contrariamente a quello che sostiene la psicologia cognitivista, si tratta di mostrare che «non è il cervello che pensa, bensì il corpo!»[24] o, in altri termini, che il cervello funge solo da trasduttore di segnali o da interfaccia sensibile per il rapporto dialettico che il corpo intrattiene col mondo[25]. In conclusione, i montaggi sensomotori che il corpo umano sviluppa nel suo rapporto storico e culturale con l’ambiente esterno vengono a iscriversi nel plastico e prematuro cervello neotenico, costituendo una sorta di «mondo esterno interno» o di «mondo interno esterno»[26], di protesi oggettivata o d’impalcatura esterna dello spirito umano[27]. La concezione di Lewontin di un rapporto dialettico e interattivo tra l’organismo interno e l’ambiente esterno trova un’applicazione più precisa al caso dell’uomo.
- Il paradosso antropologico e l’uomo postmoderno
Chiediamoci ora di nuovo: per quale ragione l’uomo postmoderno sente il bisogno di identificarsi con una scimmia superdotata, con una macchina computazionale o con un nulla ontologico? Questo bisogno paradossale può essere in primo luogo spiegato a partire da un fatto che già conosciamo. Secondo Prochiantz, l’essere umano vive del paradosso di essere «estremamente individuato» e di essere, al contempo, un «individuo estremamente sociale», un «individuo estremo» che può costituirsi in quanto tale, nel corso di un processo fortemente dilazionato di individuazione[28]. Poiché il cervello umano viene al mondo un anno troppo presto, carente di quelle coordinazioni extraspecifiche che permettono agli altri animali di adattarsi «istintivamente», in base a una sorta di «memoria genetica della specie»[29], ad ambienti specie-specifici predeterminati, l’essere umano può infatti compensare la sua condizione «ultraneotenica»[30] di sovraesposizione e prematurazione, soltanto per mezzo di una sorta di exattamento o metapherein cognitivo primario. Esso può compensare tale condizione soltanto trasferendo sull’ambiente esterno, quelle coordinazioni intraspecifiche, e quelle strutture di «senso» mediate – intersensoriali e cognitive, simboliche e affettive – che lo uniscono ai suoi simili, fin dalla prima infanzia. Bisogna ora notare che questo transfert comunicativo primario ha una conseguenza duplice. Se, da un lato, esso permette un grande vantaggio adattativo, poiché fornisce all’essere umano un’apertura al mondo, ovvero una flessibilità e plasticità che nessun’altra specie conosce, e che gli ha permesso di popolare l’intero globo terracqueo, mantenendo in se stesso, nel proprio clan, linguaggio e cultura il proprio «centro» (nomadico), d’altro lato esso è all’origine di una chiusura su di sé, di un ripiegamento sulle proprie «coordinazioni intraspecifiche», che è alla base di ogni antropocentrismo e antropomorfismo, etnocentrismo e trascendentalismo cognitivo, linguistico, culturale, politico. Come è stato recentemente osservato da De Carolis[31], il prevalere esclusivo del momento della chiusura su quello dell’apertura, o viceversa, o il netto dissociarsi di un momento dall’altro, sono all’origine delle patologie individuali e sociali che segnano la nostra epoca. Il bisogno d’identificazione dell’uomo contemporaneo con la macchina, l’animale o il nulla fornisce un esempio di tale fenomeno: transfert comunicativo parziale, o scissione ed espulsione rigida del polo opposto. Il celebre caso del bambino autistico Joey che identificava i propri organi e il proprio corpo con un patchwork di macchine, da lui stesso create, per mantenersi in vita e proteggersi nei confronti dell’aperto, è in questo senso paradigmatico.
Ma c’è un altro fatto che bisogna considerare per rendere conto di tale bisogno paradossale. Le coordinazioni intraspecifiche che hanno permesso alla specie umana di allevare una prole neotenica non sono di per se stesse sufficienti per assegnare agli individui un’identità di gruppo, familiare o sociale. Per sapere chi sono e come devono agire collettivamente, i gruppi umani hanno avuto bisogno di identificarsi nel corso della loro storia con Terzi istituzionali che hanno assunto di volta in volta l’aspetto della grande fiera da cacciare, dell’animale totemico, degli dèi-sovrani dell’antico Egitto, del Dio di parola del monoteismo, del golem cibernetico, affrontando bisogni sempre più complessi, per mezzo di una logica storico-sociale – esonerante, exattante e comunicativa – analoga a quella sopra descritta. Ora, ci avverte Gehlen, nel momento in cui le ultime grandi istituzioni vacillano, la specie umana sembra trovarsi di fronte a un’alternativa: o implodere nella propria natura neotenica, assegnando alla «massa fluida» umana la parvenza preumana di una società «a bassa tensione»[32] di bonobo consumistici e televisivi; o alienarsi completamente nella propria protesi macchinica, asservendosi a un’impalcatura tecnoscientifica completamente autonomizzata dalla razionalità umana. Contro lo stesso Gehlen, compito della riflessione filosofica e scientifica è dunque quello di mostrare che la dinamica comunicativa consustanziale all’umano può essere riattivata, sottraendola a scissioni e alternative rigide, aprendola al futuro, ma stabilizzandola anche su immagini dell’umano più ampie e concrete, capaci in qualche modo di soddisfare l’inestinguibile bisogno d’identificazione – teorico, pratico, simbolico – dell’individuo postmoderno. Un compito tutt’altro che scontato.
[1] J. Habermas, Antropologia, in G. Preti (a cura di), Filosofia, Feltrinelli-Fischer, Milano 1966; Id., Il futuro della natura umana, tr. it. Einaudi, Torino 2002.
[2] R. Lewontin, Biologia come ideologia, tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 2005, p. 94.
[3] M.C. King, A.C., Wilson, Evolution at two levels in humans and chimpanzees, in «Science», 188, 1975, pp. 107-116.
[4] Cfr. S. J. Gould, Ontogeny and Phylogeny, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, London 1977, p. 405 e sgg.; Id., Questa idea della vita, tr. it. Editori Riuniti, Roma 1984, p. 45 e sgg.
[5] Cfr. L. Bolk, Il problema dell’ominazione, a cura di S. Esposito e R. Bonito Oliva, Derive Approdi, Roma 2006.
[6] Cfr. G. de Beer, Embriologie et évolution (1930), Amédée Legrand, Paris 1933.
[7] Cfr. A. Portmann, Zoologie und das neue Bild vom Menschen: Biologische Fragmente zu einer Lehre des Menschen, Rowohlt, Hamburg 1956.
[8] Cfr. A. Gehlen, L’uomo, tr. it. Feltrinelli, Milano 1983.
[9] S.J. Gould, La struttura della teoria dell’evoluzione, a cura di T. Pievani, Codice edizioni, Torino 2003, p. 1322 e sgg.
[10] Cfr. S.B. Carroll, Infinite forme bellissime, tr. it. Codice edizioni, Torino 2006, p. 107 e sgg., 125, 260; S.F. Gilbert, Biologia dello sviluppo, tr. it. Zanichelli, Bologna 2005, p. 361 e sgg.
[11] E. Straus, Il vivente umano e la follia. Studio sui fondamenti della psichiatria, a cura di A. Gualandi, Quodlibet, Macerata 2010, p. 68 e sgg.
[12] Cfr. M. Mazzeo, Storia naturale della sinestesia. Dalla questione Molyneux a Jakobson, tr. it. Quodlibet, Macerata 2005.
[13] Cfr. G. Lakoff, M. Johnson, Philosophy in the Flesh, Basic Books, New York 1999; G. Lakoff, R.E. Núñez, Da dove viene la matematica, tr. it. Boringhieri, Torino 2005.
[14] Cfr. F. Jacob, Evoluzione e bricolage, tr. it. Einaudi, Torino 1979; S.J. Gould, E.S. Vrba, Exaptation, il bricolage dell’evoluzione, a cura di T. Pievani, Boringhieri, Torino 2008.
[15] Cfr. A. Gualandi, L’individuazione neotenica umana e la genesi exattante e comunicativa del «senso», in A. Cavazzini, A. Gualandi (a cura di), Logiche del vivente. Evoluzione, sviluppo, cognizione nell’epistemologia francese contemporanea, «Discipline filosofiche», 1, 2009.
[16] G. Marcus, La nascita della mente, tr. it. Codice Edizioni, Torino 2004, p. 141.
[17] S. Rose, Il cervello del ventunesimo secolo. Spiegare, curare e manipolare la mente, Codice edizioni, Torino 2005, p. 134 e sgg.
[18] S.B. Carroll, op. cit., p. 264.
[19] Cfr. V.S. Ramachandran, Che cosa sappiamo della mente, tr. it. Mondadori, Milano 2004.
[20] Cfr. J.P. Changeux, L’uomo di verità, Feltrinelli, tr. it. Milano 2003; P.M. Churchland, Il motore della ragione, la sede dell’anima, tr. it. Il Saggiatore, Milano 1998; G. Edelman, Il presente ricordato, tr. it. Rizzoli, Milano 1991.
[21] Cfr. E. Straus, Estesiologia e allucinazioni, in E. Minkowski, V. von Gebsattel, E. Straus, Antropologia e psicopatologia, tr. it. Bompiani, Milano 1967; J. Jaynes, Il crollo della mente bicamerale e l’origine della coscienza, tr. it. Adelphi, Milano 1984, p. 126, 485 e sgg.; T.J. Crow, Auditory Hallucinations as Primary Disorders of Syntax: An Evolutionary Theory of the Origins of Language, in S.A. Spence, A.S. David (ed. by), Voices in the Brain: The Cognitive Neuropsychiatry of Auditory verbal Hallucinations, «Cognitive Neuropsychiatry», 1/2, February/May, 2004.
[22] Cfr. A. Tomatis, L’oreille et le langage, Éd. du Seuil, Paris 1963; Id., La notte uterina, tr. it. Red, Como 1996; P. Lieberman, Uniquely Human, Harvard University Press 1991; M. Annett, Left, Right, Hand and Brain, Erlbaum, London 1985.
[23] Cfr. M.C. Corballis, The Lopsided Ape, Oxford University Press, New York-Oxford 1991; Id., Dalla mano alla bocca: le origini del linguaggio, tr. it. Raffaello Cortina, Milano 2008; S. Mithen, Il canto degli antenati. Le origini della musica, del linguaggio, della mente e del corpo, tr. it. Codice Edizioni, Torino 2008.
[24] A. Prochiantz, A cosa pensano i calamari? Anatomie del pensiero, tr. it. Einaudi, Torino 1999, p. 157.
[25] R. Lewontin, op. cit., p. 87.
[26] A. Gehlen, op. cit., pp. 231, 298, 303.
[27] Cfr. A. Clark, Dare corpo alla mente, tr. it. McGraw-Hill, Milano 1999, p. 167 e 191.
[28] A. Prochiantz, La costruzione del cervello, tr. it. Theoria, Roma 1992, p. 78.
[29] Id., A cosa pensano i calamari?, cit., p. 148.
[30] Cfr. M. Mazzeo, Il tempo del tatto, in R. Contessi, M. Mazzeo, T. Russo (a cura di), Linguaggio e percezione, Carocci, Roma 2002.
[31] Cfr. M. De Carolis, Il paradosso antropologico: nicchie, micromondi e dissociazione psichica, Quodlibet, Macerata 2008.
[32] A. Gehlen, Le origini dell’uomo e la tarda cultura, tr. it. Il Saggiatore, Milano 1994, pp. 271, 273, 277.