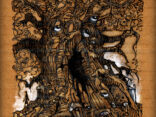Autore
Indice
- Tracciare un confine tra uomo e animale
- Un vivente senza risposta
- Animal rationale?
S&F_n. 06_2011
- Tracciare un confine tra uomo e animale
L’Animale che dunque sono lancia una sfida al confine tra animalità e umanità, tra il sé e l’altro da sé. Una sfida però incompiuta, perché, come Marie-Louise Mallet ricorda nella Prefazione, Derrida aveva intenzione di ampliare l’opera, che raccoglie due testi già pubblicati separatamente e integrati con le due parti ancora inedite del suo intervento al seminario di Cerisy del luglio 1997 su L’animale autobiografico. La questione dell’animalità attraversa in realtà la produzione derridaiana fin dai testi degli anni Settanta e fin dai ripetuti confronti con Heidegger, ed è affidata in genere a testi disparati che l’autore intendeva unificare e raccogliere in un saggio, la cui preparazione fu però sempre rimandata per mancanza di tempo, fino alla soglia ultima della malattia e della morte.
La questione dell’animalità conduce inevitabilmente alla domanda generale dell’antropologia filosofica, ossia:
Che cosa significa essere un essere umano? Cosa ci distingue dall’animale? Cosa ci rende propriamente uomini?
Ebbene, le classiche definizioni dell’essere umano imposte dalla filosofia occidentale hanno segnato una differenza irriducibile tra uomo e animale, una diversità che si sostanzia nella capacità logico-linguistica, di cui l’uomo sarebbe l’unico e privilegiato destinatario.
Animal rationale oppure zoon logon echon: da Aristotele a Rousseau, la storia della filosofia occidentale situa la differenza tra uomo e animale in un confine ritenuto inviolabile, al cui superamento l’animale non ha accesso. La porta è sbarrata dal logos, questa sintesi di ragione e parola che aggiunge
all’unità dell’organismo vivente qualcosa d’altro, qualcosa in più, qualcosa che lo caratterizzi e lo faccia pensare diverso dalla bestia[1].
La filosofia occidentale infatti ha posto la differenza tra uomo e animale come una verità inconfutabile, usandola per legittimare la prevaricazione – violenta e spietata – dell’uomo sull’animale, come sostenuto anche da Adorno nella Dialettica dell’Illuminismo:
L’idea dell’uomo, nella storia europea, trova espressione nella distinzione dall’animale. Con l’irragionevolezza dell’animale si dimostra la dignità dell’uomo[2].
La differenza uomo-animale è stata teorizzata anche in altre culture ma in nessuna di queste ha mai costituito una motivazione atta a giustificare lo sfruttamento sistematico che l’uomo effettua sugli animali, perché non viene considerata come un limite invalicabile. Infatti, non si può affermare con certezza che l’inizio del rapporto uomo-animale, sebbene conflittuale, sia basato soltanto sulla drammatica e netta divisione tra uomini, potenzialmente portatori di diritti, e animali, ridotti a cose, divisione che ancora oggi permette lo sfruttamento di decine di miliardi di animali all’anno per scopi alimentari, di ricerca scientifica o puramente ludico-voluttuari.
Infatti, la letteratura sumerica, la più antica conosciuta, risalente al IV millennio a. C., offre una prospettiva sul rapporto uomo-animale ben diversa da quella imperante nella cultura occidentale. Nell’epopea di Gilgamesh (ciclo epico di ambientazione sumerica risalente a 4.500 anni fa), il re della città di Uruk, guerriero crudele, per due terzi divino e per un terzo mortale che tiene sotto il suo dominio un popolo sempre più stanco delle sue prepotenze e ingiustizie, piange, disperato, la morte dell’amico Enkidu, una sorta di chimera, un essere per metà uomo e per metà animale. Dal dolore di Gilgamesh per la morte di Enkidu si evince che in origine l’approccio al rapporto uomo-animale doveva essere molto diverso dall’attuale e basato, quanto meno, sul rispetto:
“Enkidu, amico mio, mulo imbizzarrito, asino selvatico delle montagne, leopardo della steppa, noi dopo esserci incontrati, abbiamo scalato assieme la montagna […],e ora qual è il sonno che si è impadronito di te? […]” Allora ricopre la faccia del suo amico come quella di una sposa, come un’aquila comincia a volteggiare intorno a lui, come una leonessa, i cui cuccioli sono stati presi in trappola, egli va avanti e indietro[3].
Tra i popoli antichi quello egizio è sicuramente il più celebre per il rispetto e in molti casi per una vera e propria venerazione degli animali, come ci ricorda Erodoto di Alicarnasso, storico greco che riportò nelle sue Istoriai gli usi e i costumi delle terre che aveva esplorato durante i suoi numerosi viaggi:
Tutti gli animali che si trovano in Egitto sono ritenuti sacri, sia quelli che vivono con gli uomini sia quelli che non ci vivono[4].
Il diverso rapporto dell’Antico Egitto con gli animali è anche testimoniato dalla descrizione che altre tradizioni forniscono della condizione animale in questa cultura:
I sacrifici che noi offriamo al Signore Iddio nostro Yahvé sono cosa abominevole per gli egiziani[5].
Lo stesso Aristotele nella Politica dice:
Le piante sono fatte per gli animali e gli animali per l’uomo, quelli domestici perché ne usi e se ne nutra, quelli selvatici, se non tutti, almeno la maggior parte, perché se ne nutra e se ne serva per gli altri bisogni[6].
Proprio alla Politica si deve la celebre definizione di uomo quale animale razionale, una dizione che marca con decisone un confine invalicabile tra due ordini di esseri viventi: quelli portatori di logos, ossia ragione e parola, e quelli che ne sono privi e per questo motivo non sono degni di rispetto. Secondo lo Stagirita l’uomo è zoon logon echon, ossia animale avente il logos ed evidentemente qui il logos riferito all’uomo è la parola. Dopo aver ribadito che l’uomo è animale politico, il filosofo distingue la phoné, ossia la voce, che è data anche agli altri animali, dal logos, che costituisce il proprio dell’uomo, l’unico ad avere coscienza del bene e del male. La diversità tra uomo e animale, che sia innalzamento di grado ontologico, come per Aristotele, oppure strappo violento ed enigmatico dall’animalità, come teorizzato nel discorso sull’Origine della disuguaglianza tra gli uomini di Rousseau, viene posta dalla tradizione filosofica occidentale come un dato di fatto, un’evidenza incontrovertibile, qualcosa che nessuna analisi antropologica potrebbe negare.
Derrida, ne L’Animale che dunque sono, lavora proprio su questa verità che pretende di essere innegabile, ma alla luce di una prospettiva completamente differente. Come sottolinea nel capitolo III, dedicato a Jacques Lacan e intitolato: E se l’animale rispondesse?:
non si tratta solo di domandarsi se abbiamo il diritto di rifiutare questo o quel diritto all’animale […], ma si tratta anche di domandarsi se ciò che si chiama uomo ha il diritto di attribuire all’uomo, quindi di attribuirsi, ciò che egli rifiuta all’animale, e se ne ha mai il concetto puro, rigoroso, indivisibile, in quanto tale[7].
Il taglio dell’indagine è però del tutto diverso rispetto a quello tradizionale della filosofia. L’unità di ragione e parola, la capacità logico-linguistica, l’attitudine alla simbolizzazione, nel percorso derridaiano conducono a un unico elemento: l’autobiografia. Il discrimine tra uomo e animale consiste, letteralmente, nella capacità di scrivere la propria vita: l’uomo è dunque l’unico animale autobiografico, ossia capace di tramutare in simboli grafici la percezione della realtà, sia interiore che esteriore. Tuttavia, il lettore sbaglia se crede che l’autobiografia aggiunga all’essere umano, come avviene per la definizione aristotelica, un qualcosa in più, una completezza che l’animale non possiede, ad esempio la capacità di produrre segni linguistici. Derrida sostiene piuttosto che l’uomo è un animale ancora incompleto, addirittura contraddittorio, perché «mancante di sé»[8]. Precisiamo subito cosa il filosofo intende per mancanza: si tratta della nudità, della nuda pelle umana, nudità di cui l’uomo acquisisce consapevolezza, come narra il libro della Genesi. Nell’Introduzione all’edizione italiana dell’opera, Gianfranco Dalmasso sottolinea che è la mancanza il vero punto in questione nella definizione stessa dell’uomo, come dimostrerebbe senza equivoci l’esperienza del pudore, visto che nella propria nudità l’uomo si avverte come «mancante a se stesso»[9], identificando in questa mancanza una colpa originaria. L’uomo è l’unico essere vivente che ha coperto le sue nudità, che si è nascosto tra gli alberi dell’Eden perché provava vergogna dinanzi allo sguardo divino. La questione del pudore è indissolubilmente connessa a quella della nudità ed è qui che scoppia il diluvio di parole dell’opera derridaiana.
Il suo percorso, ricco, affascinante, labirintico, si snoda tra Aristotele e Descartes, Kant e Lévinas, Heidegger e Lacan, tracciando nuove coordinate per l’antropologia filosofica perchè dà accesso alla nozione di uomo non attraverso la parola, non attraverso il logos come elemento discriminante, ma attraverso il concetto di nudità in sé. «La strategia derridaiana si muove in controsenso rispetto a questa strada principale e finora apparentemente vincente che è la parola»[10]. Il concetto che ha il compito di marcare la differenza tra uomo e animale è allora la nudità in sé. Ma nudità rispetto a chi? Rispetto allo sguardo dell’altro su di me e di me in relazione a tale sguardo. Quest’alterità, questo essere altro da me costituisce uno dei concetti più densi e fertili della dissertazione. Cosa significa essere altro rispetto all’animale? Quindi cosa significa essere un essere umano?
La domanda fondamentale dell’antropologia filosofica passa attraverso gli occhi di una gatta. La gatta di Derrida, che lo guarda nudo e inspiegabilmente genera in lui un senso di imbarazzo, di vergogna:
Vergogna di che e davanti a chi? Vergogna di essere nudi come una bestia. Normalmente si crede […] che la caratteristica delle bestie e ciò che in ultima istanza le differenzia dall’uomo, è quella di essere nudi senza saperlo[11].
Da questo assunto discende che gli animali, nudi senza saperlo, non sarebbero in realtà nemmeno nudi. Non esiste nudità in natura per il semplice fatto che non c’è consapevolezza della nudità, se non sai di essere nudo allora non sei nudo. Ma se così stanno le cose perché Derrida prova vergogna nei confronti della sua gatta che lo guarda nudo, di fronte a un essere vivente che non ha la percezione della nudità? Perché lo sguardo della gatta lo scuote come se a guardarlo fossero gli occhi di un essere umano, perché si sente esposto al suo sguardo come se fosse la chiamata perentoria del volto dell’altro? Ebbene Derrida della sua gatta dice:
Possiede un suo punto di vista su di me. Il punto di vista dell’assolutamente altro e niente mi ha mai fatto pensare all’alterità assoluta del vicino e del prossimo, quanto i momenti in cui mi vedo visto nudo sotto lo sguardo di un gatto[12].
A partire da Bentham e dalla sua sfida a chiedere non se gli animali pensino o parlino, ma se soffrano come noi, ossia se possano non potere, se possano paradossalmente essere impotenti nella loro vulnerabile passività che condividono con la nostra finitezza e se perciò meritino compassione, si snoda una riflessione che indaga in realtà una diversa genesi del pensiero:
L’animale ci guarda e noi siamo nudi davanti a lui. E pensare comincia forse proprio da qui[13].
Immancabile il riferimento a Emmanuel Lévinas, il cui pensiero risulta caratterizzato da una programmatica apertura nei confronti dell’alterità e del prossimo. Tramite quel basilare evento che è l’incontro con l’altro, con l’irriducibile alterità dell’altro, siamo catapultati oltre i confini della nostra soggettività egoistica ed egocentrica. È il volto il modo in cui si presenta l’Altro, un volto dotato di autosignificanza, in quanto assolutamente trascendente e indipendente dal contesto fisico e sociale. Ma l’animale è Altro? E quindi ha o no un volto? Rispondere a queste domande implica la determinazione etica del concetto di responsabilità, perché in virtù della sua pregnanza il volto dell’altro mi coinvolge e mi mette in discussione, rendendomi responsabile nei suoi riguardi. Se applichiamo questa tesi al mondo degli animali ne discenderanno numerose questioni, prima tra tutte quella della violenza operata dall’uomo nei confronti degli animali e legittimata dalle Sacre Scritture:
Elohim disse: facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Che abbia dominio sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutte le fiere della terra e anche sui rettili che strisciano sulla terra[14].
Fin qui Dio attribuisce all’uomo la signoria sugli animali, successivamente gli comanda di dare un nome a tutti gli esseri viventi del creato. Dare un nome significa tracciare un limite, un confine invalicabile tra sé e l’altro, tra la soggettività e l’alterità del prossimo. L’uomo raggruppa sotto il termine animale una molteplicità di esseri viventi, separandoli da sé e ponendoli sotto il proprio dominio. Questa presa di distanza avviene attraverso la parola, quella funzione che l’animale non possiede e che rappresenterebbe con evidenza la sua assoluta estraneità all’uomo.
- Un vivente senza risposta
L’animale, che parola! L’animale è una parola che gli uomini si sono arrogati il diritto di dare. […] Si sono dati la parola per raggruppare un gran numero di viventi sotto un solo concetto: l’Animale, dicono loro. E si sono dati questa parola, accordandosi nello stesso tempo tra loro per riservare a se stessi il diritto alla parola, al nome, al verbo, all’attributo, al linguaggio delle parole e in breve a tutto ciò di cui sono privi gli altri in questione, quelli che vengono raggruppati nel gran territorio della bestia: l’Animale[15].
Gli autori presi in esame da Derrida, da Kant a Lacan, concordano nel considerare il linguaggio come l’elemento discriminante tra uomo e animale, anzi Ani-mot, l’animale-parola , come ironicamente viene chiamato da Derrida, che gioca sulla pronuncia francese, animaux infatti si legge allo stesso modo. Ebbene questo limite è come una linea irriducibile e insuperabile che divide due territori. Ma se esiste un confine, deve esistere una prossimità, perché il confine in realtà divide ciò che originariamente era unito, ossia la totalità vivente che viene marcata a fuoco da solchi divisori frutto di un’iniziativa umana del tutto arbitraria. È l’uomo a dividere con una linea il regno degli esseri viventi, a tracciare un confine tra sé e l’altro arrogandosi il diritto di intervenire, in modo spesso irreversibile, nella vita di altri viventi esercitandone il dominio:
Noi cacciamo, uccidiamo, sterminiamo, mangiamo e sacrifichiamo gli animali, li utilizziamo, li facciamo lavorare e li sottomettiamo a esperimenti che sono proibiti sull’uomo[16].
Ebbene la stessa tradizione filosofica cristiana giustifica il sopruso sull’animale da parte dell’uomo. Tommaso d’ Aquino infatti nella Summa Theologiae asserisce quanto segue:
Nessuno pecca per il fatto che si serve di un essere per lo scopo per cui è stato creato. Ora, nella gerarchia degli esseri, quelli meno perfetti sono fatti per quelli più perfetti. […] Perciò se l’uomo si serve delle piante per gli animali e degli animali per gli uomini, non c’è niente di illecito[17].
Gli fa eco Spinoza, che nella sua Ethica afferma:
Non nego, tuttavia, che i bruti sentano, ma nego che per questo non sia lecito provvedere alla nostra utilità, servirci di essi a piacere e trattarli come più ci conviene[18].
La prospettiva derridaiana muove proprio dalla volontà di decostruire la visione antropocentrica dell’universo. Si tratta di guardare il mondo e i suoi abitanti con occhi nuovi, con una sensibilità profondamente mutata. Gran parte della tradizione filosofica occidentale ha considerato l’essere umano come l’essere superiore a tutte le altre creature, meritevole del diritto di dominare la terra e gli animali che ne sono parte per organizzare la propria esistenza e realizzare i propri scopi. Si tratta di scardinare l’idea per cui il mondo sia fatto per l’uomo e per questo egli abbia il diritto di stabilirvi la propria egemonia.
Occorre osservare che in Tommaso e in Spinoza ricorre l’antitesi lecito-illecito. I filosofi la usano per costruire una giustificazione. Volendo usare una metafora giuridica, si tratta di una vera e propria memoria difensiva: gli uomini vogliono giustificarsi, discolparsi, argomentare un’apologia dello sfruttamento animale. David Hume ne era consapevole e infatti nel Trattato sulla natura umana dice:
Subito dopo il ridicolo di negare una verità evidente, c’è quello di darsi molta pena per difenderla e nessuna delle verità appare più evidente di questa: gli animali sono dotati di pensiero e di ragione come gli uomini[19].
Ebbene, la ragione per cui l’uomo si sente giustificato a usare violenza sull’animale si fonda principalmente sulla capacità logico-linguistica, facoltà di cui l’animale è privo, ciò che segna irreversibilmente la sua estraneità rispetto all’uomo, il suo essere totalmente altro. Precisamente, l’animale è privo della capacità di rispondere. Questa è la posizione assunta dai maggiori esponenti della filosofia occidentale, che Derrida prende in esame:
Malgrado le numerose differenze o contraddizioni che li separano e che non cercherò certo di minimizzare, Kant, Heidegger, Lévinas e Lacan, condividono, riguardo a ciò che essi chiamano l’ animale, un numero considerevole di ciò che io chiamerei credenze, e che voi potreste chiamare, se preferite, assiomi, o pregiudizi, presunzioni o presupposizioni. In ogni caso vorrei cercare di dimostrare che, come Descartes, essi pensano che, a differenza di noi uomini (differenza che viene così determinata), l’animale non parla né risponde, che la sua capacità di produrre segni è estranea al linguaggio e si trova limitata, fissata da un programma[20].
La risposta infatti si differenzia dalla reazione perché è libera, libera perché frutto di una scelta, di una consapevole decisione, mentre la reazione è circoscritta in uno schema comportamentale rigido.
Ne L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, di Arnold Gehlen – che con Max Scheler e Helmuth Plessner è il fondatore dell’antropologia filosofica contemporanea – la differenza tra uomo e animale viene indagata proprio alla luce di questa prospettiva: individuare un possibile spazio di libertà tra le pulsioni che avvincono l’essere vivente e le azioni del vivente stesso. È possibile che l’essere vivente vinca sulle proprie pulsioni, rimandandone l’appagamento in un futuro che potrebbe restare anche solo immaginario? Ebbene soltanto nell’essere umano si verifica uno iato, una separazione tra impulso e azione, perché soltanto in lui si esercita la funzione simbolica del logos, che media la percezione della realtà tramutandola in un universo linguistico in cui possa operare l’attività dell’intelletto. L’uomo è l’essere non specializzato, ossia privo di adattamento a uno specifico ambiente naturale, è l’unico essere vivente che conduce la sua esistenza piuttosto che semplicemente vivere, perché la sua vita è inesorabilmente votata al padroneggiamento del domani. Egli, per via della sua carenza organico-istintuale, deve necessariamente acquisire familiarità con il mondo, ossia appropriarsene mediante una visione simbolico-linguistica che gli consenta di trasformare l’infinito campo di sorprese in un campo dove è possibile agire, ossia trasformare la natura in modo utile alla propria vita.
Ebbene Gehlen attribuisce proprio al linguaggio il più alto valore di esonero e di familiarità con il mondo, affermando con chiarezza quanto segue:
comunicazione entro una sfera mondana illimitatamente aperta, orientamento e dimestichezza con il mondo, libera disponibilità delle cose nei simboli, esonero dalla pressione del presente e della presenza immediati – tutti questi risultati della vita umana in generale – […] solo il linguaggio sembra raggiungerli in sé, in modo concentrato e nel compimento più alto[21].
Proprio per questo motivo il linguaggio nasce e cresce nella struttura senso-motoria dell’essere umano; non solo, essendo la prestazione che realizza nel modo più efficace l’esonero dall’immediatezza del presente, esso consiste nell’elemento senso-motorio che governa lo sviluppo di tutte le prestazioni umane. Il linguaggio è insomma ciò che ci rende propriamente uomini e ci distingue dall’animale, l’essere senza risposta perché senza parola.
Ora, il principale capo d’accusa rivolto all’animale è quello di essere privo di logos, il che implica immediatamente l’essere privo di ogni sorta di diritto. Ma il logos, inteso qui in senso stretto, ossia come parola-discorso, è una capacità prettamente umana che non si ravvisa in nessun altro essere vivente. La facoltà di produrre suoni articolati e organizzarli secondo una grammatica generativa e ricorsiva è propria soltanto all’uomo. Per questo motivo, l’essere umano costituisce un’anomalia in natura, in quanto portatore di una costituzione organica carente e deficitaria che, come dimostrato dall’antropologia elementare di Gehlen, lo costringe a elaborare una visione simbolica del mondo, che per lui si presenta come un infinito campo di sorprese piuttosto che come un ambiente elettivo, foggiato ad hoc e tale che i suoi istinti vi siano ancorati. Ebbene il linguaggio nasce come disimpegno, esonero produttivo, come riscatto dalla pressione del presente. Non dunque, come manifestazione della superiorità - presunta - dell’animale sull’uomo. Ciò che dovrebbe legittimare la supremazia dell’uomo sull’animale è in realtà la manifestazione della sua debolezza, della sua manchevolezza, della sua costituzione organica carente e, per questo, bisognosa di un plus, di un qualcosa in più, per poter sopravvivere come tutti gli altri esseri viventi. L’essere umano ha bisogno del linguaggio per vivere in questo mondo perché ha bisogno di costruirsi una visione panoramica delle cose, un universo simbolico in cui la parte rimanda al tutto, l’indizio rimanda al totale, perché i suoi istinti non sono sufficientemente forti e sviluppati per permettergli di vivere liberamente in natura come fanno invece tutti gli altri esseri viventi. Secondo la prospettiva gehleniana quindi, il linguaggio è la manifestazione della struttura senso- motoria deficitaria dell’uomo, costretta a organizzare un sistema di esoneri produttivi tali che l’uomo possa avere visione simbolica del mondo. Eppure il logos è sempre stato considerato come il segno della superiorità dell’uomo rispetto a tutti gli altri esseri viventi, piuttosto che il segno della sua strutturale manchevolezza. Come sostenuto da Montaigne:
La presunzione è la nostra malattia naturale e originaria. La più calamitosa e fragile di tutte le creature è l’uomo e al tempo stesso la più orgogliosa. Essa si vede collocata qui, in mezzo al fango e allo sterco del mondo, attaccata e inchiodata alla peggiore, alla più morta e putrida parte dell’universo […] e con l’immaginazione va a porsi al di sopra del cerchio della luna. […] È per la vanità di questa stessa immaginazione che egli si eguaglia Dio, […] che trasceglie e separa se stesso dalla folla delle altre creature, fa le parti agli animali suoi fratelli e compagni e distribuisce loro quella porzione di facoltà e forze che più gli piace[22].
L’uomo è dunque l’animale malato, l’animale che ha negato la sua propria natura considerandola come un residuo irriducibile di materia e imperfezione, destinandola a piegarsi dinanzi alla forza dell’intelletto, dell’anima, della ragione. Ricordiamo a tal proposito le parole di Nietzsche espresse ne La gaia scienza:
Temo che gli animali vedano nell’uomo un essere loro uguale che ha perduto in maniera estremamente pericolosa il sano intelletto animale: vedono cioè in lui l’animale delirante, l’animale che ride, l’animale che piange, l’animale infelice[23].
Ma, facendo una reductio ad absurdum, ossia chiedendoci se l’animale rispondesse, le cose cambierebbero? L’uomo si sentirebbe ugualmente giustificato a usare loro violenza? Ebbene secondo Derrida non basta
rompere la tradizione cartesiana dell’animale-macchina senza linguaggio e senza risposta[24].
Questa tradizione ha condizionato profondamente ogni antropologia filosofica, perché ha influenzato la nostra concezione di alterità e di soggettività al punto che non sarebbe sufficiente
per un’etica ricordare al soggetto, come ha tentato Lévinas, il suo essere-soggetto, il suo essere-ospite o ostaggio, cioè il suo essere assoggettato all’altro, al Totalmente altro[25].
Occorre pensare la relazione tra il sé e l’altro da sé in termini completamente diversi, a partire a da una decostruzione del concetto di animal rationale, dato che la differenza tra uomo e animale è stata sempre determinata dal concetto di ratio.
Animal rationale è dunque la definizione dell’essere umano comunemente condivisa dalla filosofia, che però nello stesso tempo è foriera di non poche problematiche.
- Animal rationale?
Dopo tutte le critiche che ha potuto sollevare la teoria dell’animale-macchina al tempo dei Lumi, quando Kant riafferma la differenza dell’animale razionale che è l’uomo, lo fa a partire dall’“Io”[26].
Nell’Antropologia dal punto di vista pragmatico, Kant definisce l’uomo come colui che «può avere l’Io nella sua rappresentazione»[27], dove per “Io” si intende l’unità della coscienza che rimane se stessa in tutte le sue modificazioni. L’“Io” è l’“io penso”, l’unità dell’appercezione trascendentale che accompagna tutte le rappresentazioni.
Il soggetto, che è l’uomo, è una persona detentrice di ragione, morale e diritto. Per questo motivo la persona è un essere assolutamente differente per rango e dignità agli animali privi di ragione, considerati alla stregua di cose, su cui si ha potere e autorità. Questo potere sull’animale è l’essenza dell’“Io”, è l’essenza della “persona”, che, a differenza dell’animale, è in grado di presentarsi in una forma di presenza a se stessa che accompagna tutte le rappresentazioni. Questo “Io” eleva l’ essere umano al di sopra di tutti gli altri esseri viventi, ne legittima il dominio sulla terra, gli conferisce un rango superiore a ogni altra forma di vita su questo pianeta. L’animale invece, secondo Kant, non ha un “Io”, non è capace di presentazione o di rappresentazione poiché non possiede quella scintilla cosciente e autocosciente che gli permette di stagliarsi al di sopra della natura, al di sopra della catena causalistica degli eventi, spezzandone la necessità e dando inizio a una serie nuova nel tempo: l’animale non è libero, è schiavo dei suoi istinti perché privo di ragione, privo di pensiero. È nel pensiero che si sostanzia l’egoità della persona, questa presenza a se stessa, questo sé della presenza a se stessa,
questo “Io” singolare e universale, condizione della risposta e dunque della responsabilità del soggetto[28].
Insomma, anche secondo Kant, all’animale è preclusa quella relazione speciale con il mondo che è riservata solo all’essere umano, fatta di coscienza, autocoscienza, simboli e linguaggio. Come diceva Heidegger, l’animale è povero di mondo. Nel corso di lezioni tenuto nel semestre invernale del 1929-1930 all’Università di Friburgo sui Concetti fondamentali della metafisica: mondo, finitezza, solitudine, Heidegger, nell’affrontare il rapporto dell’animale con il proprio ambiente, prende in esame la teoria biologica di Jakob von Uexküll e afferma che:
Il confronto con le sue ricerche concrete è una delle cose più fruttuose che oggi la filosofia possa far propria della biologia dominante[29].
Il filosofo ritiene che lo status dell’animale sia caratterizzato da una povertà di mondo, riprendendo la teoria biologica di Uexküll secondo la quale l’animale è chiuso all’interno della propria Umwelt, riceve solo le impressioni per le quali è preformato in base alla sua struttura corporea e reagisce agli stimoli perché ha gli organi adatti. La perfetta armonia tra domande e risposte costituisce la vita e la realtà dell’essere vivente.
Ebbene Derrida, utilizzando la sua consueta strategia decostruzionista, propone una lettura diversa di questo seminario. In generale, sostiene che la questione affrontata da Heiegger sia relativa all’essenza della vita stessa, della vita intesa nella sua totalità, della vita di ciascun essere vivente. Ma in particolare, rispetto all’essere umano e contrariamente a quanto affermato da Kant,
l’intenzione di Heidegger è quella di definire l’essenza dell’uomo in altro modo che non attraverso la coscienza, in altro modo che non attraverso la ragione[30].
Pertanto,
non ci avvicineremo a esso fintantoché continueremo a considerare l’uomo come un qualcosa che si differenzia dalle cose materiali per il fatto di avere la coscienza, di essere un animale dotato di ragione, un animal rationale, o un io con delle pure esperienze vissute, ma legato a un corpo[31].
La questione della corporeità in questo contesto è di primaria importanza, perché rimanda al concetto di finitezza, tematica fondamentale nel seminario di Heidegger. La finitezza consiste nella possibilità di morire, una possibilità propria soltanto della
vitalità del vivente a differenza di ciò che è senza vita[32].
Ora, la vitalità del vivente è ciò che l’animale ha in comune con l’uomo. Pertanto, non è possibile parlare dell’essenza dell’animalità in generale, senza mai mettere in questione l’appartenenza di tutti gli esseri viventi a un’«essenza generale dell’animalità». La questione posta da Heidegger nella seconda parte del seminario è «l’essenza dell’animalità dell’animale», in opposizione a «l’essenza dell’umanità dell’uomo». Ma
l’animalità dell’animale possiamo determinarla soltanto se ci è chiaro che cosa costituisca la vitalità del vivente nel suo differire dal senza-vita, il quale non ha neppure la possibilità di morire. Una pietra non può essere morta, perché non vive[33].
Ebbene, implicitamente Heidegger dice che l’animale muore perché vive, perché appartiene alla stessa totalità vivente cui appartiene l’uomo. Si tratta di una posizione diversa rispetto a quella assunta dal filosofo in altri testi, in particolar modo in Essere e Tempo, dove si insiste sul fatto che l’animale non muore, semplicemente finisce di vivere. Derrida sottolinea un’importante differenza lessicale tra il seminario del ’29 e gli altri testi heideggeriani. Mentre in altre opere, in riferimento all’animale, Heidegger usa il verbo verenden, ossia finire di vivere, al seminario usa sterben, ossia morire. L’animale, a differenza della pietra che non muore perché non vive, muore perché vive. Tuttavia l’animale a differenza dell’uomo è povero di mondo. Che significa? Significa che ha subito una privazione, un torto, uno strappo? Non esattamente.
Anche la pietra è povera di mondo, ma non ha subito alcuna privazione. Privare non ha solo un significato negativo.
In altre parole: dire dell’animale che è povero di mondo è mostrare che ha mondo. E continuamente Heidegger dice delle cose deliberatamente contraddittorie, cioè che l’animale ha un mondo come “se non l’avesse”. L’animale è “privato” e questa privazione implica che abbia una capacità di sentire, di “sentirsi povero”, […], l’animale prova la privazione di questo mondo[34].
Derrida sostiene dunque che, se si vuole accusare Heidegger di mettere l’animale al di sotto dell’uomo, bisogna leggere più da vicino i Concetti fondamentali della metafisica,
per non dimenticare che egli intende fare un’altra cosa, cioè dire che questa povertà non significa un meno, che anzi in un certo modo essa significa un più: un sentire la privazione che evidenzia che l’animale può sentire qualcosa, mentre una pietra non ne è affatto capace[35].
Lo stesso Descartes, fondatore della teoria dell’animale-macchina, non accettava pacificamente la definizione di uomo quale animale razionale, come si legge nelle Meditazioni di filosofia prima.
Che cos’è però un uomo? Dirò che è un animale razionale? No di certo, che poi occorrerebbe ricercare che cosa è un animale, che cosa razionale, cosicchè da un solo problema, scivolerei in parecchi altri e ancora più ardui […][36].
In questo testo, Descartes propone una sospensione della definizione comune di animale razionale, che Derrida giudica necessaria affinchè si possa «raccogliere e presentare ciò che io sono»[37]. Dal concetto di io sono secondo Descartes, bisogna escludere l’animalità, ossia tutto ciò che riguarda l’auto-affezione, l’auto-mozione, il nutrirsi, il sentire, eccetera. Per delimitare l’accesso al puro io sono bisogna isolare ogni riferimento alla vita del corpo. L’unica cosa non separabile dall’io sono è, secondo Descartes, il pensiero:
Pensare? Ecco, ho trovato: è il pensiero la sola cosa che non può essermi sottratta. Io sono, esisto, questo è certo; quanto a lungo invero? Di certo per tutto il tempo che penso[38].
Che cosa dunque io sono? Una cosa che pensa, una sostanza pensante che irradia un corpo, il quale, nella tradizione materialistica e meccanicistica viene concepito come un automa, un meccanismo forgiato da un artigiano. Dice Descartes:
Suppongo che il corpo altro non sia se non una statua o una macchina di terra che Dio forma espressamente per renderla più che possibile a noi somigliante»[39]; e anche: «[...]i nervi della macchina da me descritta si possono benissimo paragonare ai tubi delle macchine delle fontane [...][40].
Ebbene Descartes dubitò su tutto,
ma non dubitò mai […] che l’animale fosse solo una macchina, arrivando perfino a fare di questa indubitabilità una sorta di condizione del dubbio, dell’ego come tale, come ego dubito, come ego cogito e dunque come ego sum[41].
Nel caso dell’animale non umano però, tale automa viene privato dell’io, del sé, l’animale non ha un’anima, ha solo un corpo. Quindi è solo una macchina, senza linguaggio e senza risposta.
L’animale non sceglie, non è libero, non parla, non risponde. Soprattutto, l’animale non pensa. Per questo motivo il cogito ergo sum di Descartes, che pone nel pensiero la condizione indispensabile dell’esistenza, esclude gli animali dal regno dell’essere, confinandoli in una dimensione ontologica altra rispetto a quella degli esseri umani. Eppure, l’animale è li che ci guarda. Noi siamo esposti al suo sguardo, perché l’animale è altro da noi, ci scuote e ci interroga, rendendoci responsabili nei suoi riguardi. L’animale possiede un punto di vista su noi, che possiamo ignorare, ma al quale non possiamo sottrarci. Perciò Derrida dice «il pensare comincia proprio da qui»[42], perché si tratta di un pensiero nuovo, che sospende la classica definizione di animale razionale per concentrarsi semplicemente sul concetto di animale in sé.
L’animale nudo di fronte a un altro animale. L’animale che dunque sono. Derrida sottolinea che quella congiunzione espletiva, quell’ergo,
serve non tanto a ricordare Descartes, quanto a farlo comparire[43].
Questo dunque ha funzione auto-deittica, perché esprime il fatto che il soggetto della proposizione mostra di esibire se stesso, puntando l’indice verso colui che dice io, verso se stesso appunto. Significa dire «eccomi», dire io ci sono, io sono qui. Ma l’animale non ha un io, perché non pensa: l’animale è solamente corpo, è una macchina. Se è privo del rapporto autodeittico, ossia «il rapporto con sé dell’anima e del pensiero»[44], l’animale-macchina è privo dell’ego, dell’ego cogito.
L’animale non ha un io, quindi non potrebbe dire «eccomi»; come sosteneva Kant, non è capace di presentazione né di rappresentazione, poiché non possedendo un io è privo di presenza a se stesso. Ma l’animale non dice in fondo «eccomi», a suo modo, indicandosi autodeitticamente in un: «sono qua», «sono io», quando obbedisce mansuetamente alla mia convocazione? Nel mondo animale diverse sono infatti le modalità di automostrarsi, di dire «eccomi, sono qui» modalità con le quali si dice io: ad esempio, l’esibizione seduttiva che nel mondo animale si dispiega in parate, musiche e colori, la quale suscita variamente riservatezze, ritrosie, pudori.
Il rapporto autodeittico in filosofia, invece, sembra essere legato unicamente al linguaggio. Soltanto il logos sembra essere cifra di un’anima, di una coscienza, di un io. Soltanto chi parla è. Soltanto chi parla ha diritto a essere considerato un tu. Appropriata in questo contesto è l’argomentazione di Voltaire:
Forse è perché io ti parlo che tu giudichi che io abbia il sentimento, la memoria, delle idee? Ebbene! Non ti parlerò: tu mi vedrai rincasare con aria afflitta, cercare una carta con inquietudine, aprire un armadio dove ricordo di averla rinchiusa, trovarla, leggerla con gioia. E tu ne deduci che io ho provato il sentimento dell’afflizione e del piacere, che ho memoria e conoscenza. Giudica dunque allo stesso modo questo cane, che non trova il suo padrone, che lo ha cercato per tutte le vie con grida dolorose, che rincasa inquieto e agitato, sale, scende, va di stanza in stanza, trova infine nel so studio il padrone che egli ama e testimonia la propria gioia con la dolcezza del suo mugolio, con salti e carezze[45].
Ebbene, l’animale mi guarda e io sono nudo davanti a lui. Il pensare, forse, comincia proprio da qui. Comincia un nuovo modo di concepire l’essere umano e di concepire l’essere vivente in generale, perché la nudità originaria del vivente, quella totalità unitaria divisa dal solco che separa l’animale dall’uomo, di fronte allo sguardo dell’altro al quale siamo esposti, riaffiora, potente e inarrestabile. È la vita stessa che nella sua immediatezza reclama il diritto di essere riconosciuta e rispettata in tutte le sue manifestazioni, senza differenze, senza esclusioni. Come sostiene Milan Kundera:
La vera bontà dell’uomo si può manifestare in tutta purezza e libertà solo nei confronti di chi non rappresenta alcuna forza. Il vero esame morale dell’umanità, l’esame fondamentale (posto così in profondità da sfuggire il nostro sguardo) è il rapporto con coloro che sono alla sua mercé: gli animali. E qui sta il fondamentale fallimento dell’uomo, tanto fondamentale che da esso derivano tutti gli altri[46].
[1] G. Dalmasso, Il limite della vita, Introduzione a J. Derrida, L’animale che dunque sono, tr. it. Jaca Book, Milano 2006, p. 7.
[2] T. W. Adorno - M. Horkheimer, Dialettica dell’Illuminismo, tr. it. Einaudi, Torino 2010, p. 134.
[3] G. Pettinato, La saga di Gilgamesh, Rusconi Libri, Milano 1992, p. 197.
[4] Erodoto, Le Storie, libro II, tr. it. Utet, Torino 2006, p. 255.
[5] Esodo, 8, 22.
[6] Aristotele, Politica, tr. it. Laterza, Roma-Bari 1993, p. 184.
[7] J. Derrida, L’animale che dunque sono, cit., p. 137.
[8] Ibid., p. 37.
[9] Ibid., p. 9.
[10] Ibid.
[11] Ibid., p. 39.
[12] Ibid., p. 47.
[13] Ibid., p. 58.
[14] Ibid., p. 48.
[15] Ibid., p. 71.
[16] Ibid., p. 138.
[17] T. d’Aquino, Summa Theologiae, libro 17, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1997, p. 166.
[18] B. Spinoza, Ethica more geometrico demonstrata, a cura di P. Sensi, Armando Editore, Roma 2002, p. 122.
[19] D. Hume, Trattato sulla natura umana, tr. it. Bompiani, Milano 2001, p. 679.
[20] J. Derrida, L’animale che dunque sono, cit., p. 137.
[21] A. Gehlen, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, tr. it. Feltrinelli, Milano 1988, p. 278.
[22] M. de Montaigne, Saggi, volume I, tr. it. Adelphi, Milano 2009, p. 187.
[23] F. W. Nietzsche, La gaia scienza, tr. it. Adelphi, Milano 2007, p. 165.
[24] J. Derrida, L’animale che dunque sono, cit., p. 173.
[25] Ibid.
[26] Ibid., p. 141.
[27] I. Kant, Antropologia dal punto di vista pragmatico, tr. it. Einaudi, Torino 2010, p. 57.
[28] J. Derrida, L’animale che dunque sono, cit., p. 142.
[29] M. Heidegger, I concetti fondamentali della metafisica. Mondo, finitezza, solitudine, tr. it. Il Melangolo, Genova 1992, p. 337.
[30] J. Derrida, L’animale che dunque sono, cit. p. 207.
[31] Ibid.
[32] Ibid., p. 234.
[33] Ibid.
[34] Ibid., p. 216.
[35] Ibid., p. 217.
[36] R. Descartes, Meditazioni di filosofia prima, in Opere filosofiche, vol. I, tr. it. Utet, Torino 1967, p. 673.
[37] J. Derrida, L’animale che dunque sono, cit., p. 116.
[38] R. Descartes, Meditazioni di filosofia prima, cit., p. 674.
[39] Id., L'homme, tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 1960, p. 120.
[40] Ibid., pp. 130-131.
[41] J. Derrida, L’animale che dunque sono, cit. p. 122.
[42] Ibid., p. 58.
[43] Ibid., p. 121.
[44] Ibid., p. 122.
[45] Voltaire, Dizionario filosofico, tr. it. Einaudi, Torino 2006, p. 345.
[46] M. Kundera, L’insostenibile leggerezza dell’essere, tr. it. Adelphi, Milano 1999, p. 288.