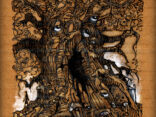Autore
Indice
- Le ragioni di una domanda
- È eludibile l’antropocentrismo?
- L’alterità assoluta delle piante
- Le ragioni di una risposta
↓ download pdf
S&F_n. 27_2022
Abstract
Is Plant Ethics really necessary?
This article aims at analysing the possibility and the need for a plant ethics within the field of applied ethics. Starting with an analysis of the symbolic and cultural representations of “nature” and with the connection with the material dimension of human relationality, it will move on to a speculative and synthetic analysis of the fundamental categories of environmental ethics (serving as a model for animal ethics and plant ethics), and then to renewed ontological representations that vegetal life can “show”, concluding with some propositions from which it is possible to answer positively to the question: is plant ethics really necessary?
ἀλλ’ὃσσα περ ζῆι, πάντα καὶ γνώμαν ἔχει
Epicarmo
- Le ragioni di una domanda
È una questione di presa di coscienza ex-post e di emergenza di problemi che sembrano divenire sempre più ingestibili. Ma è anche una questione che non può che muovere da un assunto: riconoscere dignità (qualunque cosa essa significhi – non è importante adesso) a un determinato ente, nel caso più lampante: l’umano, non ha condotto necessariamente a un rispetto dell’uomo da parte dell’uomo, neanche in quella specifica parte di mondo che è stata in grado di pensare qualcosa come la dignità umana e l’universalizzazione dei diritti. Considerazione morale, diritti umani e positivi, partecipazione etico-politica alla costruzione del comune: a questi dispositivi non tutti gli umani possono ancora accedere e non sembra che stiamo vivendo tempi promettenti affinché questo allargamento si produca. Eppure, tutta la vicenda complessa della costituzione di un’etica ambientale[1], di un’etica animale[2] e adesso di una possibile etica delle piante[3] rientra all’interno di una dinamica che intende allo stesso tempo allargare la considerazione morale a enti naturali altri (gli animali, certamente, ma anche le piante, e addirittura “oggetti” dalla complessa, se non impossibile, definizione epistemologica e ontologica come l’ecosistema, la biodiversità, etc.) e inchiodare l’Occidente e la sua cultura a determinate responsabilità morali, in questo caso nei confronti della Natura. Utilizziamo il termine Natura, almeno in questo contesto iniziale, volutamente con la iniziale maiuscola: non si tratta di definire preliminarmente cosa debba intendersi con il termine “natura”, non affrontiamo in questo contesto questioni di filosofia biologica o di biologia filosofica, ma di delineare i contorni di una utilizzazione culturale e simbolica di una determinata rappresentazione al fine di costruire determinate partizioni all’interno del reale, partizioni funzionali alla costruzione e alla soddisfazione di determinate esigenze e bisogni dell’umano (nel nostro caso: occidentale). La metodologia, il cammino che decidiamo di seguire, è quello di connettere rappresentazione culturale e simbolica e determinazione materiale (economico-politica) all’interno di una “spirale”: non si tratta semplicemente di reperire una struttura materiale di sfruttamento, nelle interazioni tra gli umani e tra l’umano e il mondo vivente e non vivente, tale da determinare le rappresentazioni culturali, né di cercare di dimostrare l’inverso, come alcune rappresentazioni culturali abbiano la capacità di determinare una struttura materiale di sfruttamento nelle interazioni tra gli umani e tra l’umano e il mondo vivente e non vivente – chiedersi, nell’umano, se viene prima il bisogno o la rappresentazione (culturale e simbolica) del bisogno è una domanda mal posta: il movimento che va restituito è quello di una spirale, un movimento ricorsivo ma non eternamente uguale a se stesso, che con-cresce mediante il continuo intrecciarsi di strutture materiali e rappresentazioni simboliche a un livello di complessità sempre maggiore. In questo senso, determinanti diventano gli spostamenti, dunque gli eventi, ovverossia le soglie di problematizzazione. Perché il problema, in questo momento e all’interno delle differenti etiche dell’ambiente, animale e delle piante, riguarda proprio ciò che è andato costituendosi come Natura all’interno della tradizione di pensiero occidentale e come questa “istituzione” di una certa Natura abbia impattato e favorito una determinata struttura di sfruttamento della “natura istituita”: nelle ricostruzioni culturali, si parte nella maggior parte dei casi da un’analisi storico-critica di questa attitudine di pensiero (dal “tradimento” socratico nei confronti della filosofia della natura al racconto biblico, come elementi fondativi, poi si passa alla soglia della modernità scientifica, da Galilei a Newton, e al dominio della dimensione tecnica/tecnologica nella contemporaneità) e la questione viene affrontata soprattutto dal punto di vista culturale e simbolico, vale a dire di relazione gnoseologica, ontologica e morale-individuale con l’alterità naturale; a partire dall’indubbio interesse in vista di un ripensamento della relazione etica che connette l’umano al suo mondo, la dimensione della relazione istituente con una determinata struttura materiale dello sfruttamento della Natura (di ciò che di volta in volta va a riempire questo “universale”: dunque, non solo in senso “ambientalista”, ma anche rispetto a una sorta di reductio ad naturam cui in passato sono andati in contro le donne, gli altri etnicamente intesi, etc.) va inquadrata in tutta la sua complessità.
Pierre Hadot ha raccontato in maniera magistrale i due atteggiamenti fondamentali dell’Occidente (sin dall’antichità greco-romana) nei confronti della Natura, l’atteggiamento prometeico (svelamento violento dei segreti di una “natura” pensata come “nemica” e “ostile”, di cui l’umano orgogliosamente non fa parte, almeno non del tutto) e l’atteggiamento orfico (svelamento pacifico dei segreti di una “natura” pensata come “amica” e “creativa”, di cui l’umano orgogliosamente fa parte, seppur non del tutto)[4], e a partire da questo quadro si potrebbero raccontare come i due atteggiamenti siano fortemente interrelati e funzionali l’uno all’altro, si potrebbero richiamare tutte le riflessioni che connettono il dominio violento o pacifico della natura esteriore (oggi, i paradigmi del “dominio” e del “pilotaggio” come risposta alla crisi climatica) al dominio violento o pacifico della natura interiore, si potrebbero richiamare le riflessioni su come il dominio violento o pacifico della natura sia connesso al dominio violento o pacifico su ciò che di volta in volta è stato considerato, nell’umano, più vicino alla natura, dal femminile all’alterità “selvaggia”, si potrebbe richiamare la maniera mediante la quale l’operatore “natura” abbia funzionato sia in senso negativo (questa o quell’altra realtà è inferiore perché vicina alla natura, a una dimensione naturale) o in senso positivo (questa o quell’altra realtà è superiore perché vicina alla natura, a una dimensione naturale) e si renderebbe conto dell’ambigua complessità nell’auto-rappresentazione dell’umano occidentale, che come un pendolo oscilla costantemente e in maniera funzionale tra questi due “opposti”. E così, quello che può essere di interesse è la maniera mediante la quale l’operatore Natura ha funzionato all’interno della rappresentazione dell’alterità, laddove nella tradizione occidentale l’alterità è sempre stata ciò che doveva essere ricondotta al Medesimo, mediante il monopolio dell’uso legittimo della forza delle armi materiali e culturali-simboliche[5]. Questa sorta di necessità di svelamento della Natura va pensato allo stesso tempo come un “bisogno” e come la “rappresentazione di un bisogno” – la “natura” è il primo spettacolo (proprio nel senso di: oggetto di visione) che si presenta all’umano: una “natura” può nascere solamente nel momento in cui si produce una determinata distanza all’interno di una prospettiva, il punto di vista del vivente umano, che non può più “vivere” l’immanenza assoluta della sua appartenenza immediata (nel senso di: senza mediazioni) al tutto vivente, e da un lato non può fare altro che provare un sentimento di rimpianto per la “perdita” già da sempre intuita, e dall’altro, trovando il mondo dinanzi a sé, sentire l’orrore e la fascinazione di un mistero angosciante, cercarne lo svelamento e sfruttarne le possibilità[6].
Non si può pensare questo “bisogno” attuale dell’umano occidentale di rielaborare la propria relazione morale con gli altri enti naturali – in questo momento sfumiamo le distinzioni e le alterità all’interno delle alterità – se non nei termini di una presa di coscienza ex-post: l’emergere di questi regimi discorsivi deve essere concepita come l’urgenza di una problematizzazione che viene allo scoperto nel momento in cui una determinata pratica, considerata fino a un certo momento “normale” e dunque “invisibile”, diviene in un certo senso “patologica” e dunque “visibile”. Una problematizzazione viene fuori sempre all’interno di un momento particolare della “spirale”, quando una determinata relazione tra dinamica culturale e simbolica e dinamica di sfruttamento materiale raggiunge un punto critico. Questa è la soglia dell’Antropocene. E allora: è davvero necessaria un’etica delle piante? Si tratta della domanda dalla quale abbiamo deciso di muovere, proprio nel senso del reperire questa problematizzazione connessa a una emergenza/urgenza. Le etiche applicate al mondo naturale rappresentano, dunque, allo stesso tempo il sintomo di una problematizzazione o di una “patologia” della libertà, e la difficoltà nel reperimento di una soluzione o, meglio, di una “cura”: nel momento in cui scindiamo il nostro rapporto con il mondo all’interno di comparti – ambiente, animale, pianta – e l’interesse si incentra su quale “considerazione morale” debba avere un determinato ente della natura con il quale entriamo in contatto, se questa “considerazione morale” debba basarsi su elementi che per analogia possiamo ritrovare nell’umano o invece esclusivamente nell’unicità di quell’ente, quando insomma rischiamo di disincarnare la dimensione etica dalle altre dimensioni complesse dell’intervento dell’umano nel mondo, di cosa è rappresentazione la domanda: è davvero necessaria un’etica delle piante? E ancora: questa impostazione che andiamo proponendo non rischia di essere essa stessa una versione dell’antropocentrismo tipicamente occidentale?
A partire da queste annotazioni introduttive – ma che sono già parte integrante del ragionamento – si passerà, a partire dalla domanda se l’antropocentrismo sia o meno eludibile, a un’analisi speculativa e sintetica delle categorie fondamentali dell’etica ambientale (che fanno da modello per l’etica delle piante), per poi approdare a rappresentazioni concettuali rinnovate che le piante possono “produrre”, concludendo con alcune proposizioni a partire dalle quali è possibile rispondere positivamente alla domanda: è davvero necessaria un’etica delle piante?
- È eludibile l’antropocentrismo?[7]
L’etica dell’ambiente rappresenta un filone della filosofia morale, sviluppatosi a partire dagli anni ‘60 del XX secolo, che nasce dall’idea che sia necessario superare i limiti della rappresentazione morale classica, secondo la quale soltanto gli umani sarebbero dotati di status morale e quindi degni di considerazione morale[8]. Secondo l’impostazione per certi versi ormai “classica”, la storia dell’etica occidentale può essere letta nei termini di una storia dell’estensione dei limiti della moralità, prima all’interno dell’umano, poi oltre l’umano. Il problema centrale, dunque, di ogni etica dell’ambiente è rappresentato dall’annosa questione dell’antropocentrismo. Nell’ormai vastissima letteratura, si ritrova solitamente un inquadramento antropocentrico, secondo il quale la “natura” (qualunque cosa essa indichi) ha valore soltanto nella misura in cui rappresenta un mezzo per la realizzazione di determinati fini umani: la necessità della conservazione, dunque, o sta nel fatto che la “natura” ha un’utilità determinante per le attività di crescita economica umana – posizione oramai perlopiù squalificata; oppure consiste nel fatto che essa è utile alla vita umana perché capace di suscitare atteggiamenti di ammirazione e fascinazione e quindi condurre a una “crescita” morale del soggetto umano “spettatore” – si tratta, ad esempio, della classica impostazione dei “doveri indiretti”. Si ritrova poi un inquadramento non-antropocentrico, secondo il quale la “natura” (qualunque cosa essa indichi) ha valore in sé, al di là dei fini umani; le strategie argomentative adottate sono solitamente due: la prima sottolinea come il valore della “natura” e/o dei singoli enti naturali derivi da alcune caratteristiche generali che essa/essi presenta(no), quali la soggettività, la capacità di provare piacere e dolore, etc., e si fondi sull’idea della possibile (e necessaria) estensione di caratteristiche umane agli altri enti naturali; la seconda intende dimostrare come il valore della “natura” e/o dei singoli enti naturali non derivi da caratteristiche che condividerebbe(ro) con la natura umana, bensì consista nella sua/loro assoluta alterità. La conservazione della “natura”, in questo caso, non riguarda la sua importanza per i fini umani, bensì si posiziona esclusivamente sul piano deontologico del rispetto morale.
Il problema – e questo è uno dei punti centrali di queste brevi riflessioni – sta proprio nella complessa dinamica dell’antropocentrismo, il quale sembra essere per certi versi ineludibile. Come abbiamo visto, l’inquadramento non-antropocentrico si fonda sull’idea che la “natura” abbia un valore-in-sé, al di là dei fini umani. Ebbene: chi determina questo valore-in-sé? qual è la sua origine, la sua fonte? Sembra essere evidente che la determinazione di questo valore provenga da un vivente particolare, con un punto di vista particolare, il vivente umano, che tra le sue caratteristiche peculiari presenta quella del “porre-i-valori”. La questione si complica: immaginando un universo privo di intelligenza senziente, gli enti naturali (dal mondo inanimato fino agli animali e alle piante, passando per ecosistemi, etc.) avrebbe oppure no valore-in-sé? Esiste un valore-in-sé, al di là del fatto che qualcuno/qualcosa possa coglierlo e “pensarlo”, o un valore-in-sé può esistere soltanto nella misura in cui è contemporaneamente un valore-per-qualcuno che lo riconosce? E nel caso: valore-per-chi? Il valore deve avere necessariamente un’origine esterna – un soggetto da cui “emana” – o è “inerente” alla “natura” e/o agli enti naturali? Senza una soggettività, senza uno spettatore/attore senziente, ha senso parlare di valore inerente? Un orso bianco porrebbe la questione del valore-in-sé del tricheco (e viceversa)? Infine: ragionare nei termini di valore-in-sé non significa reificare, oggettivare, astrarre dal flusso processuale un “qualcosa” al di là delle relazioni che instaura e lo formano? L’antropocentrismo ontologico, scacciato dalla porta, sembra rientrare dalla finestra come antropocentrismo valoriale o assiologico. Ma non è tutto. Antropocentrismo e non-antropocentrismo si scontrano, sempre all’interno dell’inquadramento cosiddetto non-antropocentrico, anche su un altro livello di riflessione. Si tratta di quella che viene chiamata “strategia dell’estensione”: estendere caratteristiche umane (capacità di essere un soggetto, capacità di provare piacere e dolore, capacità di vivere una vita che può andare bene o male, etc.) agli enti naturali significa compiere un gesto antropocentrico o non-antropocentrico? Antropocentrico, in quanto si ritiene che il modello di sensibilità, intelligenza e buona vita sia quello umano, da estendere poi agli altri enti naturali; non-antropocentrico, in quanto si ritiene che sensibilità, intelligenza e buona vita appartengano all’umano così come agli altri enti naturali, cancellandone così la centralità prometeica. Al di là della forse eccessiva stilizzazione dei ragionamenti, si tratta comunque di una compresenza. Prendiamo ad esempio la caratteristica della “capacità di essere un soggetto”: secondo Peter Singer e Tom Regan gli animali sono da considerarsi rispettivamente soggetti di interesse e soggetti di diritto[9], così come per Matthew Hall[10] e Michael Marder[11] sono da considerarsi soggetti – seppur in maniera radicalmente e qualitativamente differente – anche le piante; la filosofa Jane Bennett[12], a partire da un’ontologia di stampo spinoziano, parla di una materia con caratteristiche di soggetto agente, mentre Bruno Latour, con la sua teoria degli attanti, ritiene che anche le cose inanimate hanno agency, vale a dire la capacità di modificare uno stato di cose[13]. Ebbene: l’essere-soggetto dell’umano è lo stesso dell’essere-soggetto di un cane, di una palma, di un batterio o di una pietra? Abbiamo una definizione di essere-soggetto univoca, sulla quale basarci per il reperimento di alcune sue caratteristiche nella realtà umana, animale, vegetale o inanimata? In realtà, non l’abbiamo neanche per l’umano. Focalizzandoci sul mondo vegetale, tutto appare ancora più complicato: nonostante studi innovativi e rivelatori sulla neurobiologia delle piante (cui faremo cenno nel corso della riflessione), in che misura esse possono essere definite dei “soggetti”? In più: ha senso chiederselo? chiederselo significa compiere un gesto antropocentrico o non-antropocentrico?
Ma non è soltanto questione di soggettività. Passando alla questione della “capacità di provare piacere o dolore”, è possibile ritrovare questa facoltà nelle piante? Ha senso ricercarla con caratteristiche che siano simili a quelle del vivente umano e animale? Non si tratta di antropocentrismo o, comunque, di zoocentrismo?
Arrivando infine all’astrazione massima della strategia dell’estensione, vale a dire l’idea secondo la quale tutto ciò che è dotato di “vita” ha valore-in-sé, non dovremmo forse chiederci e definire prima che cosa è “vita”? È una risposta che può essere data in maniera univoca? Un cane, una palma, un batterio, o ancor di più “oggetti” indefinibili come un ecosistema, conducono la stessa “vita” di un umano (e la stessa tra di loro)? La “vita” è una caratteristica/qualità che posseggono determinati “enti” o è un processo complessivo di cui i singoli “enti” sono forme di manifestazione “parziale”? Gli attanti inanimati di Latour, questa pietra o quella montagna, per il fatto di avere agency, hanno una “vita”? Pensare come una montagna[14] è per l’umano un tentativo antropocentrico o non-antropocentrico? Infine: se la “natura” e/o gli enti naturali hanno valore-in-sé, nella loro assoluta alterità e irriducibilità all’umano, di che valore si tratta? Se è radicalmente altro, è possibile davvero reperirlo? Chi sarebbe in grado di svelarlo? La risposta è sempre l’umano e l’alterità assoluta sembra comunque un limite invalicabile. E ci troviamo nuovamente dinanzi all’ipotesi di un antropocentrismo valoriale o assiologico.
La cosiddetta etica delle piante rientra pienamente – anche a partire da qualche accenno già fatto – all’interno di questa complessità. E rispetto all’animale, la questione è sicuramente più problematica. Quelli che sono stati definiti i tre approcci fondamentali della Plant Ethics[15] sono i seguenti:
- Non-moral yet inclusive approach, secondo il quale «la vita delle piante è decisamente importante per la vita degli esseri umani e degli animali non umani» per cui «le piante hanno valore e importanza morale perché sono elementi insostituibili della buona vita degli esseri senzienti che abitano il pianeta Terra» – si tratta di un approccio definito “ecumenico” in quanto «accoglie ragioni estetiche, prudenziali, narrative e scientifiche per valorizzare e rispettare le piante, e le unisce a ragioni morali che si riferiscono al bene degli umani e degli altri animali» e che «parla spesso il linguaggio della giustizia: proteggere le foreste, la biodiversità botanica, le popolazioni di piante e le singole piante è in molti casi un modo per essere giusti nei confronti di tutti quegli esseri umani e animali non umani che possono in vari modi beneficiare del mondo vegetale oggi e in futuro»[16].
- Relational approach, secondo il quale «il valore e l’importanza morale delle piante non discendono dallo status ontologico e morale delle piante, ma emergono piuttosto all’interno delle pratiche umane che si riferiscono alle piante» per cui «gli approcci relazionali non parlano tipicamente il linguaggio dei doveri e degli obblighi, ma quello della cura e della virtù»[17].
- A value-in-nature approach, secondo il quale non sono da mettere in evidenza «le nostre ragioni per dare valore alle piante, né il nostro rapporto con esse, ma piuttosto i valori delle piante stesse», anche se non si tratta della «ricerca del valore intrinseco delle piante […]: si tratta piuttosto di un’esplorazione di valori concreti, empiricamente testati nella, della e per la vita delle piante, tra cui l'integrità e la prosperità»[18].
All’interno di questa sintesi molto efficace si ritrovano molte delle complessità e delle articolazioni dell’etica ambientale e animale cui abbiamo fatto un seppur troppo rapido cenno all’interno di questo paragrafo. Si tratta di approcci che comunque tendono spesso a integrarsi o a incrociarsi in maniera critica. Nonostante questo campo di studi sia piuttosto recente, le pubblicazioni e le articolazioni sono già numerose. Troviamo il punto di vista “utilitarista”, secondo il quale le piante non sono da considerarsi soggetti di benessere, per cui il nostro comportamento morale nei confronti di esse può essere giustificabile soltanto a partire dal benessere umano e animale che ne deriva, dunque l’etica delle piante non può che essere indiretta e derivativa[19]. Abbiamo poi il punto di vista del “valore inerente”, secondo il quale le piante hanno tale valore nella misura in cui hanno “interessi” in quanto enti naturali teleologicamente organizzati dalla dinamica della selezione naturale – le complessità di questa posizione muovono dall’idea che, dunque, anche batteri e artefatti dovrebbero così avere interessi, in quanto enti organizzati a partire da una finalità intrinseca[20]. Ci sono poi le teorie del “fiorire” su base neo-aristotelica, secondo le quali il “fiorire” può divenire una sorta di metro di giudizio a partire dal quale valutare se la nostra relazione con le piante conduca a forme di danneggiamento o di beneficio, con il vantaggio di avere al centro una nozione che proviene dalla scienza botanica e non da una dimensione valoriale antropocentrica[21] – qui il pericolo è sempre quello di incorrere nella fallacia naturalistica. C’è poi chi riflette a partire dal concetto kantiano di “dignità” (che nel filosofo tedesco può essere ricondotto soltanto all’umano, in quanto agente morale razionale) e sulla difficoltà di fondo dell’estensione dei concetti dell’etica umana all’etica delle piante, in quanto determinati concetti costruiti per un “regno” difficilmente possono essere adeguati per un altro “regno”[22]. Ci sono poi gli approcci relazionali: secondo Coeckelbergh, ad esempio, l’analisi dal punto di vista ontologico o metafisico del regno delle piante potrebbe non essere la via più percorribile per giungere a un’etica delle piante, la quale dovrebbe piuttosto muovere dalla relazione con l’umano e mediante un dialogo tra il punto di vista umano e quello vegetale, e puntando su un’etica pratica e contestuale[23]; mentre Schörgenhumer punta invece sulla questione della “cura” e delle virtù a essa connessa[24].
All’interno di questo ampio panorama (che non pretende comunque di essere esaustivo), sorgono due questioni. La prima è che sembra essere chiara la mancanza di un ragionamento che muova dalla “spirale” di cui discutevamo nell’introduzione al saggio (la relazione “complessa” tra il dominio culturale e simbolico e il dominio economico-politico, tra la rappresentazione del bisogno e il bisogno), e le ragioni di questa mancanza sarebbero anche esse da analizzare dal punto di vista etico. Da qui la domanda: è possibile immaginare, ai tempi dell’Antropocene e della crisi climatica conclamata, una riflessione morale per certi versi slegata dalle urgenze politiche? La seconda concerne ancora una volta la questione dell’antropocentrismo: se è vero che la riflessione sull’etica delle piante deve muovere da qualcosa come il riconoscimento di un’alterità assoluta, che può essere appunto “riconosciuta” non in maniera mai complessiva ma attraverso uno sforzo non solo scientifico ma anche “immaginativo”, è altrettanto vero che questo riconoscimento non può che provenire dall’umano, dal punto di vista umano. Questa tipologia di sforzo intellettuale e immaginativo può portare con sé forme di destabilizzazione delle consuetudini simboliche e culturali e, inserendosi nella “spirale”, modalità di ripensamento di una serie di categorie economico-politiche, che nell’Antropocene non regolano soltanto l’umano ma sono a fondamento dell’intera possibilità futura della relazionalità vivente nel Sistema Terra. Si tratta in parole semplici di mostrare come il “riconoscimento” dell’alterità assoluta di un ente naturale possa portare con sé un ripensamento della dimensione simbolica e culturale di comprensione dell’alterità con possibilità di trasformazioni nelle relazioni materiali tra gli umani, tra i viventi umani e i viventi nonumani, e tra i viventi umani e la realtà tutta del Sistema Terra. Si tratta in parole ancora più semplici della rappresentazione di una necessaria riattivazione del modello immaginativo dell’utopia.
Si può ritenere che questa posizione sia del tutto antropocentrica – necessità di un’etica ambientale, animale e delle piante in vista del benessere umano –, ma in realtà si tratta di una forma tutt’al più di “antropocentrismo debole”[25], nella misura in cui il benessere umano, nell’epoca dell’Antropocene, non può essere più scisso, neppure simbolicamente, da un riconoscimento di un benessere “ambientale”, animale e vegetale. Il benessere è un inter-esse comune. L’inter-esse può essere inteso in senso strumentale e individuale oppure come valore comunitario che trova nell’“inter” la matrice della comunità biotica. Nel secondo caso, l’unico ovviamente all’altezza della sfida del cambiamento climatico, la costruzione di questo inter-esse comune oltrepassa le distinzioni tra le differenti forme di ben-essere e muove dal riconoscimento di una complessa relazionalità e processualità, sempre metastabili e sempre da stabilizzare. Una relazionalità e una processualità che sono allo stesso tempo ontologiche ed etico-politiche: se è vero che, dal punto di vista filosofico, è sempre difficile – se non “scorretto” logicamente – costruire un processo deduttivo che mostri il passaggio da una certa descrizione dell’essere a una certa prescrizione del dover essere, è almeno altrettanto vero che l’ingiunzione delle etiche ambientale, animale e delle piante non può che fondarsi da un lato sul riconoscimento della processualità e relazionalità ontologica e situazionale di cui uno dei poli (ma anche uno degli “effetti”) è necessariamente l’umano e dall’altro sulla necessità di un ripensamento della dimensione del politico a partire da un ripensamento radicale dei modi di produzione, consumo e sviluppo dell’umano. Che si ritenga che debba essere antropocentrica o non-antropocentrica, l’epoca critica dell’Antropocene e del surriscaldamento globale non può che muovere da un lato dalla necessità di una riattivazione della “spirale”, dall’altro dalla consapevolezza che, arrivati a questo punto critico, non vi è più grande distinzione tra una benessere umano, animale, vegetale, della vita nel suo insieme (qualunque cosa significhi “vita”). E che la costruzione di questo benessere deve passare allo stesso tempo per un ripensamento delle rappresentazioni simboliche e culturali e per una ristrutturazione delle relazioni materiali inter- e intra- specifiche. Se è vero che l’etica può essere una questione soltanto umana (gli enti naturali non agiscono o scelgono di agire in chiave etica) e quindi antropocentrica, è altrettanto vero che l’inter-esse, inteso in senso relazionale e processuale, apre a una rappresentazione della “natura” non-antropocentrica. Ma anche la rappresentazione resta una questione umana, troppo umana.
- L’alterità assoluta delle piante
Discutere dell’alterità assoluta delle piante – e, muovendo da questa, sul senso di un’etica delle piante – significa lavorare a partire dal punto di vista scientifico, mediante il reperimento delle novità che provengono dalla neurobiologia delle piante, e dal punto di vista filosofico, mediante un ripensamento del significato ontologico e metafisico della vita vegetale.
Iniziamo dal punto di vista scientifico. Prima di analizzare alcuni aspetti del contemporaneo campo di studi della neurobiologia vegetale, bisogna sottolineare come una prima comprensione del fatto che le piante siano esseri senzienti e attivi provenga da Charles Darwin[26]. Il grande naturalista inglese ragiona a partire da alcuni elementi: il primo concerne il fatto fondamentale che per comprendere la complessità della vita vegetale occorra analizzare le parti terminali delle radici, le quali rappresentano un vero e proprio organo di senso che registra differenti parametri e può reagire a essi; il secondo è che nelle piante – nelle parti terminali delle radici – esistono movimenti che è possibile considerare “intelligenti”, mediante una sequenza dimostrabile di percezione di stimoli dall’ambiente, decisione su quale direzione prendere, attuazione del movimento finale. In poche parole, si tratterebbe di una prima intuizione di quella che è possibile definire come intelligenza diffusa delle piante.
Secondo i più recenti studi di neurobiologia vegetale[27], le piante, pur non possedendo un cervello e un sistema nervoso centrale, presentano una forma di intelligenza molto complessa: esse infatti posseggono diverse migliaia di “reti cerebrali” (i meristemi), collocate sulle parti terminali delle radici, e interconnesse mediante dei particolari filamenti vascolari, definiti (per analogia) come dei veri e propri “neuroni”. Un sistema nervoso decentralizzato non significa un sistema nervoso “inferiore” o “imperfetto” (al di là del fatto che superiorità/inferiorità e perfezione/imperfezione non sono e non dovrebbero essere categorie biologiche), presenta invece dei vantaggi per esseri viventi la cui specializzazione è il non-movimento: i migliaia di cervelli di ogni singola pianta permettono a essa di integrare le informazioni sensibili e di attivare una comunicazione tra i tessuti in grado di far “prendere decisioni” alle piante. Le piante possono “decidere” ad esempio di “produrre” elementi biochimici per mutare la propria condizione e relazione con l’ambiente: in presenza di agenti patogeni, possono produrre sostanze difensive (antifungini, ad esempio) o, in presenza di un suolo povero di fosforo, possono produrre sostanze, come enzimi e acidi organici, in maniera tale da arricchirlo. Se percepiscono un pericolo nella crescita delle piante nelle vicinanze, possono produrre metaboliti che ne frenano lo sviluppo. Sembra inoltre che le piante, in qualche modo, abbiano una percezione articolata del proprio ambiente, a tal punto da “interagire” non solo con altri vegetali ma anche con animali: si è dimostrato, dal punto di vista empirico, che alcune piante, attaccate da erbivori, sono in grado di emettere sostanze che avvertono della presenza del pericolo le piante vicine, le quali attivano così le proprie difese chimiche contro l’“attacco”[28]. Semplificando al massimo, le evidenze scientifiche mostrano come le piante non siano assolutamente assimilabili ad automi passivi e con risposte meccaniche, ma siano forme-di-vita complesse, attive e intelligenti. Di un’intelligenza di difficile comprensione per l’umano, perché radicalmente differente. Cosa significa infatti possedere un cervello diffuso? Di che tipo di intelligenza si tratta? Come definirla? È possibile definirla per analogia con l’intelligenza animale o umana? Cosa può insegnarci?
Dal punto di vista filosofico, il tentativo di riflessione ontologica e metafisica più articolato è sicuramente quello di Emanuele Coccia[29]. Secondo il filosofo italiano, il nostro mondo è innanzitutto un “fatto vegetale”: il meccanismo dell’autotrofia – il fatto di trasformare in vita la luce, la materia e l’aria, costituendo così il mondo per gli animali e gli umani – è il motivo per cui le piante sono da interpretare come vere e proprie costruttrici di mondi, vere e proprie potenze cosmogoniche (Coccia parla di “tono esiodeo” da rilanciare nella botanica[30]). Il nostro “mondo”, ciò che chiamiamo “natura”, è un fatto vegetale in due sensi, sia perché è “creato” dalle piante e dalla loro attività di fotosintesi, sia perché l’organismo animale è formato completamente da materiale organico creato dalle piante. Se a questo si aggiunge il fatto che il 90% della massa eucariotica del pianeta è formato da piante e la maggior parte degli oggetti e degli strumenti che noi viventi umani utilizziamo deriva dalle piante, è possibile dunque affermare che tutta la vita animale superiore si nutre e deve l’esistenza, in senso ontologico, a questa facoltà cosmogonica delle piante. Dal punto di vista epistemologico, le piante mettono definitivamente in crisi quello che è l’assunto fondamentale delle scienze biologiche e naturali degli ultimi secoli, l’idea di una priorità dell’ambiente sul vivente; sono i viventi – e innanzitutto le piante – a creare l’ambiente in cui vivono, per cui la relazione di adattamento è molto più complessa e imbricata, si tratta di una vera e propria co-costruzione, nonché di una complessificazione del rapporto tra contenente e contenuto. Porsi al livello della vita delle piante significa ripensare tutta una serie di abitudini concettuali. Innanzitutto, cosa debba intendersi per “vita”: se è vero che gli animali superiori hanno bisogno gli uni della vita degli altri, così come gli umani hanno bisogno della vita prodotta dagli altri animali e dalle piante, lo studio delle piante fa comprendere come esse non abbiano bisogno della vita altrui (perché la ricavano dalla realtà inanimata), ma siano esse stesse creatrici di vita, in grado di modificare mondi per la diffusione e l’esplosione delle forme-di-vita. Il principio fondamentale è quello della “metamorfosi”, in quanto le piante hanno la caratteristica di coincidere pienamente con le forme che creano – l’immediatezza della trasformazione, il fatto che in una pianta generare significa trasformarsi, mutare la propria forma, rappresenta l’opposto della concezione astratta della creazione e della tecnica umane. La genesi delle forme nel mondo delle piante raggiunge un elevato livello di intensità: rispetto agli animali superiori in cui lo sviluppo si arresta, la pianta rappresenta «un’inarrestabile macchina morfogenetica» capace di costruire nuovi organi e parti di cui sono state private: «il loro non è mai un corpo definitivamente dato, ma un atto costante di bricolage somatico […] un atto incessante di autodesign»[31]. In questo senso, “mondo” e “natura” coincidono, in quanto «il mondo non è l’insieme logico di tutti gli oggetti, né una totalità metafisica di esseri, ma la forza fisica che attraversa tutto ciò che si genera e si trasforma» e la «natura non designa quel che precede l’attività dello spirito umano, né ciò che si oppone alla cultura, ma ciò che permette a ogni cosa di nascere e di divenire»[32]. E si presenta nuovamente la questione dell’antropocentrismo, a partire dall’espulsione della natura dallo sguardo filosofico e la sua riduzione a «oggetto puramente residuale, opposizionale, per sempre incapace di occupare il posto di soggetto»[33]. Si tratta, dunque, di una rimozione, «quella del vivente e del fatto che ogni conoscenza è già espressione dell’essere della vita», quella del fatto che «il mondo è il respiro dei viventi», quella del fatto che «ogni conoscenza cosmica è un punto di vita (non solo un punto di vista) e ogni verità non è che il mondo nello spazio di mediazione del vivente»[34]. Rifondare una “cosmologia”, questo il compito dell’unica filosofia possibile oggi, secondo Emanuele Coccia, una cosmologia che muova dall’esplorazione del mondo delle piante. Nella costruzione del discorso del filosofo italiano non è presente una riflessione sulle conseguenze etiche di una tale impostazione filosofica, definita “metafisica della mescolanza”, ma c’è l’idea (seppur non espressa, ma che noi riteniamo di poter derivare) che, nel momento stesso in cui muta la rappresentazione ontologica e cosmologica del mondo-natura, allora si produrranno forme nuove di relazione etica tra i viventi. Richiamando l’impostazione di Michael Marder, è possibile affermare che, se in senso levinasiano l’etica è sempre relazione con un’alterità assoluta, allora la vita vegetale merita particolare rispetto etico[35]. Sulla differenza delle piante e la necessità di un’etica delle piante post-moderna si interroga Karen Houle, la quale ricostruendo nell’umano una relazione tra strutturazione del “corpo biologico” e strutturazione del “corpo di pensiero”, sottolinea come l’impostazione filosofica dominante sia caratterizzata da opposizioni binarie che richiamano la bi-lateralità sinistro-destro del corpo biologico umano; ebbene, la fisiologia delle piante fa saltare questo schema, nessuna bi-lateralità ma una crescita di tipo rizomatico, per cui ispirarsi alla biologia della vita vegetale può indicare una strada per andare oltre il pensiero binario e può fondare, su questa unicità assoluta, la possibilità di un’etica delle piante come base per un’etica complessiva[36]. Come suggerisce Sylvie Pouteau, la particolare natura delle piante – l’apertura, il non essere auto-centrate, il vivere in uno spazio non formalizzato in modo euclideo – può permettere di pensare nuove ontologie, epistemologie e prospettive etiche[37].
In conclusione, le riflessioni di carattere scientifico e filosofico che abbiamo sintetizzato incrociano immediatamente la possibilità di un’utilizzazione simbolica e culturale di questa “alterità” per un miglioramento del mondo umano e della relazione etica con l’ambiente in generale. Ancora l’ineludibile antropocentrismo. Riconoscere come le foreste davvero parlino[38], al di là delle rappresentazioni degli indigeni, ma a partire da una metaforica per certi versi accettabile oggi anche in senso scientifico, cosa significa? Riconoscere nelle piante qualcosa che può essere di insegnamento per la nostra cultura e civiltà, cosa significa? Significa che un’etica delle piante può essere necessaria, nella misura in cui, partendo dall’assunto che si trovava nelle prime righe del saggio – riconoscere dignità a un determinato ente non conduce necessariamente a un rispetto di quell’ente –, soltanto riconoscendo la complessità sempre differente e sempre articolantesi l’una sull’altra della vita umana, della vita animale e della vita vegetale, è forse possibile immaginare un modo differente di cogliere le connessioni fondamentali tra gli enti e dunque, in quanto etica e politica sono forme che assumono la gestione della relazionalità nell’umano, un allargamento e un miglioramento della relazionalità tra umani, tra viventi umani e viventi nonumani, e tra viventi umani e natura inanimata – vale a dire: rendere effettiva l’estensione della considerazione morale all’interno di un progetto di trasformazione dell’esistente.
- Le ragioni di una risposta
Il tempo dell’Antropocene ci ha mostrato come i cosiddetti limiti planetari, il mantenimento dei quali permette al sistema di riequilibrarsi, possano nell’arco di qualche decennio essere definitivamente sorpassati. Oltrepassare tali “limiti” significherebbe dare avvio a un processo di turbolenza che limiterebbe la possibilità di una qualunque forma di “previsione” sul possibile andamento dell’intero Sistema Terra, andamento che potrebbe essere particolarmente “disordinato” per diversi millenni (se non decine di millenni), ponendo fine alla fase di cosiddetta “pace climatica” (l’Olocene) che ha permesso lo sviluppo rapido e impetuoso delle civilizzazioni umane. Al di là dell’impossibilità di una previsione per certi versi “esatta” dell’evoluzione di un sistema complesso che “agisce” in maniera stocastica, ma partendo dal presupposto che è comunque identificabile un trend o andamento, riflettere sulla domanda è davvero necessaria un’etica delle piante? significa allo stesso tempo porsi all’interno di un orizzonte che può contemplare la catastrofe e cercare gli strumenti adeguati, dal punto di vista culturale e simbolico e dal punto di vista materiale, per una trasformazione radicale dei sistemi di pensiero e vita globali (cioè la “spirale” tra elementi simbolici ed elementi economico-politici). Sembra essere estremamente probabile, e questo punto di vista non appartiene soltanto a determinate prospettive di politica complessiva, che l’attuale organizzazione dell’economia di produzione e consumo globale (e sempre più globalizzantesi) non sia più, non solo nel lungo periodo ma anche in quello medio e forse breve, sostenibile. Non è più sostenibile una determinata modalità di organizzare la “trasformazione” tecnica del mondo naturale per fini umani e non sono più sostenibili le rappresentazioni culturali e simboliche “classiche” e quelle che si vorrebbero “nuove” e “ottimistiche” e che rilanciano l’idea che, per immunizzare gli effetti degli impatti antropici, sia necessario accelerare proprio gli interventi di carattere antropico[39]. In questo senso, non si è compiuto nessun passo in avanti – anche ragionando esclusivamente a partire dal versante etico – all’interno di un percorso che preveda, dal punto di vista immaginativo, la presenza nel qui e ora della “decisione” giuridico-politica non solo degli interessi delle future generazioni ma anche di quelli di entità naturali altre. La facoltà immaginativa nel nostro tempo sembra essere particolarmente in crisi, eppure è soltanto mediante l’immaginazione che è possibile fuoriuscire dai limiti cognitivi della nostra psicologia morale[40], ed è soltanto mediante l’immaginazione che è possibile costruire nel pensiero la rappresentazione di un mondo completamente altro[41].
La ragione fondamentale per cui riteniamo che l’etica delle piante sia davvero necessaria è proprio perché potrebbe permettere un esercizio di immaginazione particolarmente articolato e complesso. Proprio trattandosi di un’alterità per certi versi non afferrabile del tutto, già sempre sfuggente, ma che può essere comunque colta nella sua straordinaria (proprio nel senso di: fuori dall’ordinario della nostra classica lettura del mondo e delle cose) unicità sia dal punto di vista estetico che metafisico-ontologico, la funzione di una centralità della vita vegetale all’interno del discorso dell’etica ambientale potrebbe essere quella di attivare uno sforzo immaginativo che, a partire dalla lenta temporalità delle piante, possa condurre a una rappresentazione “anticipata” del “futuro” del sistema Terra. Se è vero quanto afferma Coccia, che le piante sono potenze cosmogoniche ed esiodee, porsi al livello della vita delle piante dovrebbe permettere di cogliere la fondamentale potenza creatrice della vita vegetale e della vita tout court: questa forma specifica di creatività – di cui noi letteralmente ci nutriamo – potrebbe essere a fondamento di un percorso immaginativo della creatività umana, un’utopia trasformatrice della relazionalità complessiva, a partire dal presupposto oramai ineludibile che il benessere umano non può che essere inserito all’interno del complesso del benessere del “tutto”. Il ben-essere, lo stare-bene, diviene una dinamica che ha a che vedere con il mondo della creazione (e della creatività: le piante non creano e basta, creano bellezza) e con la realtà di un possibile vivere-insieme che sviluppi ed estenda costantemente i confini di questo “insieme”.
Si tratta di antropocentrismo o non-antropocentrismo? La domanda è d’obbligo. La risposta è sempre la stessa. Si tratta di antropocentrismo, nel momento in cui sembra che la finalità riguardi l’attivazione della facoltà immaginativa umana in vista della trasformazione dell’esistente, trasformazione a guida umana; si tratta di non-antropocentrismo, nella misura in cui si ragiona a partire da un’alterità assoluta, non afferrabile del tutto, e dall’idea di un ben-essere di tutta la comunità vivente e non vivente, indistintamente, senza alcuna centralità per l’umano. La nostra posizione dovrebbe essere chiara, è impossibile fuoriuscire completamente dall’antropocentrismo, è impossibile fuoriuscire dal punto di vista umano (o dal “punto di vita”, come lo chiama il filosofo Coccia). È possibile, invece, limitarne gli effetti deteriori, per coltivarne soltanto quelli che possano essere propositivi. Non sappiamo se l’immaginazione appartiene anche ai viventi nonumani, ed è forse inutile (e antropocentrico!) chiederselo. L’immaginazione, per quanto ne sappiamo, è una facoltà umana, e in questo momento è la facoltà che va coltivata e lasciata “fiorire”: la traduzione di una specifica sensibilità in discorso razionale e intellettuale necessita, mai come in questo momento, del filtro dell’immaginazione. L’immaginazione deve essere la facoltà da “coltivare” e la creatività della vita vegetale – esiodea e metamorfica – può fungere da modello per questa ri-attivazione.
Ritornando e chiudendo sull’assunto iniziale – riconoscere dignità a un determinato ente non ha condotto necessariamente a un rispetto di quel determinato ente (neanche quando quell’ente è l’umano stesso) – significa che la facoltà dell’immaginazione nell’umano è ancora troppo debole: se è vero che le piante immaginando forme sempre nuove creano forme sempre nuove, vuol dire che dalla vita vegetale abbiamo soltanto da imparare. Ricordando, forse, che all’interno della “spirale” che connette rappresentazioni culturali e simboliche e determinazioni materiali, il ruolo della dimensione “estetica” è da rilanciare. Siamo convinti che un discorso di questo tipo sarà indubbiamente tacciabile di “antropocentrismo”, ma per noi risulta decisivo, strategicamente, ridiscutere il punto di vista umano, che, pur muovendosi finalmente per vie sempre meno antropocentriche, resta e resterà il punto di vista di un vivente specifico. Ed è esattamente su quello che occorre lavorare.
[1] Per un inquadramento generale cfr. R. Attfield (a cura di), The Ethics of the Environment, Routledge, London and New York 2016; in lingua italiana, cfr. P. Donatelli (a cura di), Manuale di etica ambientale, Le Lettere, Firenze 2012; M. Andreozzi (a cura di), Etiche dell'ambiente. Voci e prospettive, LED, Milano 2012.
[2] Impossibile restituire la ricchezza della letteratura in merito, ma, per un’interpretazione complessiva della questione, in lingua italiana e in chiave darwiniana, cfr. S. Pollo, Umani e animali: questioni di etica, Carocci, Roma 2016.
[3] Per un’analisi ragionata del dibattito internazionale, cfr. A. Kallhoff, M. Di Paola, M. Schörgenhumer (a cura di), Plant Ethics. Concept and Applications, Routledge, London and New York 2018; in lingua italiana, cfr. G. Pellegrino, M. Di Paola, Etica e politica delle piante, DeriveApprodi, Roma 2019.
[4] Cfr. P. Hadot, Il velo di Iside. Storia dell’idea di natura (2004), tr. it. Einaudi, Torino 2006.
[5] Il dibattito più “accorto” sulle questioni ambientali sottolinea come la costruzione occidentale di una “identità”, allo stesso tempo come “immagine culturale e simbolica” e come motivazione per interventi colonialisti e neocolonialisti, sia lo strumento fondamentale di ogni riduzionismo dell’alterità.
[6] Su queste questioni è stato particolarmente puntuale il filosofo francese Georges Bataille che vede in questa dialettica immanenza/trascendenza l’origine non solo dell’attitudine tipicamente umana di trasformazione del mondo mediante il lavoro, ma anche della religione, dell’arte e dell’erotismo (cfr. G. Bataille, Teoria della religione (1973), tr. it. SE, Milano 2002; Id., Lascaux. La nascita dell’arte (1955), tr. it. Mimesis, Milano 2007; Id., L’erotismo (1957), tr. it. Mondadori, Milano 1972). Ci permettiamo di rinviare a D. Salottolo, La vita e l’utile: la parabola della scrofa, in «S&F_scienzaefilosofia.it», 17, 2017, pp. 177-194.
[7] Siamo debitori, come stimolo per la riflessione sull’antropocentrismo nelle etiche ambientali, di G. Pellegrino, M. Di Paola, Nell’Antropocene. Etica e politica alla fine di un mondo, DeriveApprodi, Roma 2018.
[8] Questa scansione temporale non tiene conto di personalità come Henry David Thoreau nel XIX secolo o di Aldo Leopold nella prima metà del XX secolo soltanto perché, nella brevità di questa esposizione, si predilige discutere dal punto di vista speculativo alcune categorie dell’etica ambientale così come è andata costituendosi in sapere codificato all’interno del vasto ambito delle cosiddette etiche applicate.
[9] Cfr. P. Singer, Liberazione animale. Il manifesto di un movimento diffuso in tutto il mondo (2009), tr. it. Il Saggiatore, Milano 2015, e T. Regan, I diritti animali (1983), tr. it. Garzanti, Milano 1990.
[10] Cfr. M. Hall, Plants as Persons. Philosophical Botany, Suny Press, New York 2011.
[11] Cfr. M. Marder, Plant-Thinking. A Philosophy of Vegetal Life, Comubia University Press, New York 2013.
[12] Cfr. J. Bennett, Vibrant Matter. A politcal ecology of things, Duke University Press, Durham 2010.
[13] Cfr. B. Latour, Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford University Press, Oxford 2005.
[14] Il riferimento è ovviamente a A. Leopold, Pensare come una montagna. A Sandy Count Almanac (1949), tr. it. Piano B, Prato 2019.
[15] Cfr. A. Kallhoff, M. Di Paola, M. Schörgenhumer (a cura di), op. cit. (La traduzione di questa e di tutte le citazioni di opere di cui non esiste o non viene citata l’edizione in italiano è da considerarsi nostra).
[16] Ibid., p. 2.
[17] Ibid.
[18] Ibid., p. 3.
[19] Cfr. T. Višak, Utilitarian plant ethics, in A. Kallhoff, M. Di Paola, M. Schörgenhumer (a cura di), op. cit., pp. 30-39.
[20] Cfr. R. Sandler, Is considering the interests of plants absurd?, in A. Kallhoff, M. Di Paola, M. Schörgenhumer (a cura di), op. cit., pp. 40-50.
[21] Cfr. A. Kallhoff, The flourishing of plants: A neo-Aristotelian approach to plant ethics, in A. Kallhoff, M. Di Paola, M. Schörgenhumer (a cura di), op. cit., pp. 51-58.
[22] Cfr. S. Odparlik, The dignity of plants. An overview of the discussion in German-speaking countries, in A. Kallhoff, M. Di Paola, M. Schörgenhumer (a cura di), op. cit., pp. 59-69.
[23] Cfr. M. Coeckelbergh, What do we mean by a relational ethics? Growing a relational approach to the moral standing of plants, robots and other non-humans, in A. Kallhoff, M. Di Paola, M. Schörgenhumer (a cura di), op. cit., pp. 98-109.
[24] Cfr. M. Schörgenhumer, Caring for plants: Cultivating realtional virtues, in A. Kallhoff, M. Di Paola, M. Schörgenhumer (a cura di), op. cit., pp. 110-118.
[25] Con questa espressione, dovrebbe essere chiaro, non intendiamo «il modello della conservazione delle risorse cui corrisponde una cultura della gestione», come sottolinea Luisella Battaglia, sulla scorta di un’etica dei limiti «in cui si assegnano vincoli normativi al comportamento umano in relazione all’ambiente e si prescrive un’amministrazione oculata delle risorse naturali, sempre in funzione della prosperità e del benessere umani» (L. Battaglia, Un’etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica medica, ambientale, animale, Carocci, Roma 2011, pp. 160, 161-162).
[26] Cfr. C. Darwin, The power of movement in plants (1880), Cambridge University Press, Cambridge 2009.
[27] Cfr. F. Baluska, S. Mancuso, D. Volkmann, P.W. Barlow, Root apex transition zone: a signalling-response nexus in the root, in «Trends in Plant Science», 15, 2010, pp. 402-408, e F. Baluska, S. Mancuso, Plants, climate and humans. Plant intelligence changes everything, in «EMBO Reports», 21, 2020 (liberamente consultabile al seguente link: https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/embr.202050109); per una lettura divulgativa, cfr. S. Mancuso, A. Viola, Verde brillante: Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale, Giunti, Firenze 2015.
[28] Cfr. W. van Hoven, Mortalities in kudu (Tragelaphus strepsiceros) populations related to chemical defence in trees, in «Journal of African Zoology», 105, 1991, pp. 141-145.
[29] Cfr. E. Coccia, La vita delle piante. Metafisica della mescolanza (2016), il Mulino, Bologna 2018.
[30] Cfr. ibid., p. 19.
[31] Ibid., p. 24.
[32] Ibid., p. 29.
[33] Ibid., p. 31.
[34] Ibid.
[35] Cfr. M. Marder, op. cit.
[36] Cfr. K. Houle, Facing only outwords? Plant bodily morphogenesis and ethical conceptual genesis, in A. Kallhoff, M. Di Paola, M. Schörgenhumer (ed.), op. cit., pp. 70-81.
[37] Cfr. S. Pouteau, Plants as open beings: From aesthetics to plant-human ethics, in A. Kallhoff, M. Di Paola, M. Schörgenhumer (ed.), op. cit., pp. 82-97.
[38] Cfr. E. Kohn, Come pensano le foreste (2013), tr. it. nottetempo, Milano 2021.
[39] Ci riferiamo alle posizioni ultra-prometeiche e ultra-eccezionaliste dell’umano proprie del cosiddetto “ecomodernismo” (cfr. http://www.ecomodernism.org/italiano – link consultato il 21 marzo 2022).
[40] Cfr. S. Pollo, op. cit.
[41] Ci permettiamo di rinviare, sulla connessione tra Antropocene e l’idea che sia sempre più difficile immaginare il radicalmente nuovo, e su come provare a riattivarlo, D. Salottolo, Senza il nuovo, quanto può durare una cultura? Tina e la ricerca di una “cosmologia” all’altezza dell’Antropocene, in «S&F_scienzaefilosofia.it», 23, 2020, pp. 350-385.