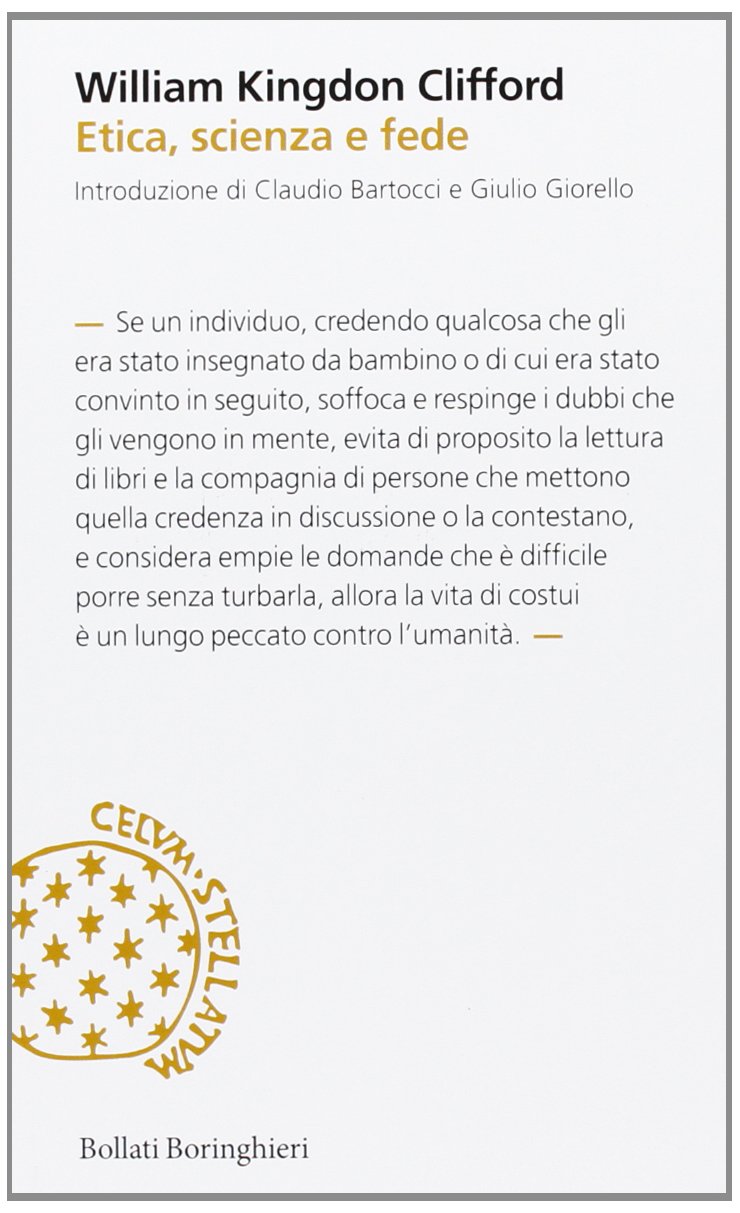Pensatore poco conosciuto in Italia, William Kingdon Clifford è uno di quei filosofi il cui contributo alla disciplina è, spesso, ignorato, forse perché egli, matematico di professione, fece nella filosofia delle brevi “incursioni”, dando vita più a felici suggestioni che a un pensiero sistematico. Tuttavia, la sua opera ebbe una notevole risonanza all’epoca e alcuni elementi del suo pensiero sono tuttora d’interesse: lo testimonia il fatto che un’intera branca della filosofia contemporanea, detta “etica della credenza” (ethics of belief) si è sviluppata soprattutto a partire dalle sue riflessioni.
Oltre alla trattazione del rapporto tra credenza e evidenza, le sue osservazioni sul funzionamento della scienza appaiono, per certi aspetti, illuminanti.
Non è affatto un caso, dunque, che a introdurre l’opera qui recensita siano un filosofo con formazione matematica e interessi epistemologici, Giulio Giorello, e un fisico matematico, Claudio Bartocci.
Fin dall’accuratissima Introduzione (pp. 7-47) è evidente la vicinanza ideologica tra questi autori e Clifford: l’apologia del pensiero scientifico e della libertà individuale sono, infatti, elementi centrali sia nel pensatore britannico che in Giorello e Bartocci.
Nelle prime pagine dell’Introduzione, i due curatori ricostruiscono con dovizia di particolari l’itinerario biografico e intellettuale del giovane studioso, inserendolo efficacemente nella cornice storica in cui visse, quella dei burrascosi scontri frontali tra positivismo e teologia conservatrice.
Tra questi due blocchi ideali ci sono in realtà molte posizioni intermedie: teologi darwinisti, scienziati spiritualisti, moderati da ambo le parti, sintesi più o meno coerenti di teorie scientifiche e dottrine religiose.
Difficilmente potremmo, tuttavia, porre Clifford tra i moderati: il suo umorismo pungente, il suo stile tranchant, il suo procedere critico, sottile e corrosivo lo rendono senz’altro uno dei più formidabili apologeti della causa della scienza positivista, senza alcuna concessione al pensiero religioso.
Nonostante qualche eccesso “ottocentesco”, il positivismo di Clifford è, però, tutt’altro che dogmatico, essendo il frutto sincero di una ricerca assidua della verità, senza preconcetti, con l’evidenza come unica guida.
L’opera qui recensita è una raccolta di tre contributi dell’autore: il primo è una lecture pubblica trascritta, gli altri due, invece, sono articoli scritti per riviste dell’epoca.
Composti tra il 1872 e il 1877 essi trattano tematiche diverse pur risultando fortemente interconnessi e si propongono quale sintesi del pensiero di Clifford su alcuni temi caldi dell’epoca, cioè il rapporto tra scienza e fede e tra etica e religione.
Pensatore fortemente schierato dalla parte della scienza, mai però prono allo scientismo, il nostro autore mostra di prendere nettamente posizione contro ogni dogmatismo, religioso e non, in un apologetico elogio del pensiero critico.
Qui si cercherà di mostrare l’importanza di alcuni suoi contributi, senza però lesinare critiche a quei contenuti che al lettore di oggi potrebbero apparire datati o troppo compromessi con lo “spirito del tempo” dell’Ottocento positivista.
Il primo dei contributi qui raccolti è intitolato Sugli scopi e gli strumenti del pensiero scientifico.
Il breve saggio è la trascrizione di una lecture davanti alla British Association for the Advancement of the Sciences, a cui Clifford partecipò nel 1872.
Argomento principale è la peculiarità della ricerca scientifica, i suoi meccanismi fondamentali e il suo scopo. A tal proposito, colpisce il fatto che Clifford esordisca tracciando una distinzione tra tecnica e scienza: molti altri autori rifletteranno sul tema nel secolo successivo, ma la distinzione qui delineata rimane del tutto originale.
Per Clifford la tecnica consiste nell’attingere a un patrimonio di conoscenze note per applicarle a un problema che si sa come risolvere. Questo è ciò che fa, ad esempio, un ingegnere o un architetto. Ma anche un ingegnere o un architetto possono essere scienziati anziché tecnici. Lo sono quando escogitano nuove applicazioni del sapere di cui sono portatori, dando nuove conoscenze all’umanità.
Essi, di fatto, avanzano quelle che molti anni dopo Popper chiamerà “previsioni rischiose” e ottengono successo perché vedono validata la loro previsione nonostante l’esito non fosse scontato.
Un architetto che costruisce case secondo canoni noti è un tecnico, uno che combina elementi noti in forme innovative e originali, non sulla base di semplice fantasia creativa ma grazie a fondati ragionamenti, è tanto scienziato quanto chi pratica ricerca pura.
Ne risulta il paradossale risultato (almeno per un filosofo della scienza ortodosso) che non solo chi pratica le scienze naturali è scienziato, ma possono esserlo anche politici, giuristi e poeti.
Il problema della demarcazione sembra, dunque, del tutto estraneo alla riflessione di Clifford e questo aspetto sarà sia la punta di diamante che il tallone d’Achille della sua teoria.
Intanto, l’autore prosegue con la sua estesa trattazione (pp. 53-64) della natura delle leggi scientifiche: esse sono talmente accurate da essere confermate da ogni esperimento, così che se l’esperimento non si accordasse con la legge quest’ultima sarebbe salva comunque, perché la colpa andrebbe ricercata in errori di misurazione, in fattori che ostacolano la misurazione e nella scarsa precisione degli strumenti.
Bisogna, però, distinguere tra esattezza pratica, ovvero la migliore precisione permessa dai nostri strumenti di misurazione, ed esattezza teorica, cioè la precisione formale delle grandezze matematiche calcolate in astratto.
I nostri calcoli hanno esattezza pratica, mai esattezza teorica, sono sempre approssimati, mai del tutto adeguati ma abbastanza corretti perché possiamo accontentarci di essi ai nostri scopi.
Qui è utile osservare come l’autore anticipi delle riflessioni di grande centralità nel dibattito epistemologico contemporaneo, come quelle tra realismo scientifico e anti-realismo.
Per il realista scientifico, le nostre teorie descrivono il mondo come esso è.
Per l’anti-realista, la scienza rileva fatti empirici e ne ricava teorie che, però, sono solo strumenti esplicativi dei fatti: più teorie, anche contraddittorie sotto alcuni aspetti, possono convivere se spiegano efficacemente i fatti. La luce a volte si comporta come una particella (teoria corpuscolare), a volte si comporta come un’onda (teoria ondulatoria). Per il realista, una sola delle due teorie sarà vera, e dovremo scoprire quale. Per l’anti-realista, finché i fenomeni empirici sono spiegati da ambo le teorie, esse possono convivere.
Clifford è un realista scientifico convinto: le teorie descrivono il mondo, esse sono vere e reali, ogni inesattezza nella loro rilevazione è dovuta alla nostra limitata capacità di misurazione che non ci permette di essere del tutto precisi. Avessimo strumenti così sensibili da misurare con esattezza i fenomeni, le leggi naturali apparirebbero del tutto uniformi. Possiamo dunque ritenere, a pieno titolo, Clifford un realista scientifico.
Una prospettiva anti-realista, invece, sembrerebbe più adatta ad alcuni esempi riportati dal nostro autore in seguito: egli, ad esempio, è consapevole del fatto che alterando la scala del contesto di osservazione (verso il microscopico o su distanze astronomiche) alcune misurazioni non possono essere effettuate con strumenti tipicamente utilizzati per quei contesti. Una legge che vale per oggetti di medie dimensioni non spiega fenomeni subatomici (e la fisica quantistica era di là da venire) così come le nostre misurazioni su larga scala non possono essere svolte come lo sarebbero su scale ridotte.
Con ciò egli mostra una presa di coscienza dell’inadeguatezza di una concezione troppo univoca delle teorie che hanno portata limitata rispetto alla molteplicità dei contesti di applicazione.
Ciò non fa però vacillare la convinzione di Clifford nell’esistenza di leggi reali, espresse dalle teorie scientifiche. Egli rimane, quindi, un realista scientifico, nonostante le sue osservazioni ben si prestino a fornire argomenti a chi considera solo strumentali le teorie scientifiche.
Tuttavia, queste questioni non occupano particolarmente Clifford, che prosegue (pp. 65-66) comparando diverse tipologie di esattezza, in particolare quelle raggiunte dalla fisica, dalla fisiologia e dalla psicologia.
Mentre le prime due, a diverso livello, hanno una loro esattezza pratica, la psicologia non l’ha ancora raggiunta.
E qui si mostra appieno lo Zeitgeist positivista: l’autore dichiara esplicitamente che tale scienza dovrà presto raggiungere lo stesso livello di esattezza delle sue colleghe per essere davvero scientifica.
La stessa idea di esattezza lascia, infatti, fuori dal novero delle scienze le discipline che non hanno ancora raggiunto il livello di predittività e precisione delle scienze naturali.
Qui Clifford è ben lontano dalle riflessioni di Dilthey e Weber che proprio contro questa pretesa vorranno difendere l’esistenza delle scienze sociali come saperi interpretativi.
Psicologia, economia e sociologia non possono produrre leggi, né avrebbe senso cercare di farlo. Esse sviluppano categorie interpretative e le applicano ai contesti per darne spiegazione. Il loro oggetto, multiforme e sfaccettato, pur essendo comprensibile e classificabile, non è traducibile in leggi. Questo per un positivista come Clifford non è concepibile, ma la storia delle scienze sociali ha provato come questo loro statuto sia il più adatto allo studio dei fenomeni sociali. Ma il nostro autore può fare riferimento alle concezioni di Comte e a Spencer come unici modelli di scienza sociale. Quindi, da questo punto di vista la sua analisi è piuttosto datata.
Dopo questa breve trattazione, il discorso va avanti e verte su un altro punto di grande importanza, cioè la natura della spiegazione scientifica.
Qui il filosofo inglese mostra di saper anche precorrere i tempi: quasi quarant’anni dopo il filosofo tedesco Otto Neurath spiegherà con il famoso aneddoto della barca come la scienza non sia mai priva di presupposti pre-teorici.
Clifford, indagando il tema della spiegazione scientifica, arriva a conclusioni quasi simili: spiegare vuol dire fare appello a fatti noti per giustificare fenomeni ignoti. Ma andando a ben vedere, alla fine ci troveremo di fronte a fatti semplici che non sappiamo spiegare, passeremmo da “è così per questo e quest’altro motivo” al “è così perché è così”, cioè a fatti semplici, irriducibili a ulteriori spiegazioni.
Ammettere che non tutto è spiegabile è una necessità logica della ricerca scientifica, e Clifford ne coglie in pieno la portata: ciò comporta un limite alla nostra capacità esplicativa, ma non inibisce affatto la nostra capacità di fare scienza: la pone solo in una prospettiva anti-fondazionalista.
Mentre questa osservazione anticipa i futuri sviluppi della filosofia della scienza novecentesca, il passo seguente (pp. 76-81) è un altro inno al positivismo. Qui l’autore riflette su alcune antinomie, che pongono il pensiero di fronte a soluzioni (in apparenza) mutualmente esclusive ma ugualmente inconoscibili. Lo spazio è infinito o ha un confine? La materia è divisibile all’infinito o è fatta di particelle ultime indivisibili? Entrambi i casi sembrano proporre antinomie ugualmente inconcepibili per la mente umana.
Clifford mostra come esse siano contraddizioni soltanto apparenti: ridefinendo il linguaggio esse possono essere operativizzate e, se sono sensate, dare risposta, altrimenti possono essere abbandonate.
Tali antinomie nascono da inadeguate formulazioni. Un confine è ciò che separa due oggetti nello spazio, quindi chiedersi se lo spazio abbia un confine è puramente non-sense. Allo stesso modo, ridefinendo i nostri termini teorici, anche la questione della natura delle particelle potrebbe essere spiegata.
Il paragone con il Peirce di How to make our ideas clear è qui calzante, poiché anche il pensatore americano arriva a simili conclusioni: non ci sono problemi difficili per chi davvero vuole risolverli, basta ridurre la questione in termini a cui si possa dare risposta e molte controversie metafisiche mostreranno di essere più ostacolate dal linguaggio impreciso che da una intrinseca complessità della questione.
Come Pierce, che ritiene impossibile prevedere ciò che potrà essere conosciuto e cosa no, anche Clifford guarda fiducioso al futuro: invece di porre limiti conoscitivi assoluti, che storicamente si sono rivelati provvisori e sono stati superati da nuove scoperte, chiariamo i concetti e aspettiamo di osservare che frutti porterà la ricerca.
Chi poteva prevedere il progresso della nostra epoca mille anni fa? Perché dovremmo farlo noi?
Su questo punto le discussioni dei due autori combaciano perfettamente.
La conclusione della conferenza si rifà alla distinzione (p. 81) introdotta all’inizio: il pensiero scientifico non è una tecnica, né una procedura, né una metodologia: esso è un ethos, un atteggiamento.
Scientifico è il ragionamento che permette di applicare cose note a scenari mai visti prima: solo chi sfrutta la conoscenza per avanzare nuove teorie inedite è scienziato, sia esso fisico, biologo, giurista o poeta.
La trattazione dell’articolo intitolato L’etica della religione apparso su “Fortnightly Rewiew” nel luglio 1877, verte sul rapporto tra coscienza morale e credenze religiose.
L’autore esordisce con un preambolo terminologico (pp. 83-87), notando l’impossibilità di ridurre a un unico significato il termine religione: il teismo, la presenza di cerimoniali e sacerdoti, fattori emotivi o morali sono tutte componenti presenti nelle varie religioni, ma nessuna di esse è definitoria.
Mentre Mircea Eliade e Rudolf Otto concorderanno sulla presenza del “sacro” come elemento unificatore di ogni esperienza religiosa, Clifford rifugge ogni tentativo di definizione univoca.
Tuttavia, il suo bersaglio polemico è chiaro: sono le chiese e le sette dogmatiche a rappresentare l’obiettivo delle sue argomentazioni critiche.
Di queste viene valutata la dottrina secondo due criteri, uno morale e l’altro epistemologico.
Poiché il ruolo dell’evidenza, cioè l’aspetto epistemologico sarà argomento del prossimo saggio, ci soffermeremo qui sull’aspetto etico.
Dal punto di vista dell’analisi morale, forse il punto più interessante di tutta l’opera di Clifford, assistiamo a un capovolgimento del dilemma di Eutifrone: giusto è ciò che risponde alla coscienza dell’uomo, e persino la religione viene posta dinnanzi al tribunale di quest’ultima.
E pare che sia trovata colpevole di ogni nefandezza: dalle condotte immorali degli dei olimpici, già esposte da Platone e Seneca, fino alle abominevoli storielle educative dei catechismi cattolici, le divinità più che essere mirabili esempi di virtù etica risultano essere peggiori degli uomini.
Perché venerare chi è peggiore degli uomini? Perché dare a criminali e malfattori la possibilità di giustificarsi additando gli dei come modello, se essi sono deprecabili nella loro condotta?
Non stiamo ancora prendendo in considerazione la verità delle credenze: ben istruito alla scuola di Hume, Clifford sa che essere e dover-essere sono indipendenti. Anche esistessero dei siffatti, nulla avrebbero di lodevole e non dovremmo venerarli.
La fede “colta” può anche mitigare alcuni elementi immorali nella religione, ma a livello di divulgazione popolare prevale la brutale logica dell’intimidazione, volta a soffocare ogni possibile critica alla dottrina. Emblematico è il catechismo cattolico dell’epoca, a dir poco traumatizzante.
Già Platone voleva bandire le narrazioni religiose inquietanti e diseducative nel timore che turbassero i bambini, censurando tutto ciò che non fosse edificante.
Qui l’apologia della censura e del controllo statale sulla produzione artistica potrebbero sembrare dittatoriali rispetto alle nostre democrazie liberali (Popper a tal proposito riteneva lo stato immaginato da Platone totalitario), ma ciò nulla toglie all’importanza dell’osservazione del filosofo ateniese: tali racconti sono distruttivi per la fragile personalità dei più giovani, e la religione ha contribuito non poco a tale violenza.
Va inoltre distinto il contenuto morale positivo dall’intera dottrina religiosa: senz’altro ci saranno nel Vangelo e in altri insegnamenti religiosi elementi di grande moralità, ma essi sono frammisti a stratificazioni teologiche derivate dalle antiche caste sacerdotali.
In una ricostruzione storica che adesso parrebbe poco accurata (ma che si inserisce abbastanza bene nel dibattito sul Gesù storico e sul Gesù del Vangelo che animò la teologia storico-critica dell’epoca), Clifford riabilita il Gesù ebreo, profeta e moralista, ma scredita la Chiesa, come istituzione sacerdotale di ascendenza egiziana, gerarchica e oppressiva.
Insomma, Cristo sì, Chiesa no, quasi un proclama da ‘68 ante litteram.
Non ci soffermeremo qui sulle problematiche legate a queste interpretazioni, ma è interessante notare come in tutte le pagine successive di questo excursus storico l’autore tenti di negare in toto l’apporto positivo del cristianesimo alla società occidentale: che abbia fatto del male è palese, che abbia fatto del bene è discutibile perché tale operato era sempre rivolto ai propri interessi. Il male è dunque intrinseco nella religione, il bene ne è un effetto secondario.
Non si può non notare quanto qui sia parziale il giudizio del filosofo inglese, che addossa alla Chiesa ogni male, senza alcuna concessione. Di enorme interesse è invece la riflessione sul ruolo della coscienza, da cui consegue una forte critica alla confessione rituale.
Mescolando sapientemente darwinismo, intuizionismo etico e formalismo kantiano, Clifford sostiene che nell’animo di ogni uomo alberghi l’Uomo: esso è la totalità dell’umanità, della razionalità e dei sentimenti morali, sviluppatisi nei millenni.
Il richiamo alla riduzione feuerbachiana della teologia all’antropologia non è esplicito, e non sappiamo se a esso facesse riferimento l’autore, ma ci sono senz’altro fortissime somiglianze.
L’Uomo è ciò che indirizza le nostre azioni verso un Noi (Ourself) ancor prima che verso di noi (ourselves), cioè verso il bene dell’umanità tutta.
Esso è “la voce dell’Uomo dentro di noi, che ci ordina di lavorare per l’uomo”. La voce dell’uomo non può essere emendata da alcun comando contraddittorio se essa giudica negativa un’azione verso il prossimo, né preti, né zar, né sacerdoti potranno rimuoverne il giudizio.
A volte gli uomini hanno avvertito questo Uomo in foro conscentiae e lo hanno identificato con un qualche Dio trascendente.
Non è Dio a creare l’Uomo, ma è l’uomo a creare Dio: quando l’uomo sente qualcosa dirgli “io sono con te e sono più grande di te”, egli pensa al Grande Compagno, come scherzosamente lo chiama Clifford, ma invece sta ascoltando l’uomo.
Per quanto originale, l’osservazione di Clifford si inserisce in un quadro più ampio e condiviso all’epoca: Auguste Comte parlava già da tempo di “religione dell’umanità”, culto laico dell’Uomo e del Progresso, mentre Emile Durkheim notava come le cerimonie religiose usassero Dio per parlare della società stessa, e come essa fosse anteriore temporalmente all’individuo, un Tutto olistico che plasma e dirige l’azione del singolo.
La Società di Durkheim e l’Uomo di Clifford vengono così ad avere molti punti in comune, figlie del medesimo contesto positivista nutrito di umanesimo e progressismo.
L’articolo intitolato L’etica della credenza (Ethics of belief, pp. 117-153), pubblicato su “Contemporary Review” nel gennaio 1877 e di gran lunga il più famoso dell’autore, inizia con un breve apologo: un armatore deve far salire un gran numero di emigranti su una delle sue navi.
Egli sa che la sua nave ha numerosi problemi tecnici, è vecchia, malandata. Ciò è evidente, ma il nostro armatore non lo accetta, e fa finta di niente. Nel caso in cui la nave affondasse, torme di persone additerebbero il disonesto armatore come responsabile.
Ma poniamo che la nave arrivi sana e salva in porto, con tutti i suoi emigranti a bordo: l’armatore sarebbe meno colpevole?
Per Clifford, qui e in altri punti molto vicino a morali deontologiche, no. Non sono le conseguenze a rendere buona l’azione, ma il modo in cui la si intraprende.
Ognuno di noi, quando accetta una credenza, compie un atto etico.
E non importa quale sia la credenza: nessuna credenza è insignificante, perché esse sono tutte interconnesse e accettare una minuzia falsa può portare ad azioni clamorose e immorali, in quanto altre credenze poggeranno su quella falsità.
Quando solo pochi cercano la verità, essa perde di rilevanza, diventa triviale. Ognuno è tenuto a vigilare sul suo stock di credenze e a mantenerlo puro tramite l’esercizio dello spirito critico.
Chi si rende credulone non danneggia sé stesso, ma l’Uomo tutto.
Già Epitteto si lamentava della stoltezza di chi si preoccupa di perdere fama e beni ma non si cura di non avere false opinioni. Clifford prosegue su una linea simile. Ogni credenza infondata è infatti un ostacolo al progresso, ogni credulone è un nemico dell’avanzamento dell’umanità.
Per quanto i toni quasi da predicatore ne rivelino l’impostazione positivista (la religione dell’umanità di Comte non è citata ma si respira una simile atmosfera ogniqualvolta si senta parlare di Uomo e progresso) Clifford coglie pienamente un nesso fondamentale tra credenza e morale: ognuno di noi deve cercare la verità e dirla agli altri, discutere le proprie posizioni per debellare il falso e affermare il vero.
Solo così si avrà una società migliore e una condotta etica condivisa.
Il dubbio non è distruttivo, ma costruttivo, esso mira a comparare le credenze proposte con l’ammontare di evidenze portate a sostegno dell’affermazione.
Esso porta a distinguere il vero presente in un corpo di dottrine dall’accettazione acritica della dottrina intera.
In accordo con le posizioni anti-religiose dell’autore, il primo caso di credenza dubbia affrontato (pp. 131-138) è quello della testimonianza dei leader religiosi.
Possiamo apprezzare il carattere morale di Maometto e Buddha, ma non per questo siamo tenuti a ritenerli necessariamente dei profeti o delle guide religiose.
Assistiamo qui a un radicale ribaltamento del principio alla base della fede: “Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto” è per Clifford la summa di ogni immoralità.
Tommaso d’Aquino diceva che rifiutare un articolo di fede equivaleva a rinunciare a tutta la dottrina, perché essa era da ritenersi tutta materia di fede. Clifford invece procede diversamente: non si crede per fede o per simpatia dottrinale, ma vagliando ciò che di buono e umano si può trovare frammisto a incoerenze e pretese dubbie.
Ma al di fuori dell’ambito religioso, che cosa potrebbe essere assunto come criterio di valutazione della bontà dell’evidenza?
Sicuramente lo è la scienza, dove non vale l’opinione personale del singolo scienziato, ma teorie corroborate e validate da intere comunità di ricerca. La dimensione comunitaria della ricerca scientifica, già notata da Peirce, è qui elevata a criterio di credibilità delle teorie scientifiche. Ciò tuttavia vale non solo per le teorie scientifiche ma anche per la tradizione e la morale (pp. 141-145).
Anch’esse vanno validate alla luce dell’esperienza e quando inadeguate vanno rifiutate e sostituite con valori e norme migliori.
La morale stessa si sedimenta nella tradizione e si cristallizza in diverse forme a seconda dei tempi e, pertanto, va sottoposta al vaglio critico dell’indagine razionale.
Se Clifford avesse conosciuto la sociologia della conoscenza, avrebbe saputo meglio spiegare ciò che qui accenna: ci sono in ogni epoca sistemi culturali declinati in diverse forme per incanalare e disciplinare i bisogni spontanei degli uomini.
Simmel chiama “contenuti” questi bisogni e “forme” le strutture che li disciplinano: tuttavia l’inerente inadeguatezza di ogni sistema culturale a esaurire la complessità della vita umana (la cosiddetta “tragedia della cultura”) fa sì che nessuna tradizione sia immune da critiche e aggiornamenti.
Quindi, l’osservazione del pensatore britannico, pur da punti di partenza ben diversi, coglie in pieno la provvisorietà dei sistemi normativi umani, pur temperando la sua concezione con la consueta dose di progressismo positivista.
Continuando lo svolgimento della sua trattazione, l’autore enuncia i principi che regolano l’accettazione di una credenza.
Possiamo accettare credenze che vanno oltre la nostra esperienza (alcuni esempi alle pp. 148-153) quando esse sono conformi a quanto sappiamo sul mondo: una rilevazione della composizione della materia solare è affidabile perché assumiamo che lo strumento che usiamo possa funzionare con il Sole così come sappiamo funzioni bene con altre sostanze.
Avendo garanzie di validità da esperienze passate, possiamo ragionevolmente estendere la credenza a situazioni a esse conformi.
Ovviamente, ci sono dei limiti: nessuna persona potrà convincerci di qualcosa che sappiamo essere al di fuori delle nostre attuali possibilità conoscitive.
Altro criterio è dunque la plausibilità, per cui riteniamo effettivamente credibile qualcosa che sappiamo potrebbe essere verificato.
Accettiamo la testimonianza di un esploratore artico quando essa è plausibile: sappiamo che potrebbe essere confermata da ulteriori spedizioni. Ma non accetteremmo mai dichiarazioni fondate su cose che l’interlocutore non può sapere, né potremmo controllare.
In ogni caso, plausibilità ed evidenza sono i principi fondamentali di accettazione della credenza.
L’autore, in conclusione d’opera si sofferma ulteriormente su questo punto. Richiamando un detto di Jacobi, secondo cui una domanda ben formulata è già una mezza risposta, Clifford sostiene che la metà complementare della risposta a ogni domanda sensata stia nell’applicare il giusto procedimento. Esso è il metodo scientifico, aperto a ogni intelletto. Chiunque, ponendo buone domande e applicando correttamente i principi di inferenza sulla base delle evidenze, può rispondere a qualsiasi questione.
L’autore fa l’esempio della legge di Ohm: qualsiasi studente avesse una domanda di ricerca ben formulata e una conoscenza dei procedimenti scientifici, potrebbe in poco tempo riscoprire ciò che decenni di ricerca fisica, culminati nel lavoro di Ohm, hanno portato all’umanità.
La critica di Kuhn alla predominanza del contesto della giustificazione rispetto a quello della scoperta fa sembrare oggi un po’ ingenua la pretesa di poter porre fuori da ogni contesto storico-sociale le scoperte scientifiche, ma l’osservazione è comunque indicativa dell’intera prospettiva epistemologica cliffordiana.
Tale concezione è lapidariamente riassunta nel motto divenuto celebre: “è sempre sbagliato, dovunque e per chiunque, credere a qualcosa in base a evidenze insufficienti”.
In conclusione, il libro si presenta al lettore come una serie di contributi slegati tra loro ma tematicamente interconnessi.
In essi, l’autore mostra di essere un fine filosofo della scienza ma di affiancare alla ricerca epistemologica un profondo senso morale, che traspare da alcune pagine vibranti.
Inoltre, lo stile quasi umoristico, scorrevole e mordace, unito al suo ateismo senza compromessi, lo avvicina per alcuni aspetti a Nietzsche, di cui sembra prefigurare taluni temi.
Egli si fa propugnatore di quello che adesso chiameremmo scetticismo scientifico, che fa del pensiero critico e del metodo scientifico i cardini di ogni indagine conoscitiva umana.
Difficile pensare a un autore di grande successo come Carl Sagan senza riconoscere che il seme del suo pensiero, e di quello di molti altri, fu lanciato da questo poco noto pensatore inglese.
Pur essendo inserito pienamente in un orizzonte positivista, evidente in ognuno dei contributi qui raccolti, egli spicca immediatamente come pensatore originale e critico, capace di incarnare lo spirito del tempo, ma anche di porre le fondamenta per un suo superamento.
Il lettore rimarrà in ogni caso sorpreso dall’acutezza del pensiero di Clifford, fine e sottile, e dalla sua eloquenza critica, caparbia e mordace ma mai feroce.
L’opera di questo autore può a buon titolo essere ritenuta punto di partenza imprescindibile per ogni trattazione del delicato e complesso rapporto tra scienza, etica e fede.
Riccardo Cravero
S&F_n. 22_2019