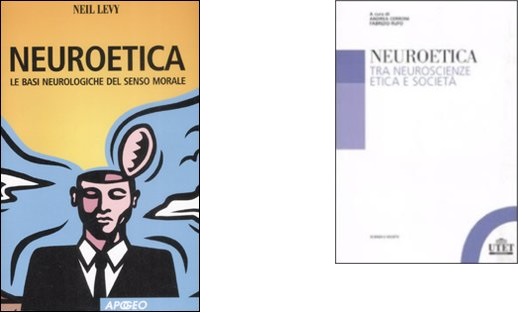Gli impetuosi sviluppi delle scienze neurologiche e l’avanzare degli studi nell’ambito delle scienze cognitive hanno prodotto negli ultimi vent’anni sommovimenti prima impensabili nel tessuto articolato della scienza e della società e hanno inciso profondamente sulla stessa possibilità di avere una coerente e strutturata immagine dell’uomo. Similmente alla nascita della bioetica negli anni Settanta, a cavallo della rivoluzione della biologia molecolare e della bio-medicina nel suo complesso, nei primi anni di questo nuovo millennio si è avvertita l’esigenza di raccogliere sotto un unico cappello disciplinare, quello della neuroetica, la variegata serie di riflessioni intorno alle conseguenze teoriche, etico/sociali e giuridiche delle neuroscienze. A partire dalla conferenza di Safire del 2004, anno nel quale il termine neuroetica (e, possiamo dire, la disciplina neuroetica), ha assunto veste pubblica, una quantità straordinaria di articoli, saggi e conferenze dedicate all’argomento hanno visto la luce senza soluzione di continuità. In questo contesto, fatto certamente di interscambi continui tra discipline anche strutturalmente molto differenti, si inseriscono i contributi di Neil Levy, filosofo australiano, e il testo curato da Andrea Cerroni e Fabrizio Rufo che costituisce uno dei volumi, ancora pochi in Italia, di carattere sistematico sull’argomento. Neil Levy non ha dubbi sull’importanza che la neuroetica verrà ad assumere nel dibattito pubblico intorno allo statuto delle neuroscienze e alle problematiche da esse sollevate e sostiene che «si possa predire senza timore che il campo relativamente nuovo chiamato neuroetica attraverserà una crescita esplosiva» (p. 1). I motivi rintracciati dal filosofo australiano sono tre: il primo è legato al fatto che «le scienze della mente stanno sperimentando una crescita rapida che è ancora più spettacolare della crescita osservata in medicina nei decenni precedenti alla nascita della bioetica» (pp. 2-3); il secondo è, invece, punto certamente nodale, che «le nostre menti sono, in un senso relativamente diretto, noi»; infine perché i neuroscienziati promettono di riuscire a legare in maniera biunivoca e intrascendibile la mente al cervello. Tali ragioni, e altre che emergeranno nel corso dell’esposizione, bastano a giustificare l’esigenza di un intervento disciplinare ad hoc, che si faccia carico del corpus di problemi accennati. La neuroetica, quindi, secondo Levy, dovrà articolarsi in due filoni, o se vogliamo esprimerci più precisamente, due direttrici d’indagine parallele. La prima è quella dell’etica delle neuroscienze (p. 7), nella quale si cercherà di capire se e dove devono frapporsi dei limiti all’indagine neuroscientifica, soprattutto nei casi in cui questa comporta un intervento diretto sul cervello. La seconda è rappresentata, invece, dalle neuroscienze dell’etica, nella quale si tenterà di comprendere in maniera sistematica quali sono i cambiamenti paradigmatici che le neuroscienze possono determinare rispetto all’etica e all’immagine stessa dell’uomo. Ma il testo di Levy presenta, oltre a una sorta di introduzione alle tematiche di diretta pertinenza della neuroetica, anche spunti teorici di grande interesse. In particolare un’interessante proposta legata all’idea che la mente fuoriesca dai confini del cranio (ipotesi della mente estesa), e una coerente delineazione di quello che l’autore chiama la tesi della parità (p. 45). Secondo quest’ultima prospettiva non dobbiamo approcciare le neurotecnologie con uno sguardo di aprioristica condanna perché, in buona sostanza, a ben vedere, esse non si muovono all’interno di una prospettiva così distante da quella tracciata dalla psicologia sociale, piuttosto che dalle varie tecniche psicoterapeutiche, il cui fine precipuo è proprio quello di produrre delle modificazioni più o meno permanenti in seno al soggetto. I capitoli successivi (il plot teorico del testo di Levy è contenuto con dovizia di particolari fin dall’introduzione) sono volti a illustrare analiticamente l’applicabilità e la spendibilità dell’ipotesi della mente estesa e della tesi di parità. In primo luogo Levy cerca di smentire l’idea, piuttosto diffusa, per cui un intervento di natura farmacologica sarebbe giocoforza toto coelo distinto da un intervento di carattere logoterapeutico o psicoterapeutico lato sensu. In prima istanza ciò non sarebbe vero per il carattere comunque fisico del processo di modifica della mente in atto nelle sedute psicoterapeutiche (rinforzi sinaptici, liberazione di certi neurotrasmettitori, etc.), in secondo luogo perché l’intervento psicofarmacologico è spesso la soluzione migliore per il trattamento di specifici casi clinici. Levy procede quindi a destrutturare dall’interno una serie di concetti positivi legati all’idea che le psicoterapie vanno sempre e comunque, o in buona sostanza, preferite all’intervento diretto. In primis l’idea che con la psicoterapia e solo con essa si può mantenere l’autenticità della persona (che si perderebbe invece con il farmaco, attraverso cui io posso rendere una persona depressa meno depressa, ma a quel punto a essere meno depressa non sarà autenticamente quella persona, ma quella persona nella misura in cui è sotto trattamento farmacologico). In seconda battuta che attraverso un intervento di tipo diretto non si metterebbe in moto un processo di autentica crescita personale e si perderebbe la possibilità di conoscere coerentemente il proprio sé (p. 82); infine la convinzione che il farmaco genererebbe un processo di meccanicizzazione del sé e andrebbe, per lo più ad intervenire sui sintomi piuttosto che sulle cause reali della patologia (p. 83 sgg.). Gli stessi argomenti impiegati per rigettare l’idea che gli interventi indiretti siano sempre da preferirsi rispetto a quelli diretti (e da essi completamente distinti) la ritroviamo nel successivo capitolo, con il tentativo di ridimensionare la portata della distinzione tra miglioramento e potenziamento. L’attenzione di Levy si indirizza poi alla questione della lettura della mente (p. 137 sgg.). Anche qui l’approccio dell’autore è assai critico verso tutti quei proclami tecnofili per i quali attraverso l’impiego delle nuove tecniche di scansione cerebrale si arriverà a riscrivere totalmente lo statuto del diritto ed il ruolo delle prove in ambito processuale (ad esempio attraverso l’uso di nuove tecniche di lie detection). Certamente con la presa in carico dei dati forniti dalle neuroscienze e attraverso i numerosi suggerimenti che ci vengono dalla psicologia sociale, possiamo approcciare con maggiore rigore tutta una serie di questioni legate alla memoria, allo statuto della personalità, alla reale, effettiva capacità del soggetto di disporre rispetto a se stesso di un sufficiente autocontrollo o, infine, possiamo gettare nuova luce sul problema dei processi decisionali, sulla concreta impronta che il libero arbitrio ha rispetto alle nostre scelte e ai nostri processi volitivi. Il testo di Levy, e questo è importante mettere adeguatamente in luce, cerca, la qual cosa è del tutto esplicitata nelle battute finali del lavoro, di costruire un’impalcatura concettuale sufficientemente articolata entro la quale leggere le questioni aperte dall’indagine empirica sul cervello, e lo fa offrendo due importanti e ben argomentati strumenti concettuali, ossia, come già detto: la mente estesa e la tesi di parità. Non possiamo racchiudere nel nostro cranio i processi che concernono la nostra individualità poiché nella intima caratterizzazione dell’uomo (non uso volutamente il termine essenza) c’è un’apertura strutturale all’alterità, apertura che si realizza innanzitutto attraverso l’oggettivazione primaria dei processi eidetici con il linguaggio, poi attraverso la creazione di mezzi e strumenti via via più complessi che in un meccanismo di loop retroagiscono sull’uomo stesso, diventando, anzi una sorta di co-estensione della soggettività. Questo significa che la tesi per cui la manipolazione diretta è un male in sé non può tenere nella misura in cui l’esterno ha lo stesso peso e la stessa importanza dell’interno per la determinazione dei processi personali. Su un registro per alcuni aspetti più disparato (i saggi spaziano da questioni di neuro-estetica a questioni legate alla comunicazione nella scienza e nella neuroetica), ma con intenti simili si muovono gli autori del secondo volume che qui si intende prendere in esame. Neuroetica, tra neuroscienze, etica e società intende gettare un ponte teorico sostenibile che colleghi campi disciplinari spesso semplicemente giustapposti e lo fa attraverso un contributo a più voci, nel rispetto, certamente dialogante, delle peculiari competenze e specificità. Il testo si apre con un contributo dello psicobiologo Alberto Oliverio nel quale si mostra come le ricerche intorno alla struttura del cervello hanno avuto delle notevoli ricadute nella determinazione dello statuto stesso dell’etica. Si fa riferimento, pertanto, al celebre caso di Phineas Gage, il quale in seguito ad un incidente di lavoro e ad alcune lesioni subite al livello della corteccia prefrontale avrebbe iniziato a manifestare comportamenti antisociali, irascibilità e incapacità di mantenere relazioni interpersonali stabili (A. Oliverio, p. 6). Le sindromi di pazienti con lesione alla corteccia frontale ventromediale sono poi state oggetto dello studio particolareggiato di Antonio Damasio, il quale viene giustamente richiamato da Oliverio quale testimone di una svolta negli studi neurologici, entro la quale il ruolo delle emozioni e della corporeità nell’ambito dei processi decisionali è stato profondamente rivisto e rivalutato. Il punto che Oliverio tende a sottolineare è come l’importanza delle scoperte neuroscientifiche non debba farci indulgere a troppo facili e semplicistiche tesi di carattere riduzionistico, ma, nello stesso tempo, debba farci riflettere sul ruolo ineliminabile della ricerca empirica per la determinazione dello statuto della soggettività normale e patologica. Nel secondo saggio di Silvano Tagliagambe si mette in stretta relazione la possibilità di richiamare il valore dell’aisthesis, della sensazione, e quindi dell’estetica rispetto alle ultime indagini neurobiologiche, che, per certi versi confermerebbero alcune intuizioni che la filosofia occidentale ha avuto sull’argomento. Il piacere infatti «oltre ad essere un aspetto fondamentale del comportamento motivato di organismi altamente evoluti come i mammiferi, dal punto di vista naturalistico appare come un dispositivo biologico frutto della selezione naturale e come tale volto a favorire la sopravvivenza e l’adattamento all’ambiente» (S. Tagliagambe, p. 27). È interessante, però, soffermarsi in particolare sul terzo e quarto contributo al volume. Nel saggio Neuroscienze e categorie giuridiche: quale impatto? si propone al lettore la questione dell’incidenza che le nuove scoperte neuroscientifiche possono avere, o stanno già avendo sulle tradizionali categorie del diritto. Di fatto le nuove tecniche di scansione cerebrale consentirebbero di impiegare, in un’ottica quantomeno plausibile, un numero considerevole di prove supplementari in fase di dibattimento processuale (A. Santosuosso, B. Bottalico, p. 48 sgg.). Negli Stati Uniti tali prove sono state discusse in diversi processi e la letteratura in materia inizia a diventare copiosa (p. 54 sgg.). L’idea dei due autori del contributo è a ogni modo quantomeno scettica, o parzialmente scettica, poiché essi ritengono il contributo delle neuroscienze al diritto un territorio ancora eccessivamente incerto e pieno di ostacoli teorici e tecnici al tempo stesso (p. 64). Nel saggio sull’Homo economicus si insiste invece sull’importanza che le ricerche in ambito neurologico possono avere nel chiarire la natura dei processi decisionali e nel fornire prove a sostegno di un’ipotesi di approccio all’economia lontana dai dettami della teoria classica. L’economia, secondo i due autori dell’articolo, può sperare di riconquistare una capacità di lettura efficace della realtà solo se abbandona l’idea dell’uomo quale agente puramente razionale (F. Rossi, M. Motterlini, p. 85). Nel saggio di Andrea Cerroni si avalla, con una posizione molto sensibilmente vicina a quella di Neil Levy, la necessità di allargare la mente al fine di includere nell’idea di cognizione un di più, un qualcosa che valichi i meri processi intracranici (A. Cerroni, pp. 118-120). Il volume si chiude con due interventi sull’importanza degli sviluppi di un dibattito articolato nell’ambito della neuroetica (F. Rufi, M. Borri) e con alcune riflessioni sul ruolo della comunicazione per il progresso e la strutturazione di questa disciplina (P. Greco). Si può concludere pertanto sottolineando, ancora, il notevole rilievo che la neuroetica ha assunto nei dibattiti contemporanei intono alle questioni sollevate dalle neuroscienze, facendo di questa nuova disciplina un ramo nello stesso tempo autonomo e dipendente della più larga e variegata riflessione sui temi della biomedicina indagati dalla bioetica e dall’etica applicata nelle sue varie forme e dimensionallargare la mente al fine di includere nell’idea di cognizione un di più, un qualcosa che valichi i meri processi intracranici (A. Cerroni, pp. 118-120). Il volume si chiude con due interventi sull’importanza degli sviluppi di un dibattito articolato nell’ambito della neuroetica (F. Rufi, M. Borri) e con alcune riflessioni sul ruolo della comunicazione per il progresso e la strutturazione di questa disciplina (P. Greco). Si può concludere pertanto sottolineando, ancora, il notevole rilievo che la neuroetica ha assunto nei dibattiti contemporanei intono alle questioni sollevate dalle neuroscienze, facendo di questa nuova disciplina un ramo nello stesso tempo autonomo e dipendente della più larga e variegata riflessione sui temi della biomedicina indagati dalla bioetica e dall’etica applicata nelle sue varie forme e dimensioni.
Luca Lo Sapio
S&F_n. 5_2011