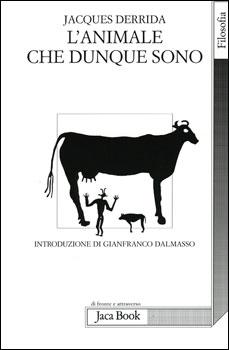«L’animale autobiografico» è il titolo (suggerito proprio da Jacques Derrida) per una decade di conferenze organizzata a Cerisy-la-Salle nel 1997. L’animal que donc je suis, comparso nel 2006, è la raccolta degli interventi che il filosofo francese aveva preparato per l’occasione. Si tratta di un testo postumo, che riunisce tre interventi composti per una lettura di fronte a un uditorio, una lettura che, comprese le discussioni, coprì una durata quasi dieci ore. La quarta e ultima parte del testo è la trascrizione di una registrazione cui non corrisponde – unica eccezione – alcun testo scritto. Si legge, nelle pagine conclusive del libro, una parola quasi improvvisata, di cui si riconoscono il carattere orale e il tono familiare. «Se è relativamente facile trascrivere esattamente tutte le parole pronunciate (basta solo fare molta attenzione), una certa interpretazione comincia quando si tratta di tradurre in ritmo i silenzi, gli accenti dell’intonazione in segni d’interpunzione e si sa quale attenzione aveva Jacques Derrida per tali segni» (dalla Prefazione di Marie-Louise Mallet, p. 32). Un testo postumo, dunque, che raccoglie una parte del materiale su cui Derrida ha lavorato per comporre – se ne avesse avuto il tempo – una grande opera su «l’animale».
L’animal que donc je suis: nel titolo si fa sentire una coincidenza grafemica – quella del suis francese – in cui possiamo trovare tanto il verbo essere quanto seguire. Tale ambiguità nel titolo (l’animale che dunque sono/seguo) non è affatto risolta dal testo che, anzi, ne fa il tratto indecidibile che sostiene l’economia dell’intero discorso sull’animale e sull’uomo. In riferimento ai racconti della Genesi sulla grande scena della nominazione, Derrida scrive che: «L’uomo è dopo l’animale. Lo segue. Questo “dopo” della sequenza, della conseguenza, o della persecuzione, non è nel tempo, non è temporale: è la genesi stessa del tempo» (pp. 54-55). Cosa significa, in rapporto all’animale, «io sono»? A tale domanda non si può dare una risposta univoca, «dal momento che tale affermazione sembra implicare un “sono nel senso di sono appresso all’animale” oppure “sono in quanto sono presso l’animale”» (p. 47).
Si può considerare il tema della differenza tra umano e non umano come l’orizzonte più vasto in cui si colloca il testo di Jacques Derrida. Tale macro-questione si articola attraverso una serie di domande che riguardano “l’esperienza dell’animale”, in entrambi i sensi possibili per questo genitivo: l’esperienza del «tutt’altro che chiamano animale» (p. 50), dove già il chiamare, che segna uno spazio umano circoscritto in rapporto a un resto, non è neutro poiché allude alla questione della chiamata e della risposta. Una delle domande ricorrenti in questo testo, infatti, suona così: l’animale risponde o reagisce? La reazione, infatti, s’inscrive nell’ordine del previsto e dell’automatico (animale), a differenza della risposta che apre all’ordine del possibile e dell’imprevedibile (umano). La posta in gioco di tale questione è talmente radicale che ne va dell’intera differenza ontologica, della logica stessa del vivente umano, dell’assunto metafisico concernente l’animale razionale (zoon logon echon).
La prima questione posta da Derrida è quella nella nudità e, conseguentemente, del pudore. Non si tratta tanto della nudità dell’animale, quanto del posto della nudità nella scena uomo-animale (nello specifico, il vedersi visti nudi dallo sguardo di un gatto). «È come se, nudo di fronte al gatto, ne provassi vergogna». L’esperienza della nudità è qui intesa come una soglia dell’umano, unico animale che prova imbarazzo in situazione di nudità. La nudità dell’uomo, vista dall’animale, è una scena che investe la differenza intorno a cui si struttura il testo derridiano. Se occorre interrogare la differenza uomo-animale – questa una delle ipotesi del testo – non si può prescindere dallo sguardo animale.
Nella storia di questa differenza, da una parte troviamo il discorso metafisico sul proprio come proprietà dell’uomo, che fa dell’animale un essere mancante: «un teorema, una cosa vista e non vedente» (p. 51). Dall’altra parte, una parola che, segnata dalla sua stessa mancanza – senza rappresentanti istituzionali, una parola «i cui interpreti sembrano essere piuttosto poeti o profeti» (p. 52) – tenta di percorrere la via di un essere-con l’animale. La via percorsa da Derrida coincide invece con un tentativo di dire, attraverso la scrittura, il segno della mancanza come tratto costitutivo del rapporto uomo-animale («bisogna operare un rovesciamento»): la mancanza, la privazione, il negativo dalla parte dell’uomo. Il proprio dell’uomo consiste nel non avere un proprio (paradigma antropologico della mancanza originaria, della proprietà umana che coincide paradossalmente con una mancanza di proprietà).
Un’altra questione decisiva, quella della violenza dell’uomo sulla vita animale – «l’immensa questione del pathos e del patologico, (…) della sofferenza, della pietà e della compassione» – è introdotta a partire da una domanda di Bentham: «Can they suffer?». Da questa prospettiva, il problema non è di sapere se l’animale può parlare o pensare, se sia o meno “logon echon”, ma piuttosto di interrogare la sofferenza animale, il suo pathein. Chiedersi se gli animali possono soffrire equivale, per Derrida, a porsi la domanda: «possono non potere?». La domanda formulata dall’autore del Panopticon rovescia la premessa metafisica del logos come facoltà/capacità, del «poter-avere logos» come segno positivo della differenza, «tesi questa, posizione o presupposto che resta costante da Aristotele a Heidegger, da Descartes a Kant, Lévinas e Lacan» (p. 66).
L’animale che dunque sono diventa, dunque, un testo sulla frattura che investe la questione del limite tra «l’Uomo con la U maiuscola e l’Animale con la A maiuscola». Non si tratta, tuttavia, di negare la tesi della discontinuità tra l’umano e l’animale. Il continuismo biologico («di cui sono note le sinistre connotazioni») è visto con sospetto da Derrida, che in esso scorge una direzione impercorribile. La via percorsa non è, infatti, quella di un attacco frontale alla frontiera: si tratta piuttosto di percorrere lo spessore del limite abissale che dà forma a questa frattura, a questa frontiera plurale.
Il discorso paradigmatico, dominante e normativo sulla posizione dell’uomo di fronte all’animale e al mondo, si articola in forme diverse e con differenti firmatari nella tradizione metafisica occidentale. Esso emerge come un punto di riferimento costante per la lettura derridaiana. «Al centro di queste difficoltà – scrive il filosofo di El Biar – c’è sempre l’impensato di un pensiero della vita». La sospensione di ogni riferimento alla vita, alla vita del corpo e alla vita animale, segna, in questa tradizione, la storia autobiografica dell’«io sono». La sequenza di autori con cui Derrida si confronta (Cartesio, Kant, Heidegger, Lévinas, Lacan) è tenuta insieme dalla persistenza di alcune premesse: l’animale non parla né risponde, l’animale è fissato/ancorato a un programma. A parte pochi casi, il discorso metafisico mette da parte le differenze strutturali tra le specie animali, la sessualità animale, i rapporti di dominazione, il progresso del sapere etologico. Agisce da sempre una tendenza a «confondere tutte le specie animali nella grande categoria dell’“animale” versus l’uomo» (p. 100). La non-risposta (premessa della non-libertà di un animale che «non parla né risponde», la cui «capacità di produrre segni è estranea al linguaggio e si trova limitata, fissata in un programma», p. 137) e la mancanza (nella forma di un difetto, di un deficit generale: animale presentato essenzialmente come povero di mondo) sono i presupposti che Derrida individua nella tradizione metafisica come costanti dell’animale teoretico.
Una scena sacrificale fonda, dunque, lo spazio dell’uomo. Derrida cita Kant, che nell’Antropologia dal punto di vista pragmatico scrive: «la guerra interna o esterna, per quanto sia un gran male, è nella nostra specie anche il movente [Triebfeder: l’eccitante della pulsione] che ci fa passare dallo stato rozzo di natura allo stato civile» (pp. 146-147). Derrida legge questo passo nel senso dell’addomesticazione, della bestia domata, di una guerra interna che l’uomo combatte contro l’animale, di un sacrificio della sensibilità alla ragione morale. Ridotto/ricondotto al ruolo di sparring-partner dell’Uomo, l’Animale resta prigioniero degli assunti antropomorfici: «spettacolo teorico» sospeso tra gli estremi assoluti della bontà/innocenza e del male/crudeltà.
Il terzo capitolo, “E se l’animale rispondesse?”, inizia con una dedica a Jacques Lacan, autore in cui Derrida segue le tracce di una mutazione teorica, e, contemporaneamente, di una «conferma stagnante dell’eredità, dei suoi presupposti, dei suoi dogmi». Nella configurazione lacaniana, l’animale sorge nella differenza tra finta e inganno:«l’animale non sa mentire in senso proprio, secondo il senso comune, secondo Lacan e tanti altri, anche se, come si sa, sa fingere» (p. 185). L’animale, in altre parole, non accede all’ordine simbolico (ordine del significante che rimane una prerogativa strettamente umana). L’animale lacaniano resta catturato nell’immaginario, perché non sa fingere di fingere: «non lascia tracce in cui l’inganno consisterebbe nel farsi prendere per false mentre sono quelle vere, cioè quelle che indicherebbero la pista buona. E nemmeno cancella le proprie tracce il che per lui sarebbe già farsi soggetto del significante» (J. Lacan, Sovversione del soggetto e dialettica del desiderio nell’inconscio freudiano, 1974) (p. 186).
Il quarto e ultimo capitolo è, come si accennava, la trascrizione di una comunicazione improvvisata da Jacques Derrida in chiusura del colloquio. Si tratta di un accenno di confronto con Heidegger e, più precisamente, con i suoi Concetti fondamentali della metafisica. In questo testo Derrida legge una riconferma trionfale del paradigma metafisico sulla mancanza dalla parte dell’animale. In riferimento alla vita animale, «weltarm» significa “povero di mondo” (a differenza dell’uomo, “formatore di mondo” o «weltbindend»; e della pietra, che è semplicemente “senza mondo” o «weltlos»). Solo l’uomo è finito,nel senso della finitezza, del suo rapporto con il tempo. «L’animale non è finito in questo senso (…). Non ha finitezza come non ha la parola, come non muore “propriamente”, parlando in senso proprio, ecc.» (p. 210). Se l’animale è vivente laddove l’uomo è esistente, allora la morte (legata alla finitezza) resta una prerogativa umana. L’animale heideggeriano, «parlando in senso proprio», non ha il Dasein, quindi si limita semplicemente a crepare. «Il suo modo d’essere, che noi chiamiamo “vita”, non è senza accesso a ciò che è accanto a esso e in mezzo al quale si trova come vivente. In virtù di questa connessione si dice dunque che l’animale ha il suo mondo-ambiente, e si muove in esso. L’animale è, per la durata della sua vita, imprigionato in un mondo-ambiente come in un tubo che non si allarga, né si restringe» (M. Heidegger, Concetti fondamentali della metafisica – Mondo – finitezza – solitudine, 1999) (p. 221, nota). La suite teoretica, che si conclude per mancanza di tempo con questi cenni su Heidegger, mostra che la marginalizzazione della questione dell’animale è al cuore della metafisica occidentale. Il tono del discorso sull’Animale, sempre al singolare generale, si fa sentire come un contrappunto al di là della distanza e delle differenze tra i singoli autori.
Daniele Garritano
S&F_n. 7_2012