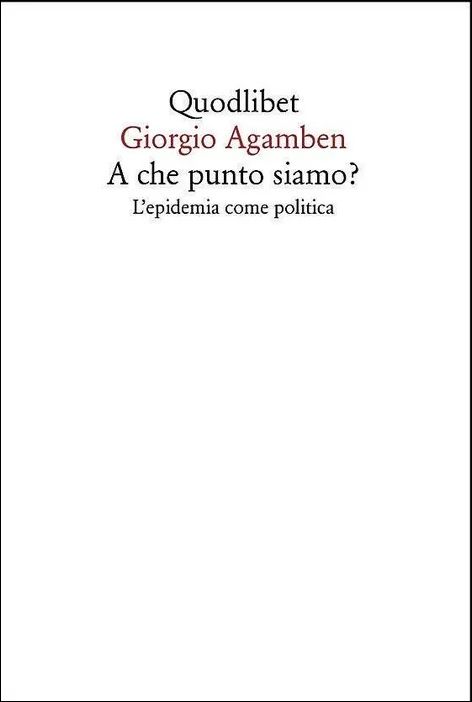Nell’ambito dell’apprensivo e troppo spesso monotono dibattito sull’epidemia che recentemente ha colpito buona parte della popolazione mondiale, un discorso a sé va fatto per il testo di Giorgio Agamben, composto da una serie di brevi articoli e interviste dedicati ai primi mesi dell’attuale situazione epidemica e, più precisamente, alla questione delle possibili ricadute della sua gestione per mezzo di uno specifico “paradigma di governo” messo in atto in Occidente.
Le considerazioni svolte nel testo, che, quando non semplicemente ignorate (cfr. p. 57), sono state accolte per lo più poco favorevolmente, «non riguardano l’epidemia, ma ciò che possiamo capire dalle reazioni degli uomini ad essa» (p. 27) e, pertanto, ciò che sembrerebbe aver disvelato. Inoltre, nel sottolineare come in questa situazione sia in questione più di quanto possa apparire legato a un problema meramente sanitario, ne viene rilevato al tempo stesso il “carattere epocale”, nella misura in cui costituirebbe l’occasione per un profondo cambiamento delle condizioni di vita della civiltà occidentale (cfr. p. 14).
Nel testo, che, pur arrestandosi a un punto di vista per lo più politico, ha quantomeno il merito di risvegliare l’attenzione su alcuni aspetti dell’epidemia quasi del tutto ignorati e su cui sembrerebbe regnare una generale inconsapevolezza, viene preso in considerazione il modo in cui in Occidente e, più in particolare, in Italia è stata generalmente affrontata l’epidemia, tentando di portare all’attenzione alcune questioni connesse alle strategie di contrasto alla diffusione del contagio; nella misura in cui queste sarebbero rivelatrici di alcuni caratteri e dello stato della civiltà occidentale, sviluppando contestualmente una densa analisi critica di quello che si potrebbe chiamare il suo attuale (e secondo l’autore probabilmente anche futuro) sistema giuridico-politico e, se è lecito esprimersi così, della mentalità di cui un tale sistema sembra essere espressione e che siffatte strategie, tutt’altro che neutre, sottendono.
In primo luogo, viene segnalata la presenza nella civiltà occidentale di un certo rapporto caratteristico tra la scienza e la religione. Tuttavia, nel testo, a eccezione di qualche accenno, per “religione” si intende non tanto o primariamente una religione particolare, ma, più in generale, ciò che si può chiamare l’atteggiamento religioso, usando quindi questo termine come sinonimo di «sistema di credenze» (p. 69). Per quanto riguarda invece ciò che si può intendere per “scienza”, che viene chiamata, per sottolineare il ruolo predominante che ha assunto nell’Occidente moderno, per l’appunto, «la religione del nostro tempo» (p. 34) e che, pertanto, «come ogni religione, può produrre superstizione e paura o, comunque, essere usata per diffonderle» (ibid.), il suo significato, seppur non esplicitato direttamente nel testo, va verosimilmente messo in relazione con quell’ideale conoscitivo che, soprattutto a partire dalla modernità, è divenuto il metro di misura di ogni forma di sapere, imponendo progressivamente la razionalità scientifico-matematica come unico modello conoscitivo valido. Sebbene, tra le altre cose, spesso questa “fede nella scienza” non faccia altro che coincidere con la sopravvalutazione di una concezione limitata del sapere (in quanto relativa a un ambito ristretto di fenomeni) e con un atteggiamento fideistico nei confronti del calcolo e della statistica.
In questo senso, si trovano nel testo una serie di considerazioni su come la scienza e, per quanto riguarda la situazione in questione, in particolare la medicina (motivo per cui si parla anche di «religione della salute»; p. 13), abbiano preso il posto di ogni altro tipo di fede, elevando, proprio in virtù di quella concezione limitata, a unico oggetto di venerazione la «nuda esistenza biologica che occorre a qualunque costo salvare» (p. 35), finendo però, in maniera non troppo paradossale, per generare condizioni di vita invivibili, in quanto caratterizzate per lo più da un continuo stato di ansia e di agitazione. Pertanto, l’attuale situazione di crisi avrebbe mostrato in maniera sufficientemente chiara in che modo una civiltà (che già qualcuno chiamava “il regno della quantità”), la cui unica fondamentale preoccupazione è costituita dalla preservazione dell’esistenza fisica, possa rinunciare in maniera fin troppo facile alle sue convinzioni politiche (si pensi soprattutto alla considerevole rinuncia alle libertà individuali), ma, soprattutto, possa accettare di vivere in uno stato di perenne paura e angoscia.
Tutto ciò sarebbe possibile a partire dalla scissione dell’«unità della nostra esperienza vitale, che è sempre inseparabilmente corporea e spirituale, in una entità puramente biologica da una parte e in una vita affettiva e culturale dall’altra» (p. 48): scissione definita «la più grande delle astrazioni» (p. 49). Un “sacrificio” che verrebbe perciò compiuto proprio per salvaguardare quella che viene chiamata la fede nella “nuda vita”, la quale, differentemente da quello che dovrebbe caratterizzare l’oggetto di una religione, vale a dire legare gli uomini tra loro (quantomeno coloro che condividono la stessa religione), agisce invece come principio divisivo: «la nuda vita – e la paura di perderla – non è qualcosa che unisce gli uomini, ma piuttosto li acceca e li separa» (p. 26). Così l’autore, mostrando come intrecciati il discorso riguardante la fede nella scienza e quello riguardante la politica, invita a chiedersi cosa sia «una società che crede soltanto nella sopravvivenza» (ibid.).
Altre considerazioni sfiorano invece la questione della tecnologia, in riferimento al suo uso come strumento di governo, e del suo sviluppo ipertrofico, in quanto eccederebbe la semplice e comprensibile conservazione della vita (quasi elevata esponenzialmente e illusoriamente verso una asintotica esclusione della morte), apparendo però, da un altro punto di vista, come controfinalisticamente orientato (cfr. p. 63), nella misura in cui finirebbe, se così si può dire, per “deantropomorfizzare” l’uomo attraverso una desensibilizzazione e una duplicazione del suo rapporto con il mondo e dei rapporti tra gli uomini. Tale questione, che concerne la «cancellazione dalla vita di ogni esperienza dei sensi e la perdita dello sguardo, durevolmente imprigionato in uno schermo spettrale» (p. 100), fa perciò riferimento all’insorgere di quell’incantamento tecnico-digitale (avente il suo lógos proprio) che in particolare negli ultimi tempi ha ricevuto un’ulteriore decisiva accelerazione.
Il carattere più propriamente “politico” del testo si ritrova, come si diceva, in alcune considerazioni circa lo statuto giuridico delle strategie di gestione dell’epidemia messe in atto, in maniera più o meno consapevole, dai “decisori politici” e rivelatrici di quella che l’autore ritiene essere la messa in pratica di un certo “paradigma di governo” fondato sulla permanenza di uno “stato di eccezione” e che si esplicita nella sempre più frequente sostituzione del potere esecutivo al potere legislativo (cfr. p. 59). Tale “paradigma di governo” sancirebbe pertanto la fine delle democrazie così come sono state finora conosciute e la loro sostituzione con un «nuovo principio di organizzazione della società» (p. 49), vale a dire con nuove forme di dispotismo (o, se non altro, con forme di governo più marcatamente autoritarie e reazionarie).
La caratterizzazione di questo paradigma di governo chiama in causa il concetto di “biopolitica”, il quale si riferisce, a grandi linee, a un tipo di esercizio del potere politico che, facendo propria fino in fondo l’analogia stato-organismo (cfr. p. 86), si esercita direttamente sulla vita biologica, in certa misura in maniera inedita, se non altro in quanto il suo esercizio è reso possibile dall’attuale sviluppo tecnologico e biotecnologico (che manifesta inoltre la forte connessione tra potere politico e ricerca scientifica, tradendone così la non-neutralità). Una chiara manifestazione di tale esercizio del potere può essere individuata proprio in quell’«obbligazione giuridico-religiosa» alla salute «che deve essere adempiuta a qualsiasi prezzo» (p. 13) e, conseguentemente, in una forma di organizzazione della società che, nel riconoscere una normalità biologica, conseguentemente esclude ciò che vi si oppone, mostrandosi pertanto, attraverso la negazione di ciò che minaccia questo ideale di salute, come “tanatopolitica”; cosa di cui, tra l’altro, la recente storia europea ha fornito tragici esempi. Questa obbligazione viene di volta in volta giustificata attraverso ragioni di sicurezza a loro volta motivate da una situazione di crisi, i cui termini possono però variare indefinitamente in estensione e intensità. In questo senso, «possiamo chiamare “biosicurezza” il dispositivo di governo che risulta dalla congiunzione fra la nuova religione della salute e il potere statale col suo stato d’eccezione» (ibid.).
Considerazioni di questo genere, che suggeriscono l’inquietante prospettiva di una sorta di disegno politico messo in atto, consapevolmente o, per così dire, spontaneamente, da un non ben precisato “potere” (cfr. p. 11) volto a imporre un controllo sempre più pervasivo (p. 83) sulla popolazione, potrebbero per certi versi apparire più o meno eccessive e in ultima analisi infondate o, comunque, ovvie, in quanto queste forme di esercizio del potere, fondate sull’emergenza e sull’esclusione dalle collettività di ciò che viene di volta in volta ritenuto dannoso per esse, non costituirebbero nessuna significativa novità, ma sarebbero, con forme diverse, tipiche di ogni organizzazione politica, così come le procedure attualmente usate dalle collettività per contrastare l’epidemia sarebbero in fondo analoghe a quelle messe in atto precedentemente. Tuttavia, sebbene la questione richiederebbe di essere trattata più approfonditamente e secondo più prospettive, al di là dei motivi che potrebbero giustificare o meno il carattere inedito della presente situazione (cfr. pp. 103-106) e a prescindere dalla possibile obiezione circa il carattere temporaneo delle limitazioni attuate e, quindi, di una eventuale sopravvalutazione da parte dell’autore dei rischi relativi alla gestione dell’emergenza, è comunque difficile negare che le società umane appaiono generalmente caratterizzate, oltre che da una certa “tirannia della collettività”, da forme di dominio e di conflitto (sebbene si tratti di un dominio relativo), i cui caratteri possono però essere comunque di volta in volta portatori di significative differenze qualitative. Inoltre, anche senza particolari evidenze in questo senso, non è così inverosimile che possa esserci chi, approfittando di una situazione di generale paura, possa avere un interesse di qualunque genere a deprimere ulteriormente, in un modo o in un altro, la forza d’animo dei popoli e a disunirli per imporre su di essi un qualche dominio e, dunque, non è detto che non valga la pena prendere almeno consapevolezza di questa possibilità. Tra l’altro, si potrebbe dire, come recita un detto taoista, che se «il popolo non teme la morte, come intimidirlo con la pena di morte?» [Cfr. Tao-tê-ching, LXXIV, Adelphi, Milano 1994].
In ogni caso, oltre ai molteplici spunti e interrogativi che questo testo, denso di questioni problematiche, può offrire circa gli argomenti a cui qui si è solo sommariamente accennato, ciò che vi si può trovare di peculiare interesse consiste probabilmente già solo nell’affrontare la questione dell’epidemia e della sua gestione in maniera differente e alternativa da come avviene quasi esclusivamente nell’instabile fantasmagoria mediatica e medianica del dibattito pubblico e della dialettica politica. Ad esempio, attraverso quei modi di affrontare la questione marcatamente “sentimentali” e ideologici; sia che si tratti della passiva e fiduciosa (ma tutt’altro che rassicurante, visto il terrore panico che per lo più ne consegue) accettazione acritica dei dati trasmessi e delle misure per contrastare la diffusione della malattia, unitamente ai principi in base a cui queste vengono adottate, sia che si tratti del semplicistico e altrettanto dogmatico rifiuto paranoico e pregiudiziale, tramite pseudoargomentazioni, di qualsiasi narrazione ufficiale; posizione, quest’ultima, a cui tra l’altro si può facilmente associare qualunque pensiero eterodosso o vagamente critico, escludendo così dal dibattito chi, pur «senza voler minimizzare l’importanza dell’epidemia» (p. 61), inviti a interrogarsi sulle implicazioni di certe misure e a chiedersi a che prezzo e costituendo quale precedente queste vengano accettate.
Tuttavia, al di là della plausibilità o meno delle ipotesi sulle conseguenze dell’attuale situazione (cfr. p. 42, p. 85), la cui imprevedibilità e complessità rende difficile esprimersi in maniera univoca, questo testo, seppur forse troppo caratterizzato da un certo pensiero discriminatorio e da un tono eccessivamente assertorio che manifestano un approccio teorico sistematico, nonché da alcuni limiti propri delle concettualità a esso peculiari, può comunque essere un’occasione per considerare lo stato di una civiltà e quelle che sono le sue condizioni di vita, così come le sue superstizioni, considerando il modo in cui essa affronta una situazione caratterizzata, più di quanto avvenga normalmente, da «un perenne stato di paura e di insicurezza» (p. 27). Dunque, una situazione che, da un altro punto di vista, è tutt’altro che eccezionale, e che, così come gli «sconvolgimenti ciclici» attraverso cui l’universo manifestato si mostra nel suo aspetto più terrifico e tremendo, nel far prendere coscienza in maniera ineludibile di quella che appare come l’universale transitorietà tanto del singolo come di intere collettività, proprio per questo può assumere i caratteri di una crisi non solo politica e sanitaria, ma di una crisi più profonda, nei confronti della quale tanto la politica quanto la scienza sembrano per lo più tacere.
Roberto Corso
S&F_n. 25_2021