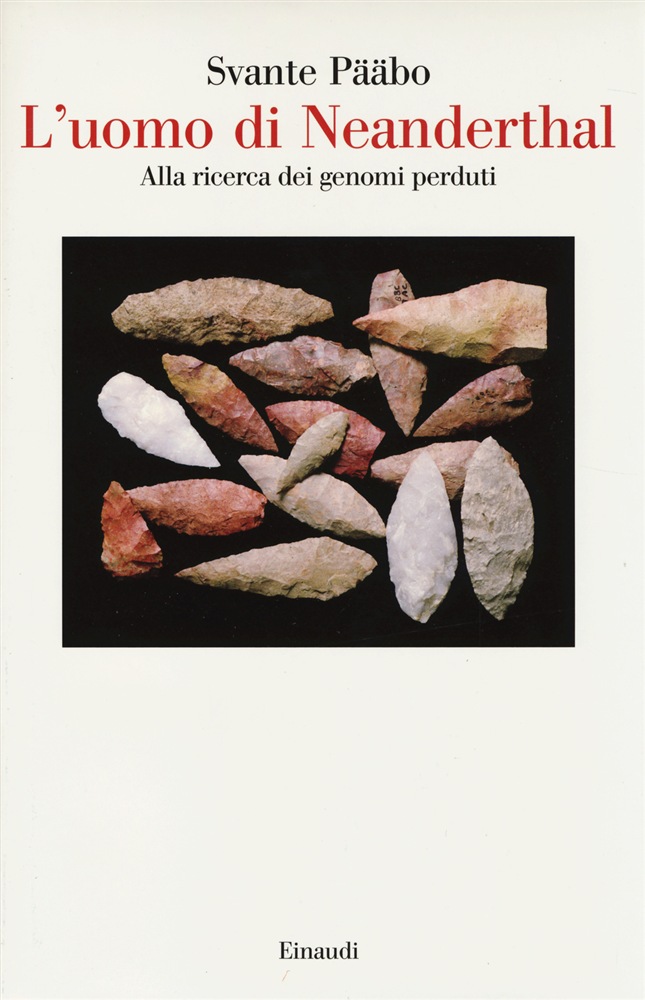I Neanderthal fanno il loro ingresso nella storia umana nel 1856, a seguito del ritrovamento fossile di “strane” ossa (un cranio e qualche altro frammento) in una cava nella valle di Neander in Germania. L’Origine delle Specie di Darwin sarebbe stato pubblicato solo tre anni dopo, e a quelle “strane” ossa – tanto strane da essere inizialmente attribuite a un orso – seguono presto altri ritrovamenti. Chi sono questi strani ominidi dal cranio ovale e dalla pronunciata arcata sopraccigliare, di cui nessuno aveva mai sentito parlare prima, e soprattutto, in che modo sono imparentati con noi umani moderni? Per tentare di rispondere a queste domande con accuratezza scientifica dovranno passare più di centocinquant’anni da quel primo ritrovamento, che inaugura la stagione della paleoantropologia come disciplina autonoma. Oggi i siti di ritrovamenti fossili e archeologici neanderthaliani sono molti, sparsi in tutto il continente eurasiatico, e l’accrescersi della messe di dati ha determinato anche, come spesso accade, un accrescimento dell’interesse pubblico e scientifico nei confronti dei Neanderthal.
Per un lungo periodo, i Neanderthal sono stati descritti come diretti progenitori degli umani moderni, occupanti il gradino precedente sulla scala evolutiva. Meno “evoluti” dunque: scimmieschi, rozzi, ancora allo “stato di natura”. La datazione dei siti che ne ospitano i resti conferma che essi scomparvero tra i 40.000 e i 30.000 anni fa, periodo in cui gli umani moderni cominciano a colonizzare il pianeta. Si pensò quindi che gli umani moderni li avessero in qualche modo soppiantati, magari anche in modo violento, in luogo della loro superiorità, o semplicemente accaparrandosi le risorse. Come spesso accade, i Neanderthal sono diventati una sorta di “doppio” dell’umano moderno, il “negativo”: una quasi-scimmia umanoide, ancora troppo imperfetta, eliminata dalla selezione naturale dalla forma più compiuta di umano: il sapiens. Certo, il rinvenimento di ulteriori reperti fossili e di artefatti complessi neanderthaliani (come punte di freccia in selce o addirittura strumenti musicali) iniziava a mettere in crisi tale visione, ancora maggioritaria nell’ambito della paleoantropologia; ma si trattava comunque di ipotesi, basate peraltro su una quantità di reperti ancora troppo esigua per fare “scienza”.
Svante Pääbo, biologo svedese specializzato in genetica evolutiva, esplora un altro approccio allo studio di quei fossili, gettando nuova luce su chi erano i Neanderthal e riscrivendo completamente alcune sezioni della storia evolutiva umana. Dal 1997, infatti, inizia a lavorare sul DNA antico, estratto proprio dai resti neanderthaliani, insieme a un instancabile team internazionale di ricercatori e dottorandi al Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie di Lipsia, di cui Pääbo dirige il dipartimento di genetica evolutiva. E, dopo quasi vent’anni di sforzi, nel 2010 è riuscito a sequenziare per intero il DNA neanderthaliano, con un livello di accuratezza paragonabile al genoma sequenziato a partire da un campione di un umano vivente. Può sembrare poca cosa, ma se si pensa che il genoma umano sia stato sequenziato interamente solo nel 1999, mentre dal 1997 il biologo svedese già lavorava per sequenziare il DNA mitocondriale neanderthaliano, ci si rende subito conto che Pääbo e i suoi si trovano di fronte a un’impresa a dir poco titanica.
Le difficoltà ad approcciare tale sforzo sono molteplici, come lo stesso Pääbo racconta in queste pagine. Innanzitutto, lavorare con del materiale genetico, seppure ben conservato ma datato decine di migliaia di anni, rappresenta una vera e propria sfida. In effetti, quand’anche lo stato di conservazione dei resti analizzati sia accettabile o addirittura ottimo, in migliaia di anni tali campioni sono stati esposti a batteri, muffe, funghi – con il loro materiale genetico – e persino alla contaminazione umana di chi li ha, più recentemente, maneggiati. Tanto DNA estraneo si mescola così a quello dell’individuo studiato, al punto da vanificare, per la quantità di errori possibili, l’intero sforzo scientifico. Oltretutto, non bisogna dimenticare che la ricerca genetica sul DNA antico non era mai stata implementata. Il lavoro pionieristico di Pääbo è considerato oggi l’atto di fondazione della paleogenetica, disciplina fino a quel momento inesistente. Nella comunità scientifica della fine degli anni ‘90 si considerava addirittura impensabile estrarre anche solo qualche stringa di caratteri da una mummia egizia: la sfida del DNA Neanderthal sembrava assolutamente impossibile.
Pääbo racconta in queste pagine le difficoltà e gli intoppi, le attese lunghissime per i risultati e la loro difficile interpretazione, la preoccupazione per la riproducibilità degli esperimenti, le delusioni e i vicoli ciechi, e anche gli esiti strabilianti e inaspettati delle sue ricerche, con una familiarità dal sapore autobiografico. In un certo senso, il volume possiede in sé una molteplicità di livelli di lettura. Certo, esiste il livello divulgativo, che mostra l’esito delle scoperte e la loro rilevanza nell’ambito della storia evolutiva umana; su un altro piano l’autore svela ai lettori il dietro le quinte, il lento e a volte tediante ritmo del lavoro di laboratorio, con le sue battute d’arresto, le sue frustrazioni e i suoi successi. Si ha cioè l’impressione di essere messi a parte dei meccanismi interni della prassi scientifica dei paleogenetisti, di osservare la scienza nel suo “farsi”, e di leggere il punto di vista, umanissimo, del ricercatore, con le sue aspettative, le sue speranze e le sue paure.
Geniali intuizioni collettive del team di Pääbo, unitamente allo sviluppo, lento e incrementale, delle tecnologie applicate alla genetica (come ad esempio la messa a punto di nuovi reagenti in grado di evidenziare porzioni degradate o illeggibili del genoma, o l’informatizzazione dell’elaborazione dei dati ottenuti dal sequenziamento) hanno permesso, e non senza difficoltà, di far fronte e alla fine superare con successo gli enormi ostacoli di partenza, non solo con risultati inaspettati ma con conseguenze assolutamente rivoluzionarie.
Con Pääbo scopriamo con certezza che i Neanderthal non erano nostri progenitori. Il dato genetico ci informa che la loro linea evolutiva uscì dall’Africa centinaia di migliaia di anni fa (tra i 400.000 e i 300.000 circa), ben prima che gli umani moderni si evolvessero, stanziandosi in buona parte dell’Eurasia. Gli umani moderni si sono evoluti anch’essi in Africa, ma l’hanno lasciata soltanto intorno ai 50.000 anni fa. I Neanderthal sono perciò umani “arcaici”, data l’altezza temporale della loro separazione dall’ultimo antenato comune. Ma non è tutto. Le analisi comparative del DNA antico con quello degli umani moderni hanno rivelato qualcosa che era impossibile inferire dall’analisi “a occhio nudo” dei fossili, qualcosa di impensabile: tutti gli umani viventi oggi – con la sola esclusione di chi abbia ascendenza africana – possiedono nel loro genoma il 2-4% di DNA Neanderthal. Ciò significa necessariamente che gli umani moderni e i Neanderthal hanno avuto unioni che hanno prodotto “ibridi” fertili. Come lo stesso autore ricorda spesso, i Neanderthal non sono dunque del tutto estinti, ma continuano a vivere dentro di noi. Tale risultato ha scosso profondamente la comunità scientifica, generando quelle che Pääbo chiama “le guerre tassonomiche” intorno allo status dei Neanderthal: se erano interfertili con gli umani moderni, si può davvero pensare che apparteniamo a specie diverse?
Il rigore e la meticolosità del lavoro di Pääbo e del suo team non lascia spazio a dubbi: tra Neanderthal e umani moderni c’è stato flusso di geni. Oltretutto, l’archeologia più recente ci svela quanto i Neanderthal non fossero poi così scimmieschi e rozzi come si pensava, suggerendo la presenza di comportamenti che ci sono abbastanza familiari: curavano i feriti, celebravano riti funebri, avevano utensili complessi e utilizzavano strumenti musicali. Siamo dunque molto più simili ai Neanderthal, e filogeneticamente più vicini a loro rispetto a qualunque altro ominide conosciuto.
Nel 2010, inoltre, Pääbo e il suo team sottopongono all’analisi del DNA anche un minuscolo frammento di osso di un dito, ritrovato nella caverna di Denisova, presso i monti Altai, nella Siberia meridionale, al confine con Mongolia e Cina. Con immenso stupore, il team di ricercatori di Lipsia rileva che il frammento di falange sia appartenuto a una ragazzina di giovane età, vissuta oltre 40.000 anni fa, che non risulta essere né Neanderthal né sapiens, ma che appartiene a una famiglia umana arcaica precedentemente sconosciuta: i Denisova. Di questo gruppo umano non si sa nulla; per il momento non ci sono altri ritrovamenti, né fossili né archeologici, al punto che i Denisova sono spesso descritti come “un genoma in cerca di un’archeologia”. Ciò che sappiamo è che anche i Denisova, come i Neanderthal, si sono incrociati con gli umani moderni, e hanno lasciato tracce di DNA negli umani moderni provenienti dalla Melanesia: questi ultimi conservano nel loro genoma fino al 7% di contributo Denisova. Nella stessa caverna sui monti Altai sono stati trovati anche i resti di un’altra ragazzina vissuta 90.000 anni fa, le cui analisi genetiche sono state pubblicate nell’agosto 2018. “Denny”, com’è stata affettuosamente soprannominata dagli scienziati, aveva padre Denisova e madre Neanderthal, ed è il primo caso di cui si abbia conoscenza di un individuo “ibrido”, dimostrando così l’esistenza di incroci anche tra i due gruppi umani “arcaici”.
Che cosa significa essere umani? Come siamo arrivati a essere umani? Da Darwin in poi, pensavamo di avere le idee chiare. Un lungo processo evolutivo ci ha separato dalle scimmie antropomorfe, nostre antenate. Saremmo, per così dire, “discesi dagli alberi” e avremmo colonizzato il pianeta, diventandone la specie dominante, grazie ai nostri cervelli enormi, le nostre capacità tecniche, artistiche, cognitive e linguistiche assolutamente uniche nell’intero regno animale. Le recenti scoperte modificano e complicano incredibilmente questo scenario, ridisegnando l’albero genealogico del genus Homo in maniera radicale. Anzi, la paleoantropologia contemporanea ci ricorda che sarebbe più corretto parlare di “cespuglio”, alla luce dei complessi e interconnessi destini di tutti i gruppi umani, noti o ancora sconosciuti, che vagavano in ogni angolo del pianeta Terra solo 50.000 anni fa. La domanda sulle origini dell’uomo è ancora aperta insomma, e la risposta è ancora incompleta, ma tutt’altro che semplice.
Serena Palumbo
S&F_n. 20_2018