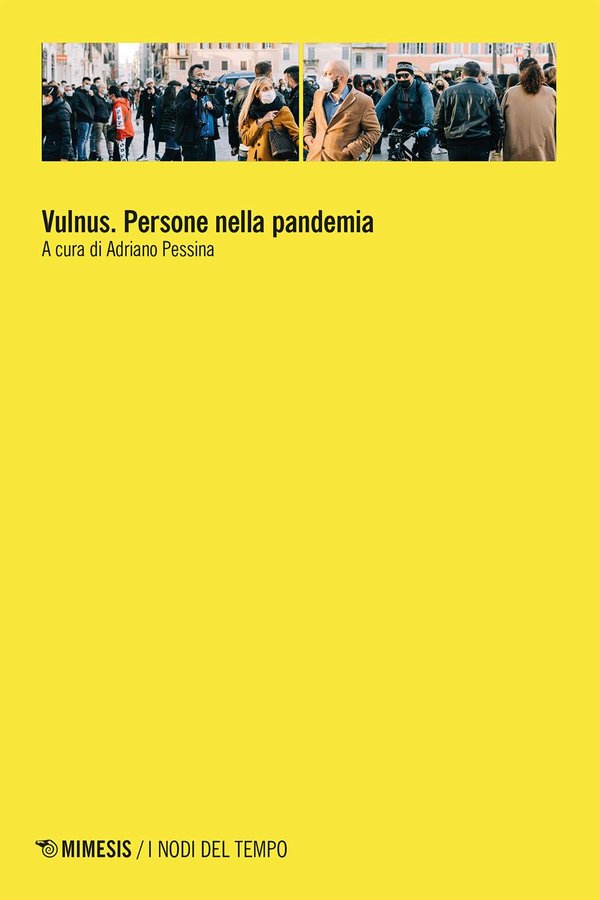Di fronte alla crisi – ambientale, sociale, bellica – a quale compito è chiamata la filosofia?
Il compito che le è probabilmente più proprio: ripensare, indagare, “curare” la dimensione individuale, i suoi turbamenti e trasformazioni, nel suo rapporto con quella collettiva e viceversa.
Questo vale in senso forse ancora più forte se pensiamo alla crisi pandemica che abbiamo appena attraversato – e che ancora sembra di là dall’essere superata. Nell’intreccio tra queste due dimensioni, quella dell’evento collettivo e del dramma che si consuma in una sfera più intima, è forse possibile ricercare e individuare, se non la “verità” di quanto è accaduto, almeno delle tracce e degli spunti per riflettere a 360° sul presente e sulle sue contraddizioni.
Il Covid-19 è stato (ed è) un trauma collettivo massivo (p. 59), dato il suo carattere complesso e proteiforme, sono molteplici le curvature che la riflessione su questo evento può assumere – riflessione sui dispositivi di controllo, sul rapporto tra individuo e comunità, sulla fragilità umana e sul nostro rapporto con il dolore, sulla “gestione” (pubblica e privata) dell’isolamento e della solitudine. Nel libro curato da Adriano Pessina, questa pluralità di spunti e di interpretazioni vengono messi in rilievo attraverso una serie di saggi che, sebbene mantengano il profilo dell’indagine sulla stretta attualità, travalicano la logica del testo d’occasione, offrendo riflessioni che, pur essendo legate all’oggi, lo superano, mostrando un più ampio respiro.
Urgenza e necessità di non fermarsi al fatto presente sono infatti ciò che deve necessariamente essere conciliato perché questi tempi non sfuggano, non fluiscano via impensati e dunque muti – incapaci di parlarci – o, per un movimento uguale e contrario, ci costringano a fissarci nel trauma, a non essere, a non pensare fuori dal suo perimetro, come se non esistesse un prima e un dopo: «per il filosofo di Jena tutto accade secondo un movimento cieco della storia e i grandi cambiamenti sono sempre un’opera notturna, difficilmente interpretabile nell’immediato. Rimane, perciò, come compito, il “dovere” di una ripar-azione terapeutica e virgola soprattutto, con l’aiuto della filosofia, medicina doloris dell’umano, di “comprendere” il lavorio carsico dello Spirito» (p. 75).
Il punto di partenza comune dei contributori sembra essere dunque quello della malattia che diviene potenzialmente, pur nella sua tragicità, occasione; come sostiene Virginia Woolf in Ammalarsi – testo ripreso da Papa nel suo saggio – «la malattia con i suoi simboli del dolore (…) è da sempre socialmente disturbante, anche perché veracem: espressione di verità» (p. 67). La crisi pandemica, come la radice greca stessa del termine suggerisce, non è solo momento complesso e drammatico, passaggio, spartiacque, ma anche occasione per il pensiero, per distinguere e separare, per fare chiarezza. Ci costringe a fare i conti con una mutata esperienza della morte e della solitudine. Mutata, ma non del tutto nuova.
La forza della riflessione su questo evento sta infatti, e in questo consiste la promessa mantenuta dal testo qui in discussione, nel tenere assieme il tema dell’eccezionalità/eccezione – ciò che è accaduto è da considerarsi fuori dal comune – e della continuità: la malattia, il modo, collettivo e individuale, che abbiamo di affrontarla, sono rivelatori del fatto che parte di ciò che abbiamo vissuto già è, già era, nel bene come nel male, in preparazione, presente in potenza; «ragionare sui tratti di continuità del tempo del Covid-19 con quello pre-pandemico significa prendere consapevolezza del fatto che il primo compito dell’etica della sovranità che stiamo cercando di delineare è quello di andare a vedere in che misura la nostra vita anteriore al virus, che abbiamo imparato a considerare come la nostra normalità, possa essere considerata effettivamente come normale (nel senso di buona)» (p. 49).
Anche il ritorno alla centralità del mero biologico (cfr. p. 60), del corpo, che può apparirci come ripresa del vecchio, della società disciplinare che, secondo la felice intuizione di Han più volte ripresa nel testo, sembrava essere stata surclassata una volta per tutte da società della prestazione, del controllo sull’auto-controllo – instillato dal dilagare del meccanismo della performance e dell’auto-realizzazione – si configura come una riproposizione non meccanica, ma anzi del tutto nuova di questi dispositivi, di un’ibridazione tra i due modelli.
Come i cittadini di Orano raccontati ne La Peste, gli uomini e le donne di quest’epoca hanno vissuto il quotidiano con un misto di insofferenza, rabbia, smarrimento, incredulità. Ma la solitudine forzata, cui sono, siamo, stati costretti dalle norme di contenimento del contagio non è e non deve essere necessariamente un male. Rispunta il tema dell’occasione, sia pure, forse, dell’occasione mancata: il tempo del dolore e del lutto può aprire lo spazio alla solidarietà e all’introspezione, alla valorizzazione dei legami comunitari.
La stessa solitudine, parola chiave, se si vogliono descrivere e comprendere questi ultimi due anni, se ripoliticizzata, nel senso più ampio e migliore del termine, può rovesciarsi in una risorsa salvifica e attivante. Se così intesa «la solitudine diventa un bene da conservare, così da sottrarre se stessi e la propria condizione allo sguardo di chi non può “cum-patire”, ma solo commentare. Nei giorni della pandemia (…) si è assistito alla narrazione di una solitudine di un isolamento segnati drammaticamente non dal pudore, ma dallo strazio di una forzata estraneazione delle relazioni parentali e amicali: l’isolamento, dettato dalle norme sanitarie, ha trasformato gli ospedali le case di cura in luoghi inospitali perché ha impedito ogni forma di contatto fisico con chiunque non fosse “addetto” alle concitate prassi di cure e assistenza» (p. 32). Questo isolamento, questo abbandono, è stato spesso materiale, e ancor più spesso anche psicologico ed esistenziale. Lo si è visto reparti di rianimazione affollati in cui si sono sperimentate la contiguità e la separazione assolute (ibid.), nella quasi totale assenza di riti di passaggio significativi e da vivere collettivamente per accompagnare la dipartita dei propri congiunti, nei discorsi inquietanti sulla gerarchia delle vite da salvare/abbandonare in assenza di risorse, sulle esistenze “utili” o “gravose” (o meglio di cui sgravarsi). Eppure, di fronte al consolidarsi di una cultura sempre più individualistica, la retorica della “responsabilità collettiva”, se non è semplice chiacchiera ma autentico richiamo a un noi (cfr. p. 34), può farci immaginare una “buona solitudine”: non isolamento, competizione, egoismo, ma ripiegamento finalizzato all’apertura, alla più stretta connessione con l’Altro; «c’è infatti una solitudine originaria, non sofferente, non disperata, non di cui non si fa mai memoria e di cui, invece, si sente la nostalgia. È la solitudine che appartiene all’esperienza dell’interiorità e che richiede di essere praticata in un certo isolamento» (p. 37) laddove «non può darsi alcuna forma di solitudine e di isolamento se non sullo sfondo di una socievolezza persa» (p. 30).
L’esperienza di questa solitudine, che è ricerca e sentimento della mancanza, avrebbe potuto mettere in evidenza una volta per tutte l’impraticabilità e l’infondatezza dell’idea di autonomia assoluta dell’individuo, del mito del “self made man”, dell’assoluta autosufficienza che mistifica l’origine della comunità: né gli individui, né le comunità si producono separatamente e autonomamente, la loro vitalità e possibilità di equilibrio e evoluzione è frutto della collaborazione e della cura reciproca.
Se la malattia difficilmente può essere interpretata come un dono (cfr. pp. 77 e sgg.), in questo caso, sarebbe almeno potuta essere rivelatrice di quel fondo comune dell’umano, di quella fragilità costitutiva, del vincolo che inevitabilmente ci lega; mettere in evidenza il fatto semplice, eppure troppo spesso cancellato e mistificato, su cui si fonda ogni gruppo, consesso umano: ovvero che la dipendenza non implica necessariamente una relazione gerarchica, uno stato di inferiorità, non comporta un giudizio morale o di valore. Non è e non deve essere considerata una condizione stigmatizzata e deviante. Che siamo tutti dipendenti, anzi interdipendenti. Che vulnerabilità e interdipendenza sono caratteri costitutivi dell’umano.
È riuscita la pandemia in questa demistificazione? A trasformare la nostra solitudine da passione triste a forza attivante?
Gli autori del volume non sembrano esserne del tutto convinti, e forse a ragione. Ma c’è ancora tempo, per riflettere e per cambiare, non disperiamo.
Viola Carofalo
S&F_n. 27_2022