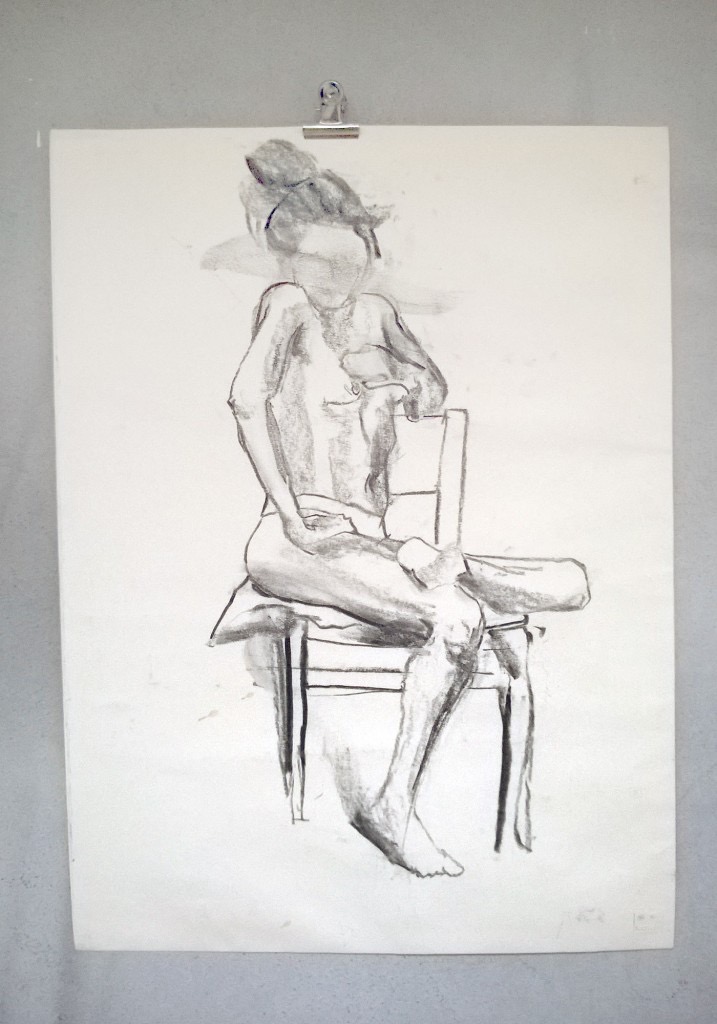Autore
Indice
- Ritorno alla cura?
- La battaglia per il riconoscimento è battaglia per la redistribuzione
- La cura come bene disponibile e risorsa illimitata
- Disconoscimento e naturalizzazione
- Rimozione dell’interdipendenza e perdita di esperienza
S&F_n. 23_2020
Abstract
Recognition, Care, impoverishment of the Experience. A Reflection from Nancy Fraser
Starting from Nancy Fraser’s reflection on Recognition and Redistribution, this article analyses the consequences of the separation between economic production and social reproduction on the path of the identity construction and the impoverishment of the Experience.
Il problema di sapere fino a che punto il traffico di merci
sia la forma dominante del ricambio organico di una società
non può essere semplicemente trattato (…) come una questione
quantitativa. (…) La differenza sussistente tra una società
nella quale la forma di merce è la forma dominante che
influisce in maniera decisiva su tutte le manifestazioni della
vita, ed una società nella quale essa si presenta soltanto in
modo episodico, ha un carattere qualitativo[1].
- Ritorno alla cura?
Il dibattito culturale e politico e le mobilitazioni in campo femminista degli ultimi anni, in particolare a partire dalla crisi economica del 2008, e, ancor più di recente, la discussione sviluppatasi attorno alla diffusione del Covid-19 e alle misure di contenimento del contagio[2], hanno riportato al centro del discorso pubblico il tema della cura. In particolare questo carico – dalla cura dei figli, alla gestione della vita domestica, all’assistenza a persone anziane e disabili – è riapparso sia, sul medio periodo, a causa della contrazione dello Stato sociale e dei servizi di supporto alle vite più “fragili”, che, in maniera più strettamente attuale e contingente (ma non è detto che questa contingenza non diventi una costante), in virtù delle misure emergenziali messe in campo nella fase di quarantena – per un verso la chiusura di nidi e scuole, riduzione o sospensione di alcuni servizi di assistenza, per l’altro la necessità di continuare a lavorare nei settori definiti di importanza strategica, strettamente connessi alla riproduzione della vita, anche a ritmi intensissimi e con il rischio di essere esposti al virus. Entrato in crisi il (precario) equilibrio tra famiglia e lavoro, tra salute e profitto, riemerge l’urgenza di una riflessione sull’intera organizzazione della riproduzione sociale[3] – l’insieme di riproduzione biologica, necessità collegate alla sopravvivenza e riproduzione della forza lavoro, carichi di cura e supporto dedicati ai soggetti non-autonomi.
Questo riapparire della sfera della riproduzione sociale, il suo ritornare al centro della scena, si è accompagnato, in maniera solo apparentemente contraddittoria, a un processo di invisibilizzazione: questo carico, lungi dall’essere riconosciuto, è stato oggetto di mistificazione, oscurato dalla retorica del sacrificio, del “compito naturale” della donna.
I piani della produzione e riproduzione sociale – grazie all’incrocio di espropriazione materiale e violenza simbolica – vengono dunque presentati come distinti, appartenenti a sfere separate e gerarchicamente collocate l’una rispetto all’altra. È proprio questa separazione a rendere possibile il disconoscimento della sfera della riproduzione sociale e, congiuntamente, dei soggetti, le donne, su cui essa, di fatto, grava. Per analizzare la genealogia di questa separazione, i suoi effetti – e le possibili strategie per il suo superamento – muoveremo dalla riflessione di una pensatrice contemporanea, Nancy Fraser, tra le più influenti nell’orientamento del dibattito attuale sul tema.
Fraser ha approfondito nei suoi scritti il rapporto tra riconoscimento e redistribuzione[4], in una prospettiva teorica e rivendicativa, qui proveremo a indagare gli effetti che questa separazione ha anche dal punto di vista dell’impoverimento dell’esperienza, per come cioè essa influisce nel processo di costruzione identitaria e di soggettivazione dell’individuo e sulla sua relazione con e intervento sul mondo. Si proverà dunque a stabilire non tanto quale sia l’equilibrio nel quale si trovano oggi queste due esigenze, di riconoscimento e redistribuzione, ma quali conseguenze abbia, nel percorso di soggettivazione, la loro separazione – la divaricazione tra piano individuale/collettivo, di classe/status, socioeconomico/identitario – e come questa comporti un impoverimento dell’esperienza e, di conseguenza, di capacità di intervento sul mondo
- La battaglia per il riconoscimento è battaglia per la redistribuzione
La categoria di riconoscimento, come reciprocità tra soggetti capaci di leggere l’altro come distinto da e uguale a sé, è alla base della riflessione di Fraser; la possibilità di essere riconosciuti nella propria autonomia e individualità e nel fondo comune che ci associa come viventi, rappresenta infatti per questa autrice un elemento fondamentale anche e soprattutto per individuare la base – morale e normativa – di ogni rivendicazione sul piano sociale e politico. La sfera della redistribuzione – e delle relazioni di produzione – non viene dunque concepita come distinta da quella del riconoscimento, deprivazione materiale e disconoscimento vanno di pari passo.
A partire dagli anni Novanta, sottolinea Fraser, il tema del riconoscimento/disconoscimento è stato declinato in un’ottica “culturalista” che finiva per depotenziarne la portata e alterarne il senso profondo[5]. Paradossalmente «lo spostamento dalla redistribuzione al riconoscimento è avvenuto proprio mentre» si inaspriva «la disuguaglianza economica (…). Invece di giungere a definire un paradigma più ampio e ricco, che abbracciasse redistribuzione e riconoscimento, abbiamo scambiato un paradigma monco con un altro, cioè un economicismo monco con un culturalismo monco»[6]. Il focus del dibattito diviene dunque, anche a partire dal crollo del blocco socialista, quello dell’identità e della rappresentanza, della decostruzione dell’opposizione categoriale binaria maschile/femminile e della “differenza sessuale”, lasciando sullo sfondo, se non accantonando totalmente, il piano dell’economia politica e della sua critica[7].
Fraser distingue questa, pur legittima e doverosa, richiesta di rinnovamento simbolico, dal riconoscimento autentico che, secondo l’autrice, non può che essere implicato col tema della redistribuzione, ovvero con l’individuazione del rapporto di interdipendenza tra sfera produttiva e riproduttiva. Le rivendicazioni legate al piano puramente identitario – a quelle che Fraser definisce politiche dell’identità – appaiono dunque come un ripiegamento su una battaglia che sembra più alla portata, come espressione di disinganno, addirittura di impotenza, non come affinamento di una sensibilità morale[8].
Rivisitare il genere significa ripensarlo come concetto bidimensionale[9] – Fraser parla a tal proposito di concezione larga[10]. Non basta procedere per sommatoria: «una piena comprensione diventa possibile solo quando le due lenti sono sovrapposte»[11], nessuna delle due spere è un effetto epifenomenico dell’altra[12], altrimenti si rischi, in un caso, di negare le risorse, nell’altro la possibilità di interazione e dialogo autentici, queste due forme di deprivazione e disconoscimento contribuiscono all’inferiorizzazione e alla totale appropriazione dell’Altro. Se per un verso gli «oltraggi» nei confronti dei subalterni – discriminazione, stereotipizzazione – «sono ingiustizie dovute al mancato riconoscimento. Sono relativamente indipendenti dall’economia politica e non sono meramente sovrastrutturali. Dunque non possono essere superate attraverso la sola redistribuzione»[13], per l’altro la prospettiva legata al mero riconoscimento è carente, finisce per trascurare altre linee di subordinazione (compresenti) e le loro reciproche connessioni (intergruppo e intragruppo), finisce per portare un intervento che può scadere divenendo puramente formale (che può degenerare in un, inefficace, politically correct), trascurando il fatto che la parità è primariamente una condizione qualitativa – in questo, ancora viva nella riflessione di Fraser sembra essere la lezione marxiana de La questione ebraica.
- La cura come bene disponibile e risorsa illimitata
Questo approccio bifocale non è dettato semplicemente dalla volontà di correggere gli errori di due tendenze di pensiero contrapposte, l’una puramente economicista e l’altra culturalista, ma dall’analisi concreta del modo di produzione attuale, delle sue trasformazioni, del rapporto con le risorse di cui dispone e della sua rappresentazione.
La sfera della riproduzione sociale diviene centrale in momenti di crisi e di emergenza proprio in quanto risorsa con la quale si istituisce un rapporto totalmente predatorio e di sfruttamento illimitato. Sempre e sempre più il modello produttivo trae linfa vitale da mondi che rappresenta come separati da sé, disgiunti dalla sfera dell’economico in quanto tale. Più che interrogarsi sulla sfera della produzione in senso stretto, Fraser sceglie dunque di indagare le sue condizioni di possibilità e, in particolare, quelle risorse non-economiche da cui essa dipende: le sacche di lavoro non remunerato (la sfera della riproduzione sociale che include il lavoro domestico), l’espropriazione di ricchezze ottenuta tramite meccanismi di razzizzazione, le ricchezze provenienti dalla natura non-umana, il drenaggio di beni e risorse pubbliche verso il privato. A tal proposito Fraser ci parla di un processo tripartito (3D), di divisione, dipendenza e disconoscimento, ovvero
- separazione «tra produzione e riproduzione, tra economia e politica e tra società umana e natura non umana»
- dipendenza tra la sfera dell’economico e le sue condizioni di possibilità[14]
- del meccanismo, infine, attraverso il quale questi reami non economici vengono disconosciuti; con essi, vengono privati di ogni possibilità di riconoscimento i soggetti che li animano e ne sono protagonisti – si pensi alle nuove forme di schiavitù, ma anche al rapporto che capitalismo estrattivo instaura con la Natura nell’Antropocene[15].
Abbiamo parlato, in tempi di crisi e di emergenza, di un ritorno alla cura (e alla sfera della riproduzione), di una nuova centralità di pratiche e beni che siamo abituati a concepire come “fuori mercato”. Dall’alto, questo ritorno si configura come sfruttamento (o approfondimento dello sfruttamento) di beni intesi come disponibili e non ancora (totalmente) messi a profitto, dal basso come proliferazione di pratiche che sembravano superate. Wallerstein descrive la semi-proletarizzazione dei nuclei familiari[16] che traggono le loro risorse e il loro sostentamento non solo dal salario ma da scambi informali, mutuo sostegno, supporti alla povertà erogati in varia forma dalle istituzioni statali: beni e pratiche che si trovano al di fuori dell’ambito del mercato. Ma questa esternità è reale? Il ritorno a queste pratiche in tempo di crisi porta a pensare a una regressione (in senso pre-capitalista), al riemergere di residui di società precedenti? Queste due domande apparentemente slegate, sono per Fraser, e nel nostro discorso, strettamente intrecciate. «La semi-proletarizzazione è stata ancora più pronunciata nel neoliberismo, che ha costruito un’intera strategia di accumulazione espellendo miliardi di persone dall’economia ufficiale verso zone grigie informali, dalle quali il capitale trasferisce valore»[17]; queste attività (o beni) non immediatamente mercatizzate, possono essere ri-funzionalizzate, investite e messe a valore[18]. Da questo “spostamento” del surplus (sociale) si definisce anche il rapporto tra sfera economica e politica, oltre che tra sfera della produzione e della riproduzione. Non vi è dunque esternità né regresso: le questioni capitali, inerenti la vita, sono da sempre poste al centro di questo gioco di forze, sono anzi, potremmo dire, portando agli estremi la riflessione di Fraser, ne costituiscono la posta in gioco.
Il disconoscimento del valore di queste risorse non passa soltanto, sul piano economico, per la loro appropriazione, per il loro utilizzo totalmente (o semi) gratuito e senza misura[19], ma anche per la naturalizzazione e invisibilizzazione di questo sfruttamento, per la rimozione, attraverso la rappresentazione di sfera produttiva e riproduttiva come separate, della loro interdipendenza. Questo processo, proprio come il disconoscimento di una sfera rispetto all’altra, non ha solo una matrice economica – la produzione dipende dalla riproduzione –, ma si configura come sconfinamento continuo tra le due sfere e cancellazione del confine tra beni di mercato (o mercatizzabili) e beni simbolici.
Mentre molte pensatrici femministe – in primis ecofemministe, come Vandana Shiva – teorizzano l’esternità della riproduzione sociale al modo di produzione o la interpretano come semplice riproduzione della forza lavoro, per Fraser invece questa scorporazione si configura come impossibile e la sua rappresentazione come inquietante, pericolosa; «la riproduzione sociale» non può e non deve essere letta come ambito esterno rispetto a quello della produzione in quanto «comprende la creazione, la socializzazione e la soggettivizzazione degli esseri umani più in generale, in tutti i loro aspetti. Include anche la realizzazione e il rifacimento della cultura, delle varie aree dell’intersoggettività in cui gli esseri umani sono inseriti – la solidarietà, i significati sociali e gli orizzonti di valore nei quali e attraverso i quali vivono e respirano»[20]. Piuttosto che idealizzare un presunto esterno – come spazio di fuga o addirittura soluzione alle contraddizioni e agli squilibri dell’attuale sistema sociale, e come luogo di un riconoscimento possibile – sembra dunque necessario ricomporre ciò che è stato separato, materialmente e simbolicamente.
- Disconoscimento e naturalizzazione
Lo snodo di questa ricomposizione si situa, ancora una volta, all’incrocio tra redistribuzione e riconoscimento, e passa per l’uscita dalle forme di appropriazione integrale dei soggetti altri (del femminile, dei gruppi razzizzati, della Natura) e della rappresentazione di questa appropriazione come parte di una disposizione naturale.
Nella concezione espansa (della riproduzione e, soprattutto, del modo di produzione come totalità sociale storicamente elaborata) del modello socioeconomico proposta da Fraser non può non porsi il tema della naturalizzazione o, per meglio dire, della necessità della de-naturalizzazione, così centrale nella riflessione del femminismo materialista. Non è un caso che il ritorno al dibattito su lavoro di cura e riproduzione sociale in tempi di crisi abbia fatto riemergere le riflessioni, rimaste in ombra negli ultimi venti-trent’anni, di quelle pensatrici che, secondo traiettorie differenti, si sono interrogate sull’articolazione tra simbolico e materiale e sui dispositivi di naturalizzazione dell’oppressione[21], sul doppio livello di assoggettamento – individuale e collettivo – del femminile che passa per l’uso e l’appropriazione (del lavoro) delle donne e per il suo disconoscimento.
Le categorie sessuali – e i compiti loro associati – vengono comunemente rappresentati, in maniera più o meno esplicita, come fondati su un dato biologico, su una disposizione naturale, o anche, come nel rapporto tra razzismo biologico e razzismo culturale, su abitudini così radicate da farsi inestirpabili, come una seconda natura[22]. L’idea di naturalità dei gruppi e delle classi si fonda così su due pilastri quello della spontaneità e dell’astoricità della relazione che lega dominati e dominati. Questa naturalizzazione delle tassonomie e del dominio accompagna e legittima la separazione tra sfera produttiva e della riproduzione, mascherando la dipendenza dell’una dall’altra, «questa appropriazione del lavoro svolto dalle donne si compie nello stesso modo in cui avviene l’appropriazione del lavoro svolto dalla classe operaia da parte della classe dominante. Non può essere detto che una di queste due forme di produzione (ossia, la riproduzione) è “naturale”, mentre l’altra è “sociale”»[23]. Considerato come un dono[24] – che in quanto tale non può essere misurato in termini di mercato e per il quale non deve essere corrisposta alcuna contropartita – il cosiddetto “lavoro dell’amore” viene appropriato in blocco, non conosce prezzo né limite di vendita[25]. Questa transazione unilaterale e violenta si fonda sull’idea che a essere comparate sono due forme di esistenza di carattere differente, sociale e naturale, e non due forme del sociale.
«Il genere precede il sesso; in questa ipotesi, il sesso è semplicemente un marchio della divisione sociale che serve a riconoscere e identificare i dominanti dai dominati»[26]; gli insiemi sessualmente circoscritti e associati, nella forma di un’inclinazione naturale, a precise mansioni, sono prodotti di relazioni e rapporti di forza in cui un gruppo si appropria (o cerca di appropriarsi) sia della capacità produttiva e riproduttiva dell’altro che dei soggetti espropriati nella loro interezza – non solo nelle loro funzioni, del corpo, ma del loro universo simbolico e della loro capacità immaginativa. L’appropriazione non si estrinseca dunque solo, nel rapporto che Guillaumin definisce di sessaggio, nella rapina del tempo, dei prodotti del corpo, nell’obbligo sessuale e nella cura delle persone non-autosufficienti (e degli individui autosufficienti di sesso maschile)[27], ma in un più ampio processo di inferiorizzazione e di reificazione dell’altro nella sua totalità. Questa appropriazione totale, la riduzione allo stato di strumento delle donne, in una forma di produzione che, intesa in modo ampliato, è forma di vita la cui grammatica è basata sulla forma della merce[28], non ha solo carattere quantitativo, ma qualitativo. Se tutto il tempo, l’interezza del corpo sono appropriati, se l’intero universo simbolico è deformato dall’idea che la propria dominazione sia frutto di una disposizione naturale (e dunque eterna e immutabile[29]), allora, nella separazione dalla produzione, il lavoro di cura, desocializzato e svalorizzato, «depriva di sé chi lo svolge»[30].
Si produce così una forma di estraniazione, di alienazione che si pone al confine tra i due sensi che comunemente attribuiamo a questo termine: alienazione in senso etico come separazione, scissione interna, perdita di senso, incapacità di formulare qualsivoglia domanda sulla buona vita[31] e, in senso socioeconomico, come espropriazione materiale e simbolica della propria attività sul mondo, che diviene al contempo estranea e inefficace.
- Rimozione dell’interdipendenza e perdita di esperienza
Un esito meno esplorato di questa separazione tra sfera della produzione e della riproduzione sociale è dunque l’effetto di deprivazione di sé che essa produce. Il tentativo di uscire dalla trappola della naturalizzazione, di superare il “mito della donna” muove proprio da questa necessità di riconoscimento, di diventare soggetti[32]. Se Fraser insiste sulla necessità di ricongiungere la sfera della produzione da quella della riproduzione sociale, la rivendicazione legata a pratiche redistributive alla politica dell’identità, è perché sa che questa divisione, addirittura in alcuni casi contrapposizione teorica e rivendicativa, rischia di compromettere il soggetto stesso, di farlo appassire nell’impotenza, di abituarlo a convivere con l’impossibilità del cambiamento. Ciò che infatti rischia di perdersi in questa separazione è l’idea stessa di modificabilità del mondo e dei suoi equilibri, di possibilità dell’azione trasformativa.
Il rischio di questa impossibilità si concentra essenzialmente attorno a due dinamiche: quella della rimozione dell’interdipendenza e quella della perdita di esperienza.
Nel ricostruire, assieme a Linda Gordon, una genealogia del concetto di dipendenza[33], Fraser mostra come – in un contesto sociale, culturale e produttivo fondato su flessibilità e responsabilità personale, in cui la dipendenza dagli altri corrisponde a un destino di esclusione e inferiorità “morale” – la svalorizzazione del lavoro di cura sia parte integrante di un meccanismo di mistificazione e nascondimento della fragilità e del reciproco bisogno come fondo comune dell’umano. L’equazione tra dipendenza e subordinazione non riguarda solo chi è beneficiario del supporto, ma anche e soprattutto chi è deputato al lavoro di cura: entrambi i soggetti appaiono naturalmente inchiodati alla schiavitù del corpo (dove lampante è l’associazione corporeità/femminile) e dei suoi bisogni.
La traccia di fondo seguita in questa genealogia è quella delineata dal lavoro di Macpherson e dalla sua teoria dell’individualismo possessivo[34]. Nella riflessione di Macpherson l’individuo della prima società industriale – ovvero nell’Inghilterra del Seicento – è considerato libero e degno nella misura in cui è proprietario delle proprie capacità, la qualità che lo rende pienamente degno consiste dunque nella sua capacità di non dipendere dalla volontà altrui[35]. La società, in quest’ottica, consiste in nient’altro che in relazioni di scambio tra proprietari e ciò che rende umano l’individuo, all’alba della società industriale, è in primo luogo l’essere libero dalla dipendenza – e dunque anche eventualmente da qualsiasi relazione con l’altro che non sia volontariamente scelta in prospettiva del proprio interesse –, «essenzialmente proprietario della propria persona e delle proprie capacità, (…) [l’individuo] non deve niente alla società»[36]. Pur essendo radicalmente cambiati i rapporti di lavoro a partire dai quali muoveva la riflessione di Macpherson, il processo di precarizzazione e di femminilizzazione della produzione e la crisi dello stato assistenziale[37] contribuiscono a far sì che il discorso sulla dipendenza continui a essere collocato all’interno di una cornice discorsiva che naturalizza questo modello comunitario – che si presenta come volgarizzazione di quello hobbesiano, come società degli individui – proponendone l’ineluttabilità come verità autoevidente. Ciò che scompare o viene falsificato in questa rappresentazione è l’inevitabilità della dipendenza – o sarebbe meglio dire dell’interdipendenza –, l’universalità della fragilità, la necessità della mutua assistenza: l’unità di produzione e riproduzione sociale. Il piano socio-politico del bisogno e del diritto alla cura – che si rafforza nell’emersione del processo di divisione del lavoro e della complementarità delle competenze e, concretamente, nell’assistenza nelle condizioni permanenti o transitorie di fragilità (malattia, povertà, infanzia, vecchiaia, disabilità, etc.) – e quello etico, del riconoscimento, si implicano reciprocamente.
Il disconoscimento della sfera della riproduzione sociale determina dunque a forme di destabilizzazione radicali e di blocco dell’esperienza: la cancellazione della (inevitabile) interdipendenza tra i soggetti e tra le sfere e la rimozione degli elementi fragili dal campo in luce della vita, portano a una concezione di ogni dipendenza come condizione anomala e patologica. Totalmente subordinata a una logica della produttività che la sfrutta e la rimuove, la sfera della riproduzione rivela nei suoi cortocircuiti gli effetti di questa destabilizzazione. Fraser legge nelle immagini, potenti quanto quotidiane, di donne che scelgono di congelare i propri ovuli per potersi dedicare alla carriera, che usano il tiralatte in macchina mentre corrono a lavoro[38], non la libertà di poter gestire il corpo e le sue funzioni (in questo caso la maternità) in piena liberà, sciolte da vincoli morali e di ruolo, ma la totale cancellazione di questa libertà, della possibilità di agire. Senza nessuna nostalgia per il passato, né fascinazione per quelle correnti di pensiero che vedono nel corporeo la salvezza da un meccanismo produttivo che stritola e disumanizza l’individuo, Fraser interpreta questi comportamenti come sintomi del disconoscimento proprio di quelle relazioni di dipendenza che il modo di produzione capitalistico istituzionalizza.
Questo disconoscimento produce quello che Fraser e Jaeggi definiscono blocco dell’apprendimento, o ancora blocco dell’esperienza, ovvero la difficoltà a elaborare, mettere a frutto e, potremmo aggiungere, riconoscersi nella propria esperienza di vita, in quanto questo congelamento rende «inaccessibile un’intera gamma di esperienze sociali»[39]. L’inabilità a apprendere e elaborare l’esperienza non ha a che fare soltanto, sul piano individuale, con l’impossibilità del soggetto di riconoscersi, ma gioca anche su un piano sociale, collettivo, riguarda «le capacità di una forma di vita di dare un senso alle contraddizioni poste dalle sue stesse pratiche sociali e di trasformarsi conseguentemente»[40], è per un verso un blocco della capacità di adattarsi – e dunque di sopravvivere agli interventi predatori che espropriano e distruggono la sfera della riproduzione e, in senso ancora più ampio, la vita, come nella catastrofe ecologica – per l’altro, ed è forse questo l’aspetto più rilevante, è un blocco della possibilità di concepire il mondo come trasformabile, ovvero di intendere la propria azione su di esso come efficace. Si tratta di una impasse, più o meno duratura, simile a quelle sterilità, tipica del contemporaneo, di cui ha parlato Fisher: l’esaurimento del futuro, la sensazione profonda e diffusa che nessun cambiamento sia possibile, o anche soltanto pensabile[41].
Queste due forme di blocco hanno una radice comune, la naturalizzazione della sfera della riproduzione, la sua svalorizzazione e separazione da quella della produzione rappresentano mondo e soggetto come immobili, come materia inerte e l’azione dell’individuo, persa ogni capacità di elaborare il proprio vissuto e il proprio tempo, come del tutto vana. Questa disconoscimento ha un effetto mortifero, priva gli individui che ne sono investiti, sia sul piano individuale che su quello collettivo[42], della capacità di elaborare l’esperienza, «interrompendo i processi di apprendimento, ostacola la nostra capacità di trovare soluzioni adeguate a determinati tipi di crisi, perché estromette le risorse di cui abbiamo bisogno per sperimentare la nostra situazione in un modo sufficientemente intenso da cogliere pienamente i problemi da affrontare»[43]. Se ci è impedito di imparare, e dunque di trasformare, allora l’unico destino possibile sembra essere quello della ripetizione.
Questa particolare relazione di separazione-dipendenza-disconoscimento in quanto «fonte strutturale di potenziale instabilità»[44] e l’approfondimento di una crisi – che gioca al contempo sul piano economico, politico, ambientale, del riconoscimento –, ci mette di fronte alla contradizione intrinseca di un modo di produzione che erode i propri presupposti di sopravvivenza[45]. Di fronte a questo baratro, la crisi si presenta però anche sotto la veste dell’occasione: le attuali modalità e i dispositivi di sfruttamento e di dominio, Fraser non manca di sottolinearlo, non sono semplicemente sovrapponibili, integrati, funzionali, ma occupano posizioni spesso contraddittorie – favoriscono l’accumulazione, ma anche la creazione di punti di rottura. Lungo queste faglie è possibile trovare lo spazio per ripensare la trasformazione, per porre rimedio all’auto-dislocazione interna[46] vissuta dai soggetti non riconosciuti, forse proprio a partire dall’uscita da un’organizzazione dualistica della riproduzione sociale, da un mondo della cura che la vuole mercificata e/o privatizzata[47], e dal riconoscimento della sua centralità e continuità con la sfera della produzione.
[1] G. Lukács, Storia e coscienza di classe (1923), tr. it. SugarCo, Milano 1978, p. 109.
[2] Si veda, ad esempio, il Cross-Border Feminist Manifesto: https://spectrejournal.com/cross-border-feminist-manifesto/
[3] Cfr. N. Fraser, La fine della cura (2016), tr. it. Mimesis, Milano 2017, p. 9 e Id., Capitalismo. Una conversazione con Rahel Jaeggi (2018), tr. it. Meltemi, Roma 2019, p. 16.
[4] Cfr. N. Fraser, La politica femminista nell’era del riconoscimento. Un approccio bidimensionale alla giustizia di genere (2001), tr. it. in Fortune del femminismo (2013), Ombre corte, Verona 2014, p. 188. Su questa curvatura della teoria e della pratica femminista si vedano anche Id., Dalla redistribuzione al riconoscimento? Dilemmi di giustizia nella condizione “postsocialista”, in La giustizia incompiuta. Sentieri del post-socialismo, tr. it. Pensa Multimedia, Lecce 2011, pp. 31 e sgg.; N. Fraser et al., Il danno e la beffa. Un dibattito su ridistribuzione, riconoscimento, partecipazione (1995-2007), (a cura di K. Olson), tr. it. Pensa Multimedia, Lecce 2012, cfr. in particolare sez. I e II; N. Fraser, A. Honnet, Redistribuzione o riconoscimento? Una controversia politico-filosofica (2003), tr. it. Meltemi, Roma 2020, cfr. in particolare pp. 13 e sgg.; C. Arruzza, T. Bhattacharya, N. Fraser, Femminismo per il 99% (2019), tr. it. Laterza, Bari-Roma 2019, Tesi I, II e V; N. Fraser, Capitalismo. Una conversazione con Rahel Jaeggi (2018), tr. it. Meltemi, Roma 2019, pp. 245 e sgg.
[5] «Negli anni Novanta (…) la nuova sinistra era solo un ricordo, e il marxismo sembrava a molti lettera morta (…). Seguendo il più ampio esodo intellettuale dal marxismo, la maggior parte delle teoriche femministe imboccò la “svolta culturale”. (…) Oggi, di conseguenza, la teoria di genere è per gran parte una branca degli studi culturali. (…) Come sempre, le vicissitudini della teoria seguono quelle della politica (…). Se la generazione del Sessantotto sperava, tra le altre cose, di ristrutturare l’economia politica così da abolire la divisione di genere del lavoro, le femministe della generazione successiva (…) cercavano il riconoscimento della differenza sessuale, mentre altre preferivano decostruire l’opposizione categoriale tra maschile e femminile. il risultato è stato uno spostamento del centro di gravità della politica femminista (…) sull’identità e la rappresentanza», N. Fraser, La politica femminista nell’era del riconoscimento, cit., pp. 188-189; si vedano anche Id., Social Justice in the age of identity politics, in G.B. Peterson (a cura di), The Tanner lectures on human values, University of Utha Press, Salt Lake City 1998, vol. 19, pp. 20 e sgg. e Id., Justice Interruptus: Critical Reflections on the “Postsocialist” Condition, Routledge, London-New York 1997.
[6] Ibid., p. 189. È necessario sottolineare che Honnet, interlocutore privilegiato di Fraser, assieme a Anderson, Butler e Rorty (cfr. Il danno e la beffa. Un dibattito su ridistribuzione, riconoscimento, partecipazione, cit.), non concorda su questa scansione temporale, né sul prevalere del tema culturalista/del riconoscimento, cfr. A. Honnet, La libertà negli altri (200-2015), tr. it, Il Mulino, Bologna 2017, pp. 101 e sgg.; Id., Reificazione. Sulla teoria del riconoscimento (2015), tr. it. Meltemi, Roma 2019, pp. 43 e sgg.; N. Fraser, A. Honnet, Redistribuzione o riconoscimento?, cit., in particolare pp. 129 e sgg.
[7] Cfr. la critica alla teoria dell’agire comunicativo di Habermas, in N. Fraser, Capitalismo, cit., pp. 18 e sgg.)
[8] Cfr. A. Honnet, La libertà negli altri. Saggi di filosofia sociale, cit., p. 102. Il tema del riconoscimento, disgiunto dalle rivendicazioni redistributive, può trovare spazio – sia pur in forma adulterata – in politiche iper-reazionarie, l’intreccio dei due piani, oltre che corretto dal punto di vista teorico, costituisce per Fraser anche un argine a questa possibile deriva, cfr. N. Fraser, Il vecchio muore e il nuovo non può nascere. Dal neoliberismo progressista a Trump e oltre (2019), tr. it. Ombre Corte, Verona 2019, pp. 24 e sgg.
[9] Cfr. N. Fraser, La politica femminista nell’era del riconoscimento, cit., p. 191; Id., La dilatazione distorta del riconoscimento: replica ad Axel Honnet, in N. Fraser, A. Honnet, Redistribuzione o riconoscimento?, cit., p. 215.
[10] La necessità di questa integrazione, pur con esiti parzialmente differenti, è individuata anche da J. Butler in Meramente culturali, tr. it. in Il danno e la beffa, cit., pp. 61 e sgg.; il volume, che contiene anche la risposta di Fraser a Butler, Eterosessismo, mancato riconoscimento e capitalismo. Una risposta a Judith Butler (pp. 75 e sgg.), ricostruisce la discussione su redistribuzione, partecipazione e riconoscimento animata da Fraser dal 1995 al 2007 sulla “New Left Review”.
[11] N. Fraser, La politica femminista nell’era del riconoscimento, cit., p. 191.
[12] Cfr. ibid., pp. 194-195.
[13] Ibid., p. 192.
[14] Id., Capitalismo, cit., p. 230; cfr. anche Id., Cosa vuol dire socialismo nel XXI secolo? (2020), tr. it. Castelvecchi, Roma 2020, pp. 6 e sgg.
[15] Cfr. C. Arruzza, T. Bhattacharya, N. Fraser, op. cit., Tesi IX.
[16] Cfr. I. Wallerstein, Capitalismo storico e civiltà capitalistica (1996), tr. it. Asterios, Trieste 2000.
[17] N. Fraser, Capitalismo, cit., p. 143.
[18] Questa visione non deve però essere totalizzante, restano sempre zone d’ombra, interstizi «grandi aree di interazione sociale (…) che non sono regolate dalle norme di mercato» zone non mercificate che «operano secondo una logica diversa». Su queste faglie si sviluppano quelle che Fraser chiama lotte di confine, cfr. Capitalismo, cit., pp. 83-84.
[19] Cfr. C. Guillaumin, Sesso, razza e pratica di potere. L’idea di natura (2016), tr. it. Ombre Corte, Verona 2020, p. 48.
[20] N. Fraser, op. cit., p. 59.
[21] Questo ritorno, nel contesto italiano, è senz’altro dovuto anche alla recente traduzione degli scritti di autrici seminali per questa riflessione come Monique Wittig (Il pensiero eterosessuale, Ombre corte, Verona 2019) a cura di Federico Zappino e Colette Guillaumin (Sesso, razza e pratica di potere, cit.) a cura di Vincenza Perilli, Sara Garbagnoli e Valeria Ribeiro Corossacz; a Garbagnoli e Perilli si deve anche la pubblicazione del prezioso: Non si nasce donna. Percorsi testi e contesti del femminismo materialista in Francia (Alegre, Roma 2013), che offre una panoramica complessiva di questa corrente e contiene anche scritti di Paola Tabet e Nicole-Claude Mathieu e della pensatrice che per prima ha coniato l’espressione “femminismo materialista”, Christine Delphy.
[22] Cfr. E. Balibar, Esiste un “neorazzismo”?, in E. Balibar, I. Wallerstein, Razza, nazione, classe. Le identità ambigue (1988), tr. it. Ed. Associate, Roma 1990, pp. 29 sgg.
[23] M. Wittig, Il pensiero eterosessuale, cit., p. 26.
[24] N. Fraser, Capitalismo, cit., p. 230.
[25] Cfr. C. Guillaumin, op. cit., p. 55.
[26] C. Delphy, Penser le genre: problemes et resistances (2001), tr. it. in S. Garbagnoli, V. Perilli (a cura di), Non si nasce donna, cit., p. 38.
[27] Cfr. C. Guillaumin, op. cit., p. 43.
[28] Cfr. N. Fraser, Capitalismo, cit.
[29] «L’idea che i sessi siano perenni e l’idea che perenne sarebbe anche il rapporto tra schiavi e padroni derivano dalla stessa convinzione (…). Maschile/femminile e maschio/femmina sono le categorie funzionali a celare il fatto che le differenze sociali dipendono sempre da un ordine economico, politico e ideologico», M. Wittig, La categoria di sesso (1976-1982), Il pensiero eterosessuale, cit., p. 22.
[30] M. Wittig, Introduzione (1991), in Il pensiero eterosessuale, cit., p. 16; si veda anche N. Fraser, Rethinking Recognition: overcoming displacement and reification in cultural politics, in «New Left Review», 3, 2000, pp. 107 e sgg.
[31] Cfr. R. Jaeggi, Alienazione. Attualità di un problema filosofico e sociale (2005), tr. it. Castelvecchi, Roma 2017, pp. 31 e ss; si veda anche A. Honnet, Patologie del sociale, in «Iride. Filosofia e discussione pubblica», 18, 2003, pp. 295 e sgg.
[32] M. Wittig, Non si nasce donna (1981), in Il pensiero eterosessuale, cit., p. 39.
[33] N. Fraser, L. Gordon, Una genealogia della “dipendenza”. Il percorso di una parola chiave del welfare state americano (1994), in Fortune del femminismo, cit., p. 113.
[34] C.B. Macpherson, Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese: la teoria dell'individualismo possessivo da Hobbes a Locke (1962), tr. it. Mondadori, Milano 1982.
[35] «La prima icona della dipendenza industriale era il povero, il quale non viveva di salario ma dell’aiuto ricevuto», N. Fraser, L. Gordon, Una genealogia della “dipendenza”, cit., p. 113.
[36] C.B. Macpherson, op. cit., p. 297. «Poiché la libertà dalla volontà altrui è ciò che rende umano l’uomo, la libertà di ogni individuo può essere legittimamente limitata solo da obblighi e norme necessari a garantire agli altri la sua stessa libertà», ibid., p. 298, cfr. N. Fraser, Capitalismo, cit., p. 45.
[37] Cfr. C. Arruzza, T. Bhattacharya, N. Fraser, op. cit.
[38] Cfr. N. Fraser, Capitalismo, cit., p. 237.
[39] ibid.
[40] Ibid., p. 238.
[41] M. Fisher, Realismo capitalista (2009), tr. it. Nero, Roma 2018, p. 25 e sgg.
[42] Cfr. M. Wittig, Non si nasce donna, cit., p. 39.
[43] N. Fraser, Capitalismo, cit., pp. 235-236 (R. Jaeggi), su questo tema si veda anche R. Jaeggi, Critique of Forms of Life (2014), Harvard University Press, Cambridge-London 2018.
[44] Cfr. N Fraser, La fine della cura, cit., p. 18.
[45] Id., Cosa vuol dire socialismo nel XXI secolo?, cit., p. 31.
[46] Id., La politica femminista nell’era del riconoscimento, cit., p. 198.
[47] Id., Capitalismo, cit., p. 251.